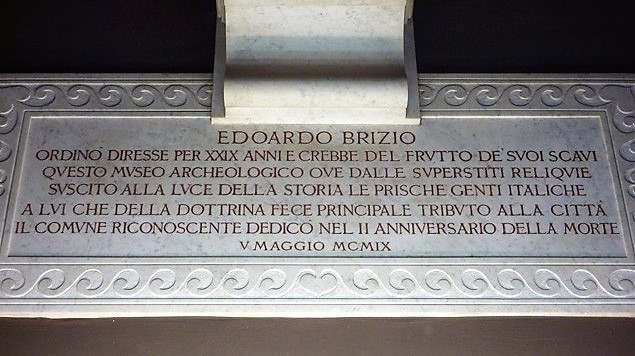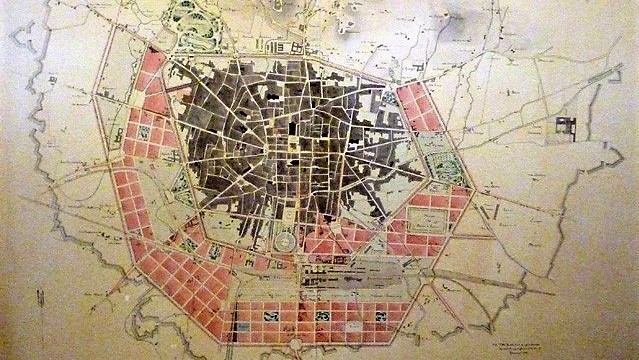Cronologia di Bologna dal 1796 a oggi
Archivio di notizie sulla storia della città e del suo territorio dal 1796 ad oggi. Con riferimenti bibliografici, link, immagini.
-
19 agosto 1888Le funicolari Ferretti per San Michele in Bosco e San LucaL’ingegnere Alessandro Ferretti, uno dei maggiori esperti in Italia di trasporti via cavo - laureato in ingegneria meccanica presso l’Università di Bologna - realizza una funicolare a doppio binario, che collega i giardini Margherita alla collina di San Michele in Bosco, dove è ospitata l’Esposizione Nazionale di Belle Arti. Una macchina a vapore a 12 cavalli trascina in circa tre minuti, fino alla spianata del colle, due vetture della portata di 30 persone. La Villa Reale è raggiungibile anche con un tram a vapore, un “vaporino ansante e sbuffante”, che sale a villa Revedin tramite una via ferrata di circa un chilometro. Sul piazzale superiore di San Michele, “fantasticamente illuminato fino a mezzanotte”, si gode “una delle più belle viste del mondo” e si respira “un’aria fresca e salubre”. È possibile fare colazione nel magnifico Chalet della Funicolare, fermarsi ad ascoltare uno dei tanti concerti o uno dei “serali trattenimenti di prestidigitazione” e di “ipnotismo umoristico", che allietano gli ospiti del ristorante, visitare l’Esposizione e la Villa Reale e poi scendere di nuovo col vaporino ai giardini Margherita. Dopo le 6 del pomeriggio il costo del biglietto della funicolare è di soli 15 centesimi a corsa. Il 19 agosto 1888 entra in funzione anche il primo tronco della funicolare per San Luca: dal Meloncello al forte Costantini, all’altezza del dodicesimo mistero. Per l’occasione Alfredo Testoni pubblica su “Ehi! ch’al scusa” una canzonetta dialettale dal titolo Funiculì Funiculà. I risultati del servizio saranno però deludenti e l’impianto sarà smantellato nel luglio del 1889. L’idea verrà ripresa nel 1928 dal podestà Leandro Arpinati e realizzata nel 1931 con la funivia.dettagli
-
14 gennaio 1912Nasce il Consorzio fra le Cooperative Birocciai, Carrettieri e AffiniOtto cooperative della provincia, con circa 400 soci - tra esse l’Inghiaiatori di Bologna e le cooperative birocciai di vari comuni della provincia - fondano il Consorzio fra le cooperative Birocciai, Carrettieri e Affini. Il primo presidente, eletto in segreto, è Ildebrando Coliva della Birocciai di Trebbo di Reno. E’ il nucleo originario di quello che sarà il futuro Consorzio Cooperative Costruzioni. Fino al 1920 il Consorzio sarà diretto dall'ing. Attilio Evangelisti e arriverà allora a contare circa venti cooperative e 1.500 soci. Provvedendo alla fornitura della ghiaia per quasi tutta la rete stradale provinciale e comunale, sarà definito "il grande benemerito della viabilità delle strade della provincia". Nel 1927 Umberto Poluzzi, uomo di fiducia del Podestà Leandro Arpinati (1892-1945) e segretario del sindacato fascista dei fornaciai, diventerà presidente del Consorzio (denominato CCC dal 1923). Sotto l’egida fascista, sostenuto da Bruno Biagi (1889-1947), presidente dell'Agenzia nazionale per la cooperazione, raggiungerà un notevole volume d’affari e realizzerà alcune importanti opere pubbliche - il sacrario dei caduti fascisti, il liceo scientifico Righi - e infrastrutture quali la Direttissima Bologna-Firenze e le bonifiche dei fiumi Idice e Reno.dettagli
-
5 ottobre 1914Conferenza interventista di Libero Tancredi e Maria RygierL'anarchico interventista Massimo Rocca (1884-1973) - noto con lo pseudonimo di Libero Tancredi - e la rivoluzionaria Maria Rygier (1885-1953) parlano nella sede della Società Operaia. La conferenza dal titolo La morale di una guerra suscita l'opposizione dei socialisti bolognesi, che contestano con urla e lanci di seggiole. Tra i manifestanti finiti ammaccati all'ospedale c'è anche il giovane Vittorio Neri, nome di copertura Leandro Arpinati (1892-1945), un ex anarchico di Civitella di Romagna, divenuto “Interventista intemerato”. Pochi giorni prima Libero Tancredi ha indirizzato, dalle colonne del "Resto del Carlino", una lettera aperta al direttore dell' "Avanti!" Benito Mussolini (1883-1945) - definito "l' unica persona capace di avere un'opinione" tra i "piccoli uomini" della dirigenza socialista - invitandolo ad imporsi o dimettersi. Ufficialmente neutralista, Mussolini è ormai da tempo "interventista a quattr'occhi". La propaganda a favore della "guerra di liberazione" di Maria Rygier, un tempo su posizioni rivoluzionarie e antimilitariste, suscita un'aspra polemica con il movimento anarchico. Fino al 1923 l'ex redattrice del giornale "Lotta di classe" si manterrà vicina ai nazionalisti. Nel 1926 emigrerà in Francia, da dove lancerà duri attacchi a Mussolini e al regime fascista. Entrerà quindi in polemica con gli antifascisti fuoriusciti e negli ultimi anni della sua vita avrà posizioni filo-monarchiche.dettagli
-
luglio 1918L'Unione Nazionale del LavoroSi costituisce la sezione bolognese dell'Unione italiana del Lavoro, diretta da Ettore Cuzzani e Adelmo Pedrini. Si pone in concorrenza con la Camera Confederale e con la Vecchia Camera del Lavoro anarchica. Si tratta di un tentativo della massoneria di penetrare nel mondo sindacale (Onofri). L'U.i.L. svolgerà una attività modesta, caratterizzata soprattutto da numerosi articoli di Cuzzani sul "Giornale del Mattino" contro gli altri sindacati. Ettore Cuzzani (1882-1932) è un ex sindacalista anarchico passato con Alceste De Ambris al fronte interventista. Con l'avvento del fascismo si rifugerà in Francia dove sarà tra i protagonisti della Concentrazione antifascista. Morirà in esilio a Tolosa. Verrà ricordato dalla stampa d'opposizione come "militant antifasciste et socialiste d'une vaillance et d'une activité inlassable". Adelmo Pedrini (1888-1954) sarà tra i fondatori del primo fascio bolognese, dal quale si allontanerà dopo la riorganizzazione di Arpinati. Negli anni Venti sarà, assieme a Cuzzani, tra gli antifascisti fuoriusciti in Francia e dirigente della LIDU. Nel 1936 parteciperà alla guerra di Spagna nelle formazioni anarchiche. Dopo la cattura nel 1942 da parte della Gestapo, conoscerà l'esperienza dei campi di sterminio a Dachau e Mauthausen.dettagli
-
febbraio 1919Progetto del Velo Sport Reno per un campo sportivo con velodromoLa società ciclistica Velo Sport Reno presenta il progetto di un impianto polisportivo, da realizzarsi nel predio del Meloncello su una proprietà dei fratelli Micheli. E' prevista una pista ciclabile in cemento lunga 400 metri, una pista di corsa e un campo per partite di football e esercitazioni ginnastiche. Dovrebbero inoltre essere erette gradinate e tribune per 4.000 spettatori. La convinzione dei soci del Velo Sport è che "dopo l'immane flagello che ha funestato il mondo, sia necessario di concedere degli svaghi alla gioventù e nel contempo sia doveroso di ritemprare i corpi stremati dai lunghi disagi e dalle più deleterie privazioni". Il progetto non sarà per il momento realizzato, ma nell'autunno un gruppo di soci del Velo Sport, in forma privata, inizieranno i lavori per la costruzione di un campo sportivo e velodromo in un terreno fuori porta Saffi. Nell'area del Meloncello sorgerà invece nel 1926 il Littoriale, voluto da Leandro Arpinati.dettagli
-
9 aprile 1919Costituzione del primo Fascio di combattimentoUn centinaio di ex combattenti, in prevalenza repubblicani, anarco-sindacalisti e nazionalisti, si riuniscono il 9 aprile in via Barberia n. 4 nella sede della Lega latina della Gioventù, organizzazione paramilitare di destra fondata alla fine della guerra dal ten. Dino Zanetti (1897-1956) per educare i giovani alla disciplina e all'uso delle armi. Viene costituito il Fascio di combattimento bolognese. E’ definito “una associazione fra uomini che pure appartenendo a partiti diversi hanno in comune il proposito di non permettere che l’Italia, vittoriosa sui campi di battaglia, sia vinta all’interno dalla rivolta degli ex imboscati o sia avvilita da governi inetti”. Tra i fondatori vi sono Pietro Nenni (1891-1980), Cesare Tumidei (1894-1980), Leandro Arpinati (1892-1945), il sergente Adelmo Pedrini, i fratelli Guido e Mario Bergamo. A rappresentare la direzione centrale del movimento, interviene l'ex capitano degli Arditi Ferruccio Vecchi (1894-1960), che pochi giorni dopo a Milano guiderà la spedizione punitiva contro "L'Avanti" socialista. Il programma politico è piuttosto generico - "Né coi bolscevichi, né coi monarchici, ma per la rivoluzione e la Costituente" - frutto di una faticosa mediazione tra anime molto diverse. In pratica il Fascio bolognese ha soprattutto il compito di organizzare squadre armate per proteggere gli oratori e le sedi dei partiti avversari dei socialisti. Pochi giorni dopo l'incontro inaugurale si avrà già una prima defezione: i combattenti nazionalisti, guidati da Zanetti, lasceranno il gruppo per fondare la Lega antibolscevica e aderiranno al Fascio di Mussolini. Le divergenze tra democratici, radicali e repubblicani interventisti da un lato, arditi e nazionalisti dall’altro, costringeranno ben presto il primo Fascio all’inattività.dettagli
-
6 maggio 1919Mario Missiroli direttore del "Resto del Carlino"A soli 33 anni Mario Missiroli (1886-1974) diviene direttore del “Resto del Carlino”. E' l'enfant prodige del giornalismo bolognese: a soli quindici anni, ancora studente liceale, dirigeva due riviste politico letterarie, “Il Nuovo Don Chisciotte” e “Rinascenza” e discettava con Carducci. Era allievo di Alfredo Oriani e seguace di Sorel. Arricchirà il giornale di firme prestigiose - da Croce a Gentile, da Papini a Prezzolini - e terrà una linea moderata, in polemica con la politica agraria del fascismo, con qualche apertura ai socialisti. Dopo la strage di palazzo d'Accursio del novembre 1920 verrà accusato dall’”Assalto”, in mano ad Arpinati, di essere al soldo dei socialisti. I fascisti lo chiameranno "il ruffiano di Cagoia", cioè di Nitti. Il 5 aprile 1921 dovrà dimettersi dalla direzione del giornale e sarà bandito da Bologna. Andrà a Milano a dirigere "Il Secolo". Assieme a lui, gli industriali saccariferi emiliani e genovesi, proprietari del "Carlino", sacrificheranno l'amministratore, comm. Achille Gherardi, alto esponente della massoneria bolognese, manganellato il 4 aprile 1921 da otto fascisti armati nei pressi della sua abitazione. Il giorno seguente la direzione sarà affidata a Nello Quilici (1890-1940), uomo di Italo Balbo, sotto la supervisione di Ugo Lenzi (1875-1953), Venerabile della Loggia "VIII Agosto". All'epoca del delitto Matteotti, Missiroli entrerà in diretto conflitto con Mussolini. Da allora, nonostante la riconciliazione con il potente ras Arpinati, rimarrà ai margini per tutto il Ventennio, riprendendo nel dopoguerra le direzioni del "Messaggero" e del "Corriere della Sera".dettagli
-
12 settembre 1919A Fiume con D'AnnunzioGabriele D'Annunzio (1863-1938), alla testa di oltre mille uomini - ex combattenti, esponenti nazionalisti, mazziniani, futuristi, sindacalisti rivoluzionari e anche alcuni reparti dell'Esercito - occupa la città croata di Fiume (Rijeka), con l'intento di proclamarne l'annessione all’Italia. Essa diverrà per sedici mesi “Reggenza italiana del Carnaro”, un piccolo stato indipendente non riconosciuto dal governo italiano. L'impresa fiumana è vissuta da molti come una prosecuzione dell'ideale irredentista o come una riedizione delle “radiose giornate di maggio”. Il 13 settembre dalla Società Dante Alighieri di Bologna viene inviato “con l’animo colmo di commozione” un messaggio di solidarietà a “Fiume gemma d’Italia nella sua grande ora”. Alcuni degli “eroici volontari” sono partiti dal capoluogo emiliano. Tra essi Giancarlo Nannini (1899-1922), già ferito e decorato nella grande guerra, considerato “fiore e speranza dell'ateneo bolognese”, che morirà il 20 ottobre 1920 durante la preparazione della marcia su Roma e sarà celebrato come uno dei martiri della rivoluzione fascista. Volontario a Fiume è anche Luigi Jacchia (1902-?), figlio di Eugenio, massimo esponente della massoneria bolognese. Nel 1920 avrà l'incarico di aprire a Bologna l'Ufficio di rappresentanza del movimento dannunziano. Aderente al Fascio di combattimento di Arpinati, ne uscirà pochi mesi dopo per passare all'antifascismo. Tra i legionari vi è anche il giornalista Giovanni Leone Castelli, detto Nanni, originario di Foggia, che nel 1920, durante il servizio militare a Bologna, fonderà il giornale “L'Assalto”, organo del fascismo locale. In seguito emigrerà in America e nel 1921 pubblicherà a Montreal il periodico “Le Fiamme d'Italia”. Il 17 settembre le associazioni patriottiche bolognesi costituiscono un Comitato di soccorso pro Fiume italiana, che ha il compito di raccogliere fondi a sostegno dell’iniziativa dannunziana e di organizzare manifestazioni per l’annessione. Viene emesso un comunicato che plaude “all’ardito volere di pochi” che si ribellano alla ragion di stato “per la più grande disciplina del sentimento e della volontà nazionale”. Il 20 settembre, al contrario, le direzioni del Partito Socialista e della CGdL condannano l’occupazione fiumana, definita il colpo di mano di “una avventuriero della guerra”. I socialisti esortano i lavoratori a tenersi pronti ad agire per la sicurezza e la difesa della pace, contro un regime di sfruttamento e di violenza “che ogni giorno mette in pericolo il progresso e lo sviluppo dell’umanità e della civiltà”.dettagli
-
10 ottobre 1919Incidente d'auto per Mussolini e ArpinatiIl 10 ottobre a Firenze, al termine della Prima Adunata dei Fasci di combattimento, Benito Mussolini sfugge a un agguato di “anarcoidi teppisti” in piazza Santa Maria Novella. Nel timore di altri attentati, “che avrebbero potuto ripetersi in ferrovia per il ritorno”, il capo del fascismo è accompagnato a Bologna in automobile. Nei pressi del capoluogo emiliano la macchina, guidata dal fascista Guido Pancani, pilota di idrovolanti, urta contro le sbarre di un passaggio a livello e i passeggeri vengono sbalzati fuori. Mussolini esce incolume dall'incidente, mentre rimangono feriti Gastone Galvani e Leandro Arpinati che lo accompagnano.dettagli
-
13 novembre 1919Arpinati e Bonaccorsi arrestati a LodiIl 13 novembre arditi, fascisti e futuristi organizzano un comizio elettorale a Lodi al teatro Gaffurio. Tre giorni prima, nello stesso teatro, i socialisti avevano impedito al candidato fascista di parlare. Un gruppo di “sovversivi” si mette a fischiare e lancia oggetti e suppellettili contro il palco. Gli squadristi rispondono sparando e uccidendo tre persone: Vittorio Cattaneo, Felice Sorino e Michele Terenzi. La polizia - in seguito criticata per il mancato intervento preventivo - ferma numerosi fascisti e sequestra molte armi. Tra gli arrestati, imputati di omicidio plurimo, vi sono i bolognesi Leandro Arpinati (1892-1945) e Arconovaldo Bonaccorsi (o Bonacorsi, 1898-1962), che diverranno “stelle di prima grandezza nel firmamento squadristico” (Franzinelli). La lunga detenzione dei fascisti sarà allietata dalla “potente voce di Bonacorsi, lo stornellatore”, che spesso si alzerà “a far udire le sue ultime composizioni”. Simili a questa, cantata dai reduci di Lodi per le vie di Milano: Pussisti di MilanoAttenti, che diluvioRitornano da LodiI fascisti del Gaffuriodettagli
-
2 settembre 1920Occupazione delle fabbricheIn seguito alla decisione degli industriali di effettuare la serrata, il 2 settembre gli operai occupano le fabbriche cittadine, dopo aver sottoscritto un impegno con il padronato a non sabotare la produzione o asportare macchinari e materiali, in cambio del rientro al lavoro. Sui tetti sono issate bandiere rosse e ci si arma per la difesa. Con il consenso della Camera del Lavoro e del Partito socialista in 56 stabilimenti cittadini vengono eletti consigli di fabbrica. Sul piano nazionale il movimento diviene politico e pone il problema della conquista del potere. Il 10 settembre a Milano, in una drammatica riunione congiunta tra sindacato e partito socialista, prevale però l'opinione di limitare l'obiettivo della lotta al riconoscimento da parte dei padroni del “controllo sindacale delle aziende”, piuttosto che puntare alla “socializzazione dei mezzi di produzione e di scambio”. Anche se in sostanza non ha scopi eversivi, l'occupazione delle fabbriche suscita grandi timori nella borghesia. La rivoluzione appare “soltanto sfiorata, ma comunque percepita come un pericolo ancora incombente” (Gotor). Secondo Antonio Labriola “l'ossessione socialista incombe fatalmente da tutte le parti". Lo stato liberale appare invece assente e impotente. Il 27 settembre a Bologna è raggiunto un accordo e l'agitazione giunge a termine. Il 3 ottobre anche gli ultimi scioperanti, gli operai metallurgici, riprendono il lavoro. Terminata l’occupazione delle fabbriche l’ “Associazione di Difesa Sociale”, che riunisce il fronte antisocialista, decide di costituire e finanziare una organizzazione paramilitare, arruolando trecento uomini armati. All’appello risponderà il Fascio di Combattimento ora guidato dall’ex anarchico romagnolo Leandro Arpinati (1892-1945).dettagli
-
17 settembre 1920L'Associazione di difesa sociale arruola trecento armatiL'Associazione di difesa sociale, finanziata da industriali, commercianti e agrari bolognesi, arruola trecento armati per la protezione della lista di destra “Pace, Libertà, Lavoro”, che concorre alle elezioni amministrative. Dell'operazione si occupa l’ex ferroviere anarchcico Leandro Arpinati (1892-1945), che pesca tra gli iscritti al Fascio, i Sempre Pronti e i Legionari fiumani, seguendo le indicazioni di Benito Mussolini (1883-1945), che da tempo supervisiona la "formazione di gruppi armati di 200-250 individui” destinati a scatenare in Val Padana la guerriglia contro i socialisti (Gotor). Il prefetto non ordina lo scioglimento del corpo armato, palesemente illegale, che diviene la struttura militare del Fascio bolognese. L'assemblea convocata il 17 settembre segna la data di nascita del nuovo Fascio bolognese, con impostazione più decisa e violenta di quello del 1919. La prima sede è aperta in via Marsala 30.dettagli
-
20 settembre 1920Alla Sala Borsa la prima vittima del fascismoSi tiene al Teatro comunale una manifestazione per il 50° anniversario di Porta Pia, organizzata dai partiti moderati. Al termine della lunga sfilata nel centro cittadino, gli squadristi di Leandro Arpinati - un gruppo di trenta-quaranta persone in divisa militare e armate di bastoni e rivoltelle - sfila più volte in via Ugo Bassi e si scontra con gruppi di giovani socialisti all'altezza del ristorante cooperativo della Sala Borsa, considerato un covo di “sovversivi”. L'operaio anarchico Guido Tibaldi rimane gravemente ferito da colpi di arma da fuoco e morirà dopo alcuni giorni: è la prima vittima del fascismo. Dopo l'attacco alla Sala Borsa gli iscritti al fascio lievitano da venti a trecento.dettagli
-
13 ottobre 1920Gli incidenti del "casermone"Socialisti e anarchici proclamano uno sciopero generale di due ore per protestare contro l'ingerenza delle potenze occidentali negli affari interni della Russia sovietica. Ad un comizio in piazza Umberto I intervengono il leader anarchico Errico Malatesta (1853-1932) e il socialista Francesco Zanardi (1873-1954). Segue un corteo - non autorizzato e sconsigliato dalla stessa Federazione anarchica - che invoca la liberazione dei lavoratori arrestati durante l'occupazione delle fabbriche. Esso si conclude con un assalto al cosiddetto “casermone” delle Guardie Regie in via Cartolerie, angolo via Dé Chiari. Secondo il segretario degli anarchici Clodoveo Bonazzi (1890-1955), ai dimostranti "viene teso un tranello nel dedalo di viuzze che si aggirano attorno al carcere". Il futuro podestà Angelo Manaresi parlerà di una scarica partita dall'interno del presidio militare. Gli esiti degli scontri sono tragici: un brigadiere e un vice-ispettore sono uccisi e molte guardie riportano ferite. Tra i manifestanti si contano tre morti in seguito a percosse e coltellate e 32 lavoratori finiscono all'ospedale. Tra i deceduti vi è il consigliere comunale socialista Erminio Zucchini, che Enio Gnudi descriverà, nel suo discorso di insediamento a sindaco del 21 novembre, come giovane "sempre pronto a prodigarsi per la sua fede e per il suo ideale". Dopo gli incidenti, circa cinquecento giovani si raccolgono attorno alla bandiera tricolore e assieme marciano, cantando l'Inno di Mameli, fino al monumento di Garibaldi, dove parla lo studente Alberto Carrara. Dalle finestre di via Indipendenza si gettano fiori, mentre in piazza Nettuno il camion delle guardie regie è accolto da grandi applausi. Leandro Arpinati, capo del Fascio bolognese, annota che l'esasperazione è "palese nell'animo di tutti". Al termine dei solenni funerali degli agenti, il 15 ottobre, i fascisti assalgono le sedi del Comune e della Provincia e sparano contro il bar di Sala Borsa, considerato un covo socialista, facendo un morto - Giuseppe Fabbri, che si trova lì per caso - e tre feriti tra i passanti. L'arresto di un centinaio di dimostranti - tra essi il sindaco di San Giorgio di Piano, Raffaele Ramponi - è salutato dal "Resto del Carlino" come una "salutare opera di rastrellamento degli elementi anarchici e della teppa". Il 21 settembre la vecchia camera del lavoro di Porta Lame è dapprima invasa dalla polizia, che sequestra una grande quantità di documenti e opuscoli, quindi da colonne di carabinieri e guardie regie. Il Consiglio Generale dell'USI (l'Unione Sindacale di tendenza anarchica), riunito nella sede, è arrestato al completo. L'assalto del “Casermone” segna una svolta rispetto all'indifferenza di molti cittadini verso i socialisti e le sinistre. In tanti, da ora in poi, appoggeranno la lotta di nazionalisti e fascisti contro "i criminali condottieri dell'orda bolscevica". Qualche tempo dopo il leader socialista Giovanni Zibordi riconoscerà nelle giornate di ottobre “l'inizio della sconfitta dei partiti e dei movimenti di sinistra”.dettagli
-
16 ottobre 1920L'incendio dell' "edicola rossa"Al termine dei solenni funerali degli agenti uccisi durante gli scontri del Casermone, i fascisti comandati da Leandro Arpinati (1892-1945) assalgono le sedi del Comune e della Provincia e sparano contro il bar di Sala Borsa, considerato covo socialista, facendo un morto - il colono Giuseppe Fabbri - e tre feriti tra i passanti. E' inoltre data alle fiamme "fra gridi festanti e applausi" (Manaresi) l'edicola-libreria, "fabbricata in ferramenta" dal Comune e addossata a Palazzo d'Accursio, all'inizio di via Ugo Bassi. Simbolo dell'identità socialista bolognese, l'"edicola rossa" è accusata di fare "propaganda sovversiva e anti-italiana" nel cuore della città ed è considerata "uno sconcio" dalla borghesia bolognese. La sua distruzione riceverà commenti entusiasti da Gida Rossi (1862-1938), insegnante e presidente del Comitato Femminile pro Mutilati ed Invalidi di guerra, che benedirà i giovani distruttori del "botteghino di stampa socialista". Per Angelo Manaresi (1890-1965), ex combattente e futuro podestà, con il rogo dell’edicola socialista da parte dei giovani figli del Fascio cittadino, Bologna ha ritrovato “la sua fiera anima patriottica”.dettagli
-
20 ottobre 1920Arpinati riorganizza il Fascio cittadinoLeandro Arpinati (1892-1945), ex ferroviere anarchico originario di Civitella di Romagna (FC), passato nel 1915 al fronte interventista - fedelissimo di Mussolini, del quale è stato guardia del corpo - riorganizza il Fascio bolognese, in crisi dall'inverno precedente per la fuoriuscita degli interventisti democratici. Da generico servizio d'ordine, il Fascio si trasforma in una formazione politica dotata di un forte braccio armato. Raggruppa nazionalisti, liberali conservatori e borghesi, penalizzati dal carovita in città e vittime dell'azione sindacale socialista nelle campagne. Nelle le sue fila entrano studenti, ex combattenti, commercianti, legionari fiumani, personaggi come Marino Carrara, Angelo Tumidei, Arconovaldo Bonaccorsi. Un rapporto del Prefetto parla di giovani animosi con tendenze politiche diverse, “ma uniti nell'intento fondamentale: opporsi al bolscevismo e a qualunque azione che tenda all'instaurazione del regime dei soviets in Italia”. Il nuovo statuto del Fascio, approvato il 20 ottobre, prevede l'uso della violenza e di mezzi inconsueti, affermando che "i fasci non sono legalitari ad ogni costo, nè illegaritari a priori". Da “esiguo gruppo di animosi” il gruppo andrà sempre più ingrossandosi, fino a diventare, dopo l’eccidio di Palazzo d’Accursio (21 novembre 1920), “il Fascio proporzionalmente più numeroso d’Italia”. Tra i mesi di marzo e giugno 1921, fasci di combattimento sorgeranno in tutta la provincia. Nel volgere di poche settimane gli squadristi passeranno all'attacco delle sedi operaie e promuoveranno feroci spedizioni punitive contro i socialisti. Il Fascio bolognese farà suo il motto di quello triestino: "Pronti ad uccidere, pronti a morire". Secondo l'amico Torquato Nanni, Arpinati sarà "il primo, il più metodico, il più violento, il più inesorabile degli squadristi bolognesi". Nel pieno delle polemiche interne al movimento fascista dell’estate 1921 Benito Mussolini riconoscerà ad Arpinati - piuttosto che a Grandi - il merito della rifondazione, dopo aver sudato “sette camicie prima di arrivare a combinare un Fascio degno di questo nome”.dettagli
-
25 ottobre 1920Il concordato Paglia-CaldaDopo diversi mesi di lotte viene firmato l'accordo tra le varie componenti dei lavoratori agricoli (mezzadri, coloni, braccianti) e gli agrari. Sarà noto come il concordato Paglia-Calda, dai nomi di Calisto Paglia, presidente degli agrari, e Alberto Calda (1878-1933), legale della Federterra. L'accordo prevede un riparto favorevole ai mezzadri (60-65%) e migliori tariffe per i braccianti. L'istituto mezzadrile risulta radicalmente modificato: il rapporto del colono con la proprietà “è stabilito su una linea di parità” (Dondi). Vengono fissati alcuni doveri degli imprenditori agricoli, quali la fornitura dell'abitazione alla famiglia mezzadrile, la fornitura dell'acqua potabile e degli attrezzi, l'anticipo di somme per le sementi, i trasporti, la manodopera aggiuntiva. La grande maggioranza dei proprietari terrieri giudica l'accordo distruttivo dell'istituto mezzadrile. Il governo è accusato di favorire i socialisti. I fascisti di Arpinati rigettano subito il concordato. Il 25 ottobre stesso compaiono armati nei comuni di San Lazzaro e Ozzano, sequestrano alcune bandiere rosse dalle locali case del popolo e, una volta tornati a Bologna, le bruciano in via Indipendenza, scaricando in aria le loro rivoltelle, senza che la polizia intervenga. Pochi giorni dopo una squadra capitanata da Garibaldo Pedrini saccheggia a Casalecchio di Reno il Caffè Jolanda e dà fuoco ai locali dell’Ente autonomo dei consumi. La tecnica incendiaria, che diventerà così frequente nelle incursioni fasciste, è qui messa in atto per la prima volta. Le azioni squadristiche vengono presentate come “risposte patriottiche alla faziosità degli estremisti rossi”. Ma i dirigenti socialisti e popolari per il momento non sembrano preoccuparsi più di tanto. Il concordato Paglia-Calda, in gran parte disatteso dai proprietari terrieri, sarà abrogato illegalmente dal Prefetto di Bologna il 30 luglio 1923, dopo la definitiva vittoria del fascismo.dettagli
-
4 novembre 1920Il periodico fascista "L'Assalto"In occasione del secondo anniversario della Vittoria nella grande guerra esce il primo numero de “L'Assalto”. Creato dal giornalista dannunziano Nanni Leone Castelli, diviene dal secondo numero il periodico del Fascio bolognese di Combattimento guidato da Leandro Arpinati. In seguito è controllato dal segretario regionale del partito fascista Dino Grandi. Autodefinitosi "giornale-battaglia" è l'organo portavoce della fronda emiliana contro la linea moderata di Mussolini nei confronti dei socialisti. Fin dal primo numero si legge questo proclama: "Ognuno deve armarsi e decidere. O coi bolscevichi o con noi. La guerra civile, che il Governo e i bolscevichi hanno voluto, noi l'accettiamo e la faremo tutta quanta e tutta in fondo, senza quartiere e senza pietà". Alla direzione del periodico si alterneranno politici e giornalisti: Gino Baroncini, Giorgio Pini, Leo Longanesi e altri. Durante la RSI "L'Assalto", divenuto quindicinale della X Legio, sarà diretto dal Rettore dell’Università Goffredo Coppola. Tra i collaboratori annovererà i giovani Agostino Bignardi, Renzo Renzi, Enzo Biagi.dettagli
-
14 novembre 1920Il settimanale "Il Comunista" diretto da Nicola BombacciEsce a Bologna il primo numero del settimanale “Il Comunista”, organo della frazione comunista del Partito Socialista. Sarà pubblicato a Imola fino al 9 gennaio 1921, sotto la direzione di Nicola Bombacci (1879-1944). Dal 30 gennaio 1921 uscirà a Milano con cadenza bisettimanale e diventerà l’organo centrale del PCd’I. Nell’ultimo anno sarà diretto a Roma da Palmiro Togliatti. Cesserà le pubblicazioni il 28 ottobre 1922, giorno della Marcia su Roma, dopo la devastazione della sede e della tipografia da parte delle camicie nere. Il primo direttore del “Comunista” Nicola Bombacci è un romagnolo di Civitella come Leandro Arpinati ed è maestro di scuola e pubblicista come Benito Mussolini. Assoluto protagonista del biennio rosso, è uno dei maggiori rappresentanti della frazione Comunista del PS assieme a Bordiga e Gramsci. Fautore dei soviet, amico di Lenin, parteciperà alla scissione di Livorno del 1921. Nel 1927 sarà espulso dal Partito Comunista “per indegnità politica”. Negli anni Trenta si avvicinerà al fascismo e dirigerà la rivista “La Verità”, finanziata dal Minculpop. Sarà con Mussolini a Salò, sognando un ritorno alle origini rivoluzionarie e socialiste del fascismo, e accanto al Duce troverà la morte a Dongo per mano dei partigiani.dettagli
-
21 novembre 1920L'eccidio di Palazzo d'AccursioIl 21 novembre, in Piazza Maggiore, i socialisti festeggiano la vittoria elettorale e l'elezione a sindaco di Enio Gnudi (1893-1947), dirigente sindacale e rappresentante della corrente massimalista del PSI. Nei giorni precedenti i fascisti, guidati da Leandro Arpinati e Arconovaldo Bonaccorsi, hanno promesso lo scontro con manifesti provocatori: vogliono impedire ai socialisti di "issare il loro cencio rosso sul palazzo comunale". Hanno annunciato per domenica una "grande prova in nome dell'Italia". Provenienti da via Rizzoli e dall'Archiginnasio, assieme ad alcuni rinforzi da Ferrara guidati dallo squadrista-futurista Olao Gaggioli, circa trecento fascisti armati sono bloccati dalla Guardia Regia in Piazza Nettuno. Tre squadre guidate da Giovanni Battista Berardi, Enea Venturi e Oreste Roppa sfondano il servizio d’ordine. Dalla parte del caffè Grande Italia, all'angolo tra piazza Nettuno e via Rizzoli, vengono sparati colpi d'arma da fuoco quando Gnudi si affaccia al balcone del municipio.. La folla terrorizzata cerca di fuggire nel cortile di Palazzo d'Accursio, ma le "guardie rosse", un gruppo di armati comunisti e massimalisti che presidiano il palazzo, scambiano i fuggiaschi per assalitori, chiudono il portone e gettano dall'alto alcune bombe a mano. E' una strage: si contano 10 morti e 58 feriti, tutti socialisti, in maggioranza per colpi d'arma da fuoco. Un giovane di sedici anni di Casalecchio, Ettore Masetti, è colpito al ventre da una pallottola e morirà dopo tre mesi di agonia. Dopo una decina di minuti di spari e scoppi, nella piazza vuota, ricoperta di ombrelli, bastoni e cappelli, rimangono solo i cadaveri, che i pompieri ricoprono di teli. Intanto nell'aula consiliare un uomo, che rimarrà sconosciuto, spara dal settore riservato al pubblico contro i consiglieri di minoranza: l'avvocato Cesare Colliva riceve due proiettili in faccia, mentre l'avvocato Giulio Giordani, mutilato di guerra, è ferito a morte. Anche in via Riva Reno, fuori dall'Ospedale Maggiore, dove Giordani è trasportato, scoppia una sparatoria e gli infermieri lasciano il ferito su un muretto al bordo del canale, rifiutandosi di entrare in ospedale. Giordani sarà considerato il primo grande martire della rivoluzione fascista, vittima dell’odio bolscevico. Così ad esempio racconterà l’evento una popolare antologia scolastica del Ventennio: “Tutta la minoranza doveva essere annientata, per celebrare meglio la vittoria socialista, e con i cesti delle bottiglie e delle paste, nelle sale attigue a quella consigliare, erano pronti i cesti di bombe; e, mentre il povero Giordani agonizzava, giungeva da quelle sale il frastuono dei gozzoviglianti”. La salma sarà esposta in un'aula del tribunale e vegliata da picchetti di camicie nere armate. I funerali, celebrati il 23 novembre, vedranno sfilare i fascisti con il gonfalone del comune, tra due imponenti ali di folla. Al consigliere ucciso sarà in seguito intitolata la piazza davanti al tribunale. La giunta neoeletta di Gnudi sarà costretta a ritirarsi senza essersi insediata, sostituita dal commissario prefettizio Vittorio Ferrero, che rimarrà in carica fino al marzo 1923. La polizia arresterà circa duecento socialisti e nessun fascista, accreditando la tesi de "L'Avvenire d'Italia", che considera i "rossi" colpevoli dei fatti luttuosi. Il Tribunale di Milano condannerà nel 1923 in contumacia alcuni militanti comunisti. Nel dopoguerra Mario Missiroli e Libero Battistelli addosseranno la maggiore responsabilità dei fatti alle forze dell'ordine, che avrebbero provocato la strage per screditare i socialisti. Il tragico eccidio di Palazzo d'Accursio ha risonanza nazionale e segna l'inizio dell'ascesa fascista. Nella provincia più rossa il fascismo attechirà velocemente e da qui si diffonderà in tutta la pianura padana.dettagli
-
7 dicembre 1920Spedizione punitiva a Castel San PietroA Castel San Pietro un ex ufficiale è malmenato da simpatizzanti socialisti mentre affigge manifesti fascisti. Nel pomeriggio una squadra di circa 150 fascisti comandata da Gino Baroncini (1893-1970) e Augusto Alvisi (1893-1947), proveniente da Bologna su quattro camion, giunge in paese e assale il municipio, la camera del lavoro e la sede della lega contadina, procurando gravi danneggiamenti. Il materiale d'archivio sequestrato, le bandiere rosse e i ritratti di Lenin vengono portati in piazza Vittorio Emanuele II (piazza Maggiore) a Bologna e dati alle fiamme, inaugurando un rito, che diverrà ricorrente dopo le spedizioni punitive degli squadristi. Legato inizialmente a Dino Grandi e agli agrari, l'imolese Baroncini, ragioniere e impiegato dell'Agraria, è "secondo per autorevolezza e comando nel fascio bolognese" dopo Arpinati. Particolarmente violento e coraggioso, ma anche abile e astuto organizzatore, è uno dei più tenaci oppositori di ogni compromesso con i socialisti. Per il prefetto Mori “rappresenta la concezione agraria proclive alla violenza, se necessaria alla difesa degli interessi degli agricoltori”. Guiderà altre clamorose spedizioni punitive: il 4 aprile 1922 a Porretta, il 13 ottobre a Molinella. Verrà emarginato dal partito fascista dopo il 1923, per le sue posizioni troppo radicali.dettagli
-
18 dicembre 1920Due deputati aggrediti a Bologna. Eccidio del Castello a FerraraIl 18 dicembre i deputati socialisti Genuzio Bentini (1874-1943) e Adelmo Niccolai (1885-1948), difensori di un gruppo di braccianti accusati di violenze a Trebbo di Reno, vengono bastonati da una squadra di fascisti davanti al tribunale di Bologna. "Dopo una ripugnante e bestiale scena protrattasi per qualche tempo", Niccolai e l'anziana madre, accorsa in suo aiuto, sono accompagnati a casa "pesti e sanguinanti". Per l'aggressione ai due parlamentari vengono fermati alcuni giovani squadristi, ma Leandro Arpinati (1892-1945), reggente del Fascio, si fa arrestare al loro posto. Verrà rilasciato dopo due giorni. In un comunicato i fascisti proclamano che continueranno ad usare la violenza contro i responsabili del PUS - i socialisti ufficiali, considerati liquido infetto - finchè non cesseranno le denigrazioni nei loro confronti dentro e fuori il Parlamento. Il bellicoso proposito trova conferma il 20 dicembre a Ferrara, dove Niccolai ricopre l'incarico di Presidente del Consiglio provinciale. Qui un gruppo di socialisti, accorsi per protestare contro l'aggressione di Bologna, si imbatte in alcuni fascisti, che commemorano la morte violenta dell'avv. Giulio Giordani, avvenuta anch'essa nel capoluogo regionale il 21 novembre precedente. Nel largo davanti al Teatro si comincia a sparare. “Colpi micidiali” partono anche dall'alto del Castello, sede dell'Amministrazione provinciale. Cadono i fascisti Franco Gozzi, Natalino Magnani e Giorgio Pagnoni. Per le ferite riportate moriranno in seguito il fascista Giuseppe Salani e i socialisti Giovanni Mirella e Giuseppe Galassi. I funerali delle vittime diventano una dimostrazione di forza e “il trampolino di lancio dell‘offensiva fascista“: vi partecipano circa 14 mila persone e le 2.000 camicie nere presenti sfilano per il centro della città estense, cantando inni e tenendo vari comizi. Le spoglie dello studente Natalino Magnani, uno dei primi e più giovani “martiri della rivoluzione fascista”, ucciso - secondo la lapide commemorativa del cimitero di Lavezzola - da “vili briachi d'odio e di vino”, verranno accolte nel sacrario della Certosa di Bologna.dettagli
-
21 dicembre 1920Aggressioni all'onorevole ZanardiMentre si trova nella sede dell'Ente Autonomo dei Consumi, l'ex sindaco socialista Francesco Zanardi (1873-1954), chiamato dai nazionalisti "al sindacaz", viene aggredito e sequestrato da una squadra di fascisti - tra essi anche il futuro podestà Mario Agnoli - che lo costringe a sottoscrivere dichiarazioni patriottiche e gli intima di lasciare Bologna. L'aggressione si ripeterà il successivo 16 gennaio: i fascisti lo obbligheranno a lasciare gli uffici assieme alla moglie, con insulti e lanci di monetine. Zanardi sarà indotto a trasferirsi a Roma nel 1922, dopo la scomparsa del figlio Libero, deceduto a seguito delle percosse subite in un agguato squadrista. La polizia fascista non mancherà a più riprese di rilevare il suo "orientamento antifascista, irriducibile, acido e insidioso". L'Ente Autonomo dei Consumi, sua creatura, subirà il sistematico assalto dei fascisti e finirà sotto il completo controllo del ras Arpinati, attraverso il cognato Riccardo Muzzioli.dettagli
-
28 dicembre 1920La borghesia finanzia il Fascio di combattimentoIl Questore comunica al Prefetto che l'Associazione bolognese di difesa sociale ha versato 100.000 lire al Fascio di combattimento di Bologna, che in questo periodo sta ricevendo l'adesione di molti ex arditi, legionari e nazionalisti. L'Associazione di difesa sociale (o civile) si è costituita nel capoluogo dopo il grande sciopero seguito all'eccidio di Decima, con l'intento di "porre fine con tutti i modi più risoluti ad un succedersi di cose intollerabili e rovinose". Dietro di essa vi sono i principali esponenti della borghesia conservatrice, dal liberale Tanari al nazionalista Ghigi. L'organizzatore delle squadre d'azione, Leandro Arpinati, considera la borghesia bolognese "apatica e vile", ma non ne disdegna il denaro, ritenuto "tanto necessario alla nostra battaglia".dettagli
-
14 gennaio 1921Assalto al treno di pendolari Bologna-BazzanoAppena partito dalla stazione di Bologna un treno della linea Bologna-Bazzano è preso d'assalto a colpi di pistola da una trentina fascisti guidati da Leandro Arpinati e nascosti dietro le colonne del portico. Tra gli operai pendolari, accusati di aver boicottato un ferroviere fascista, si contano due feriti gravi. Cinque squadristi vengono arrestati dai carabinieri di scorta: tra essi Giuseppe Ambrosi, commerciante titolare del negozio Old England nel centro di Bologna.dettagli
-
24 gennaio 1921Incendio della Camera del Lavoro e violenze fascisteIl 21 gennaio a Modena, davanti alla trattoria “Il Gallo”, tre fascisti sono affrontati da un gruppo di anarchici, che vogliono vendicare un operaio bastonato poco prima sulla via Emilia. Nella sparatoria che segue il fascista Mario Ruini rimane ucciso. Il 24 gennaio ai suoi funerali partecipano tutti i fasci e le associazioni combattentistiche emiliane. All'altezza del palazzo delle Poste il corteo è fatto segno di colpi di pistola e di moschetto da parte di un gruppo di "guardie rosse", sbucato all'improvviso dal portico del Collegio. Si scatena l'inferno: altri colpi piovono dai tetti, le camicie nere non tardano a rispondere al fuoco. Al termine della battaglia si contano due morti tra le file fasciste: Augusto Baccolini da Bologna e Orlando Antonini da Forlì. Tra i feriti c'è anche il ras bolognese Leandro Arpinati (1892-1945). Nella notte fra il 24 e il 25 gennaio, a Bologna, le camicie nere danno l'assalto alla sede della Camera Confederale del Lavoro in via D'Azeglio, incendiano la Cooperativa Tipografica, che stampa il settimanale "La Squilla", saccheggiano la sede dell'Unione Socialista e gli uffici delle leghe. Una squadra, capeggiata da Dino Grandi (1895-1988), impedisce ai vigili del fuoco di spegnere gli incendi. La polizia, pur presente in forze, non interviene. Il giorno successivo i fascisti invadono le sedi della Società Operaia e della Federterra in via Cavaliera. Arpinati scaccia da Bologna il deputato socialista Luigi Salvadori (1881-1946), impegnato in una indagine sulla violenza politica diffusa in città. Il ministro dell'Interno Giolitti ordina la revoca delle licenze di porto d'armi nelle provincie di Modena, Ferrara e Bologna, provocando una generale levata di scudi. Una delegazione, capeggiata da Grandi, viene inviata a Roma per la revoca del provvedimento. Ad una settimana dal divieto, il Comitato d'azione contro il disarmo di Bologna constaterà con soddisfazione lo scarso numero delle consegne. Nel frattempo il prefetto e il questore rinunceranno a perseguire i responsabili degli assalti squadristi con il pretesto di non avere abbastanza guardie a disposizione.dettagli
-
4 marzo 1921Spedizioni punitive contro i "sovversivi". Baroncini ras delle campagneCome avviene oramai da tempo, il sabato le squadre fasciste percorrono la provincia di Bologna a caccia di “sovversivi”. La “difesa contro la tirannia delle leghe” è diventata la distruzione sistematica di uffici di collocamento, leghe, cooperative e una serie infinita di aggressioni ai sindacalisti socialisti. Gli assalti vengono pianificati con cura: gli squadristi escono dalla città a piccoli gruppi per evitare controlli della polizia e raggiungono punti di raccolta in cui li attendono mezzi appositamente noleggiati. Il 5 marzo sono riconosciuti e bastonati dai fascisti i capilega di Monte San Pietro, di Altedo e di Praduro e Sasso. Il 7 marzo a Pieve di Cento una squadra in transito spara e uccide una donna alla finestra (Angelina Toni). Il segretario politico del fascio bolognese Leandro Arpinati (1892-1945), considerato corresponsabile dell'omicidio, verrà arrestato il 15 marzo alla stazione di Milano. Scarcerato tre giorni dopo, sarà accolto a Bologna da migliaia di camicie nere in festa. Il 6 aprile a Cà de Fabbri (Minerbio) i fascisti aprono il fuoco contro un gruppo di lavoratori, ferendo gravemente Giovanna Giuseppina Pilati, che muore alcuni giorni dopo. Sono solo alcune delle imprese squadriste nella provincia bolognese, il cui mandante principale è Gino Baroncini (1893-1970), fascista della primissima ora. Incolto, ma abile e astuto, il Federale non esita, secondo Dino Grandi, "ad esibire ad ogni occasione un carattere violento e un particolare coraggio". Dal suo ufficio in via Galliera partono gli ordini di bastonare gli oppositori, incendiare le camere del lavoro, indurre alle dimissioni le amministrazioni socialiste. Baroncini acquista un potere simile a quello di Italo Balbo nel ferrarese, promettendo non solo la punizione dei "rossi", ma anche "botte agli agrari". Il modello di Balbo è quello dell’attacco violento alle organizzazioni socialiste, ma anche la riorganizzazione dei contadini e dei braccianti nei sindacati nazionali filofascisti, con la promessa della piccola proprietà. Nel frattempo i sindacalisti di sinistra sono arrestati dalle forze dell'ordine con l'accusa di boicottaggio, estorsione, minacce e vessazioni contro gli abitanti delle campagne (agrari e contadini). A Castel San Pietro vanno a giudizio 25 socialisti membri del "tribunale rosso", per i danni agricoli provocati nell'estate del 1920. Le estorsioni di denaro, confessate da un assessore di Pianoro, non sono un caso isolato: si sono verificate in numerosi altri comuni della provincia.dettagli
-
15 marzo 1921La Camera sindacale del lavoro indipendenteDopo aver ricevuto una risposta negativa da parte del Direttorio del Fascio bolognese, Dino Grandi (1895-1988) e Gino Baroncini (1893-1970) promuovono autonomamente la Camera sindacale del lavoro della città e provincia di Bologna, con sede in via Pepoli n. 5. La nuova compagine intende opporsi “alla degenerazione del movimento sindacale”, per Grandi minato dalle ambizioni dei politici. Il 30 aprile la Camera raccoglie un notevole numero di aderenti che aumenteranno rapidamente. Vengono nominati dirigenti alcuni veterani del sindacalismo rivoluzionario. E' pubblicato il settimanale "Il lavoro d'Italia". Il sindacato fascista promette la concessione di terre ai contadini mediante contratti di enfiteusi o per riscatto con pagamento nel lungo periodo. Viene suggerita anche la creazione di una apposita banca per queste operazioni. I mezzadri, soprattutto, accoglieranno con entusiasmo queste proposte, abbandonando in massa le leghe rosse e le organizzazioni socialiste. La Camera fascista si espanderà oltre la provincia di Bologna e in modo particolare in quella di Ferrara (Ufficio Terre), raccogliendo consensi crescenti tra coloni, affittuari e piccoli proprietari terrieri. Dino Grandi e Italo Balbo inviteranno Edmondo Rossoni (1884-1965) - ex socialista di Tresigallo (FE), divenuto interventista e fascista - alla guida del movimento e questi si trasferirà a Bologna fino all'ottobre 1922. La linea sindacale di Grandi e Baroncini troverà invece l’opposizione di Leandro Arpinati (1892-1945), che in questa fase concepisce lo squadrismo fascista come strumento nelle mani della borghesia.dettagli
-
3 aprile 1921Adunata dei Fasci emiliani. Discorso di Mussolini al Teatro ComunalePrima adunata a Bologna dei Fasci dell'Emilia e della Romagna. Un “mare di folla plaudente, contadini scesi da Monzuno, da Crevalcore, da Budrio e dal Sasso, arditi, ex combattenti, mondariso, ragazzi delle scuole, in un clima di ardente entusiasmo” accoglie Mussolini in bombetta su una Torpedo guidata da Arpinati, “col braccio alzato nel saluto romano”. Un imponente corteo, con oltre ventimila bandiere e gagliardetti sventolanti, lo accompagna in piazza Vittorio Emanuele II. Il 3 aprile il futuro Duce pronuncia un discorso al Teatro comunale, presentato da Dino Grandi (1895-1988): "E’ lui l'animatore, l'intrepido, l'indomito". Alla presenza della vedove di Cesare Battisti, Giacomo Venezian e Giulio Giordani - quest’ultimo assassinato nel corso dell'eccidio del novembre 1920 in palazzo d'Accursio - Mussolini ricorda la nascita del fascismo, contrappone al Primo maggio socialista il 21 aprile fascista, data del Natale di Roma, ridicolizza gli esponenti moderati del socialismo bolognese, citando Bucco, Zanardi e Bentini. Durante il congresso emiliano dei Fasci è approvato l'ordine del giorno di Baroncini e Gattelli, che tutela la proprietà privata, ma la condiziona all'etica del lavoro. Un altro ordine del giorno, firmato con Olao Gaggioli, ridimensiona però di molto la parola d’ordine di Balbo e dello squadrismo ferrarese “la terra a chi la lavora”. In un articolo sull' "Assalto" Baroncini prevederà l'esproprio dei proprietari che vivono esclusivamente di rendita, mentre prometterà la salvaguardia dei "piccoli proprietari coscienziosi". Grandi e Baroncini saranno eletti al Comitato regionale dei Fasci, mentre Arpinati accederà al Comitato centrale del partito. Il bagno di folla nella "roccaforte fascista d'Italia" impressiona Mussolini e gli fa prendere atto della forza del fascismo emiliano. Una forza che il comitato milanese dovrà cercare di governare per non esserne scavalcato (Dalla Casa).dettagli
-
21 maggio 1921Gli squadristi bolognesi a Rimini dopo l'uccisione di PlataniaIl 19 maggio 1921 alla stazione di Rimini viene ucciso Luigi Platania, ex anarchico e pluridecorato in guerra. Era tra i fondatori del locale fascio di combattimento e protagonista di numerose azioni contro i socialisti e gli anarchici. Per il fascio la responsabilità del delitto è dei comunisti e dei socialisti, osteggiati anche dai cattolici e dai liberali conservatori di Rimini. Molti di loro sognano di “tornare al medio evo ed instaurare la legge del taglione”. Il 20 maggio in piazza Cavour vi sono scontri tra comunisti e fascisti, che sparano anche colpi di pistola a scopo intimidatorio. Nel borgo popolare di San Giuliano è incendiato il circolo anarchico, in via Clodia va in fiamme di circolo dei ferrovieri. In entrambe i casi è impedito l'intervento dei pompieri. Intanto i fascisti di Sant'Arcangelo terrorizzano la gente “girando con le rivoltelle alla mano, con bastoni, minacciando, entrando nelle case”. Il 21 maggio gli squadristi di Bologna, Ferrara, della Romagna e delle Marche si concentrano a Rimini per commemorare Platania. Assieme ad Arpinati è presente il quartier generale dello squadrismo bolognese. Nel Politeama l'on Aldo Oviglio, di origine riminese, pronuncia l'orazione solenne in memoria del martire. Dopo la cerimonia di commemorazione, i fascisti scorrazzano per Rimini “menando botte da orbi a chiunque volente o nolente non si fosse tolto il cappello al passaggio delle loro bandiere”. Le misure riservate ai nemici prevedono: “nessuna fede politica, uno schiaffo; tessera Sindacato ferrovieri, due schiaffi e una bastonatura; tessera socialista, maggiori bastonate; per i comunisti e anarchici, ospedale e bando”. In un manifesto si afferma che nessuno può opporsi ai fascisti, venuti a liberare la città “dalle clientele bolsceviche”. Si susseguono aggressioni, bastonature a sangue, minacce di morte. Il 22 maggio i funerali di Platania sono disertati dai riminesi. Nassuno fa onore “ad un Eroe così vero e puro”. Il settimanale fascista di Bologna, “L’Assalto”, definisce Rimini “la città dei rammolliti e dei vili”, un “paese di mercanti ed affittacamere”. Di ritorno in città dopo le esequie, i fascisti bolognesi sparano sulla folla radunata per la festa del Corpus Domini nella frazione di Santa Giustina, sulla via Emilia. Una persona rimane uccisa e altre due moriranno poco dopo all’ospedale. Per l’aggressione lo squadrista Arconovaldo Bonaccorsi sarà condannato a tre mesi di carcere. "L'eroica figura del Martire Eroe Fascista Luigi Platania" sarà commemorata fin nella lontana Australia. A Sydney, dove il Fascio locale porterà il suo nome, sarà presentato come "il generoso popolano ex combattente" che ha sacrificato la sua vita in difesa della Patria "minacciata nella sua esistenza dal nemico interno ubbriacato d'odio caino e di ideologie straniere". Nel 1923 per il delitto di Platania si autoaccuserà Carlo Ciavatti, anarchico, mutilato sul lavoro e più volte coinvolto in vicende giudiziarie. L'anno seguente egli sarà condannato a vent'anni, che sconterà in varie carceri italiane.dettagli
-
30 maggio 1921Arpinati contestato all'assemblea del FascioIl 30 maggio si tiene al Teatro Contavalli l’assemblea del Fascio bolognese. All’ordine del giorno vi sono le dichiarazioni di Mussolini sul fascismo repubblicano e la conduzione del partito a Bologna. Sulla natura repubblicana del movimento sono favorevoli Grandi e Baroncini, mentre è nettamente contrario Aldo Oviglio (1873-1942), che difende l’utilità della monarchia. La gestione del partito di Leandro Arpinati (1892-1945) è messa pesantemente sotto accusa. E’ criticata la violenza rivoluzionaria ad ogni costo, che Baroncini giustifica solo come difesa degli interessi degli agrari. Dino Grandi vuole trasformare il fascismo in un vero e proprio partito ed è favorevole alla creazione di sindacati fascisti. Il Fascio bolognese viene di fatto commissariato dall’ala sindacalista. Arpinati è confermato segretario cittadino, ma gli viene affiancato Umberto Baccolini, ex tenente dei carabinieri e fedelissimo di Baroncini.dettagli
-
21 giugno 1921La federazione provinciale fascistaE' costituita ufficialmente la federazione provinciale del Fascio e “L'Assalto” ne diviene l'organo di stampa.Gino Baroncini (1893-1970) è eletto segretario politico e assume il controllo delle squadre d'azione, organizzate gerarchicamente con disciplina militare secondo il modello ferrarese.Le formazioni di Italo Balbo (1896-1940) operano già da tempo anche nei comuni bolognesi prossimi alla provincia di Ferrara, come Galliera, Malalbergo e soprattutto Molinella, roccaforte della resistenza antifascista. Le squadre bolognesi di Baroncini si rivolgono soprattutto al territorio imolese.Tra marzo e giugno si costituiscono fasci locali in quasi tutti i comuni della provincia: il più numeroso è quello di Malalbergo, paese al confine con Ferrara, con 250 iscritti. Seguono Castel San Pietro (175) e Budrio (168), mentre rimangono a lungo poche le iscrizioni a Medicina e Molinella.Il bilancio delle violenze fasciste nei primi sei mesi del 1921 in provincia di Bologna vede la distruzione di 35 sedi dell'opposizione, tra case del popolo, camere del lavoro, cooperative, leghe e circoli politici.Il potere della federazione bolognese - conosciuta come la Decima Legio - sarà a lungo instabile, conteso tra autorevoli squadristi della prima ora, quali Dino Grandi, Gino Baroncini e Leandro Arpinati.Quest'ultimo finirà per prevalere e la reggerà senza interruzioni dal 1924 al 1929, quando sarà chiamato a Roma da Mussolini come sottosegretario agli Interni (in pratica il numero due del regime).dettagli
-
10 ottobre 1921Arpinati lascia la segreteria del FascioLeandro Arpinati (1892-1945) lascia la segreteria del Fascio bolognese. Nell'assemblea straordinaria tenutasi il 10 ottobre al Teatro Comunale è messa pesantemente in discussione la sua gestione del movimento, sia da un punto di vista finanziario che organizzativo. Il fascismo bolognese è oramai egemonizzato da Dino Grandi (1895-1988) e Gino Baroncini (1893-1970), che, al contrario di Arpinati, sono favorevoli alla formazione di un partito fascista nazionale, affiancato da un sindacato autonomo capace di organizzare le masse operaie e di "sottrarle ai partiti sovversivi". Arpinati riassumerà l'incarico nel febbraio del 1922, su richiesta personale di Mussolini.dettagli
-
21 ottobre 1921Resa dei conti all' Assemblea del FascioAll’assemblea del Fascio, che si tiene il 21 ottobre al Teatro Rappini, Leandro Arpinati (1892-1945) difende la natura squadrista e movimentista del fascismo e si pronuncia contro la sua trasformazione in partito. E’ una posizione nettamente contraria a quella dei ras emergenti Gino Baroncini (1893-1970) e Dino Grandi (1895-1988), che sostengono anche lo sviluppo dei sindacati nazionali, osteggiati, invece, da Arpinati. Aldo Oviglio (1873-1942) tenta di mediare tra le due fazioni, sostenendo la linea sindacalista e la trasformazione in futuro del Fascio in una milizia a difesa della Nazione. La proposta viene approvata dall’assemblea. Al congresso nazionale, convocato a Roma il 7 novembre, vengono inviati Grandi, Baroncini, Oviglio, Bonacorsi e Pini, ma non Arpinati. Grandi Sarà nominato nella commissione esecutiva, Baroncini nel comitato centrale. Il congresso deciderà la trasformazione del movimento in partito e l’annullamento del patto di pacificazione con i socialisti.dettagli
-
18 gennaio 1922Il sindacato fascista di BaronciniIl 18 gennaio si tiene a Bologna un Convegno sindacale fascista. Intervengono i massimi dirigenti locali: Dino Grandi, Gino Baroncini, Edmondo Rossoni, Italo Balbo, Aldo Oviglio. E' proclamata la costituzione della Federazione Provinciale dei Sindacati nazionali, che organizza oltre 25 mila lavoratori della provincia. La nuova sigla, formalmente apolitica, stipula accordi con gli agrari meno vantaggiosi per i lavoratori di quelli ottenuti in precedenza dalla Federterra. I proprietari terrieri, che per opera di Gino Cacciari e Julio Fornaciari hanno fondato da poco la loro Federazione sindacale, vorrebbero però andare oltre: chiedono mani libere sulle assunzioni e sul livello dei salari, vogliono ridurre gli arativi e reintrodurre nei patti agrari le corvée feudali. Baroncini, segretario provinciale del PNF, pretende invece che gli accordi siano vincolanti per tutti. Vuole farsi carico delle sorti dei braccianti e dei mezzadri e denuncia lo "schiavismo agrario". Egli segue il modello ferrarese di Balbo, che si è dimostrato più adatto per la penetrazione del fascismo nelle campagne padane. Il ras bolognese sarà alla fine messo in minoranza da un'offensiva congiunta di Leandro Arpinati e Dino Grandi, in accordo con Mussolini. Dopo che Baroncini sarà riconfermato segretario per acclamazione dal Congresso provinciale dei Fasci, nel dicembre 1923, il Duce farà commissariare la indisciplinata Federazione bolognese.dettagli
-
22 gennaio 1922Prima Mostra d’Arte FuturistaIl 22 gennaio si inaugura, presso il Teatro Modernissimo, la Prima Mostra d’Arte Futurista, alla presenza di diverse personalità, quali Leandro Arpinati, Luigi Federzoni, Renzo Grandi. All’inaugurazione - ricorderà F.T. Marinetti - si scatena “un’oceanica gazzarra divisa in squadristi seguaci di Baroncini e in squadristi seguaci di Grandi”. Riccardo Bacchelli recensisce la mostra sul “Resto del Carlino”. Espongono tra gli altri Pannaggi, Masnata, Balla, Depero, Dottori e, tra i bolognesi, Guglielmo Sansoni, detto Tato, che si presenta sotto vari pseudonimi. Il capo del Futurismo ironizza sull’architettura di Palazzo Ronzani, che ospita la mostra, definendola “pseudo classicista, pseudo eclettica” e decrive in questo modo il panorama delle due torri: “In alto i due virilissimi membri Bolognesi di una volta, sotto, molti deboli passatisti di oggi, dotti e lenti”.dettagli
-
19 febbraio 1922Mussolini richiama Arpinati alla politica attivaRitiratosi a vita privata dopo il dissidio con Dino Grandi e Gino Baroncini sulla gestione del fascismo bolognese, Leandro Arpinati viene richiamato al posto di comando da una lettera di Mussolini del 19 febbraio. L'ascesa dell'ex anarchico di Civitella di Romagna fino ai vertici del fascismo nazionale diviene da questo momento assai rapida. Rieletto deputato nel 1924 e primo Podestà a Bologna nel 1926, diverrà in seguito vice-segretario nazionale del PNF e, dal 1929, Sottosergetario all'Interno, in pratica il numero due del regime, dopo Mussolini. Prima della caduta in disgrazia nel 1933, ricoprirà anche numerose cariche sportive: vice-presidente della Federazione italiana di Atletica leggera (FIDAL) nel 1925, Presidente della Federazione italiana Gioco Calcio (FGCI) e della Federazione Nuoto nel 1930, Presidente del CONI nel 1931.dettagli
-
marzo 1922Assalto dei fascisti alla "Sempre Avanti!"La S.G.E. Sempre Avanti! organizza nel mese di marzo i Campionati emiliani di Boxe. Subito dopo la fine delle gare le squadre fasciste prendono d'assalto la sede della Società in via Maggia: incendiano e distruggono le attrezzature e l'archivio, picchiano pubblico, dirigenti e atleti. Il pugile Testoni, che tenta di calmare gli animi, viene pestato a sangue e deve essere ricoverato all'Ospedale Maggiore. La Sempre Avanti!, di origine popolare, subirà più volte l'ostilità dei fascisti e del nuovo regime, ma sarà comunque lasciata vivere fino al 1928, quando i suoi dirigenti decideranno di confluire nella Bologna Sportiva, la società sostenuta dal Podestà Arpinati e controllata dal PNF.dettagli
-
18 marzo 1922Bilancio delle violenze fascisteNel 1921, secondo un rapporto della Camera del Lavoro di Bologna, gli attacchi delle squadre fasciste provocano 19 morti e quasi duemila feriti solo nella provincia. Sono distrutte case del popolo, camere del lavoro, cooperative, leghe, circoli e sezioni socialiste. Le basi di partenza delle spedizioni punitive sono soprattutto Budrio e San Giorgio di Piano. In seguito operano anche squadre dal ferrarese. Le squadre arrivano di notte all’improvviso, saccheggiano e bruciano tutto. Lo scontro nelle campagne si incentra sul collocamento, sull'imposizione di un nuovo patto colonico fascista, sulla scelta delle trebbiatrici. L'assalto alle strutture cooperative segue uno schema consueto, con due obiettivi: il capolega e la sede. Sul capolega si scatenano intimidazioni e violenze fino all'uccisione e alla cacciata dal luogo di lavoro e di residenza. La sede è esposta ai vandalismi e ai saccheggi, mentre l'ente subisce il taglio dei finanziamenti, la revoca degli appalti e degli affitti. Solo nel 1921, 23 cooperative subiscono l'azione repressiva e la chiusura forzata. Quelle che non sono distrutte vengono "fascistizzate", con la nomina di nuovi amministratori. Nel 1922 il bilancio delle violenze fasciste sarà ancora più pesante: si giungerà a vere e proprie stragi, perpetrate con l'occhio complice del governo e della forza pubblica. Tra gennaio e marzo nei paesi della provincia di Bologna non si contano le spedizioni punitive, che lasciano sul campo morti e feriti da entrambe le parti. Il 12 gennaio in città un colpo di pistola uccide il sindacalista anarchico Mario Biavati. Il 18 a San Venanzio di Galliera vengono uccisi gli operai socialisti Luigi Cantelli e Rocco Sacchetti. Il 28 febbraio è incendiata la sede della lega di Castel Maggiore. Il 4 marzo a Castel San Pietro muore il fascista Enrico Lazzari. Il 5 è assalita la cooperativa di consumo di Anzola Emilia: un bracciante anarchico è freddato a revolverate e due fratelli rimangono gravemente feriti. Il 13 marzo a Bologna sono aggrediti i militanti del Partito popolare e il 18 seguente vengono manganellati sette legionari fiumani. E' solo un elenco sommario. Un'indagine della Federcoop di Bologna del 1952 parla di 75 cooperative assaltate e sottratte ai lavoratori dalle squadre fasciste. Dopo le elezioni del 1920 nella provincia di Bologna si erano insediate 52 amministrazioni comunali a guida socialista. Nel giugno del 1922 ne rimangono 15. Molti sindaci sono stati più volte minacciati e bastonati dagli squadristi, le loro case incendiate. I primi cittadini - e assieme a loro sindacalisti, cooperatori e attivisti politici - sono stati espulsi dai paesi. Nel settembre 1922 il fascio conta in città almeno 5.000 iscritti e circa 20.000 nel complesso della provincia, metà dei quali fanno parte di squadre d'azione. In omaggio all'azione antisocialista delle squadre di Arpinati e dei ras della provincia Mussolini definirà Bologna "il quadrivio della rivoluzione fascista".dettagli
-
1 maggio 1922"La reazione tinge di sangue il Calendimaggio"A Bologna i fascisti tentano di monopolizzare la tradizionale Festa del lavoro, di marca socialista, concentrando in città le squadre dei dintorni. All'adunata partecipano migliaia di lavoratori che, “consumato un rancio”, sfilano davanti ai capi fascisti Grandi, Oviglio, Baroncini e Arpinati. Per evitare scontri, i socialisti tengono i loro comizi nel Teatro comunale. Nonostante la presenza della forza pubblica, numerosi partecipanti vengono aggrediti e bastonati all'ingresso e all'uscita. Si contano venti feriti. A Molinella un corteo di 7.000 persone, con a capo gli ex combattenti, attraversa il paese. I lavoratori manifestano davanti a Nullo Baldini (1862-1945), storico dirigente delle cooperative ravennati, la loro fede nel socialismo e nella libertà. In tutta la provincia infuria il terrorismo fascista, si verificano scontri e agguati con morti e feriti. Nella frazione di Ponte Rivabella (Monte San Pietro), alcuni fascisti, nascosti dietro una siepe, sparano sulla folla, uccidendo due fratelli e ferendo gravemente altre sette persone. A Linaro di Imola, durante la Festa del Lavoro, è ucciso l'operaio comunista Luigi Trombetti e quattro manifestanti rimangono feriti. La reazione tinge di sangue il Calendimaggio è il titolo del giornale socialista "La Squilla".dettagli
-
25 maggio 1922La morte del caposquadra Celestino CavedoniIl 21 maggio a Calderara di Reno scoppiano gravi incidenti tra un gruppo di lavoratori, che intende partecipare a una riunione sindacale, e una squadra di camicie nere di Santa Viola. Gli incidenti si ripetono il 25 maggio: nel pomeriggio centinaia di squadristi, guidati dal segretario del fascio di Santa Viola ed ex capitano di marina Celestino Cavedoni (1890-1922), pongono d'assedio il paese, lanciando bombe a mano contro gli edifici della cooperativa agricola, della cooperativa di consumo e contro la casa del popolo. Alcuni operai vengono feriti. L'intervento dei carabinieri mette in fuga i fascisti, alcuni dei quali vengono arrestati. Nella notte tra il 25 e il 26 maggio Cavedoni, ricercato dalla polizia, sarà ritrovato cadavere in via Battindarno a Bologna. Per i fascisti è “vittima di una bomba tiratagli in pieno petto da due avversari sbucati da una siepe”. Per la polizia e per il prefetto Mori, invece, si è ferito da solo con una bomba a mano durante un attacco alla Cooperativa di Malcantone, nel rione Barca. Dopo la sua morte, Leandro Arpinati costituisce un comitato segreto d'azione e scatena la violenza politica: “Voi fascisti da questo momento siete liberi da ogni vincolo di disciplina; avete anzi l'obbligo di ricordare che ogni esponente dei partiti sovversivi è responsabile di questa situazione; che ogni circolo o bettola cooperativa è un covo ove si meditano e si organizzano le imboscate e gli agguati contro di voi”. Seguono immediati assalti alle cooperative socialiste e alle sedi dell'Ente autonomo dei Consumi. A Mori, che ha smentito la loro versione, i fascisti dichiarano guerra ad oltranza.dettagli
-
27 maggio 1922L'occupazione squadrista di BolognaA seguito del ferimento del vice-comandante della “Sempre Pronti” Guido Oggioni, reduce da una spedizione punitiva alla Bolognina, e della misteriosa morte nel rione Barca del caposquadra Celestino Cavedoni, i fascisti dichiarano guerra aperta ai loro avversari. Prima di cedere il comando delle squadre a un comitato d'azione segreto, Leandro Arpinati proclama i fascisti “liberi da ogni vincolo di disciplina” nel duro confronto con gli esponenti dei cosiddetti “partiti sovversivi”. Il 26 maggio in città fascisti e nazionalisti inscenano una manifestazione contro il prefetto Mori, accusato di favorire i “partiti sovversivi”. Tra grandi acclamazioni parla l'on. Aldo Oviglio, mentre si susseguono cariche della polizia. Vengono danneggiate due sedi socialiste. Fascisti e forze dell'ordine ingaggiano una battaglia “con esplosione di un migliaio di colpi”. La Federazione provinciale del PNF convoca per il 29 una grande riunione dei segretari dei Fasci delle provincie di Bologna, Modena e Ravenna. Un comunicato della Direzione centrale afferma che “la lotta in provincia di Bologna si aggrava, le autorità politiche locali in combutta con i partiti anti-nazionali, tentano di spiantare l'organizzazione politica ed economica del Fascismo. Da questo momento e fino a nuovo ordine i poteri e le mansioni dei fasci, dei direttòri di tutti i fasci della provincia passano ai comitati di azione”. Tra il 27 maggio e il 2 giugno avviene a Bologna una grande concentrazione di squadristi in armi, comandati per l'occasione dai principali dirigenti nazionali e regionali: Michele Bianchi, segretario del PNF venuto appositamente da Milano, Dino Grandi, Italo Balbo, Arpinati e Gino Baroncini. E' bloccata la circolazione dei tram, una ventina di sedi "sovversive" sono prese d'assalto. Tra esse quelle dell'Ente autonomo dei consumi, della Federterra, del Circolo macchinisti e fuochisti di via del Borgo, la redazione dell'"Avanti", i locali del sindacato ferrovieri. La sede della cooperativa “La Sociale” è assalita con bombe incendiarie. Le squadre, provenienti da vari paesi della provincia di Bologna, da Modena, Venezia - la squadra “Serenissima” - e soprattutto da Ferrara - la cosiddetta "colonna di Balbo" - occupano il centro. Circa 10 mila camicie nere bivaccano sotto i portici del Pavaglione, di via Farini e di via Indipendenza, trasformati in veri e propri accampamenti, con distese di paglia e coperte offerte dai cittadini. Si cantano inni patriottici e si fraternizza con la popolazione. “Al tocco di notte nei bivacchi si suona il silenzio, circolano squadre di ronda. Alle sette sveglia”. Nei giorni seguenti i fascisti assediano palazzo d'Accursio e scatenano la guerriglia urbana. Vengono lanciate bombe contro la prefettura, la questura e la Camera del Lavoro. Si vuole impedire la diffusione dei giornali sovversivi, incendiando le edicole e minacciando i gestori. Non si contano le aggressioni individuali, tra cui quella a Clodoveo Bonazzi, segretario della vecchia CdL e al dott. Mario Santandrea, farmacista dei Garganelli. Viene chiesta la destituzione del prefetto Cesare Mori, che ha impiegato la polizia per reprimere le azioni delle squadre durante le manifestazioni dei giorni precedenti. Per questo viene chiamato dai fascisti il "prefettissimo", il "vicerè asiatico" o il "lurido questurino di Cagoia" (Cagoia è il nomignolo dato da D'Annunzio al presidente del consiglio Nitti), gli si grida contro: "Mori, Mori, tu devi morire". Il 28 maggio si tiene alla Sala Borsa una assemblea di industriali, commercianti e esercenti, che appoggiano l'iniziativa fascista e stigmatizzano la condotta di Mori. Il 31 maggio le camicie nere mobilitate in città sono suddivise in cinque compagnie. Nel pomeriggio circa un migliaio di squadristi compiono una spedizione in grande stile nel quartiere operaio della Bolognina, incendiando alcune cooperative rosse e scontrandosi con la forza pubblica. Assalti e distruzioni avvengono anche in molti paesi della provincia: a Molinella, Budrio, Sant'Agata Bolognese. A Castenaso vengono incendiate con la benzina la Cooperativa e la Casa del Popolo. A Borgo Panigale i fascisti feriscono con armi da fuoco alcuni lavoratori socialisti e lanciano una bomba contro la sede della cooperativa “Vita Nuova”, provocando un incendio. Il 1° giugno, mentre le violenze dilagano in tutto il territorio bolognese, il potere è trasferito all'autorità militare. Il generale Sani del Corpo d'Armata patteggia con Italo Balbo, comandante generale dei fascisti emiliani, la fine delle dimostrazioni, in cambio della promessa di un imminente allontanamento del Prefetto. Dopo cinque giorni l'occupazione di Bologna è sospesa su ordine perentorio di Mussolini, soddisfatto per la "magnifica agitazione". Il capo del Fascismo congeda le camicie nere con un telegramma: “La vostra meravigliosa disciplina farà epoca nella storia italiana. Obbedendo oggi acquistate il diritto di comandare domani, per le maggiori fortune della Patria. Vi abbraccio tutti, capi e gregari”. Di ritorno alle loro basi, le squadre compiono ancora violenze. A Lovoleto i fascisti ferraresi, dopo aver portato via una grande quantità di generi alimentari, incendiano la cooperativa di consumo. A Granarolo invadono il paese e appiccano il fuoco alla Casa del Popolo. A Bagnarola, nei pressi di Molinella, i fascisti subiscono “qualche molestia dagli avversari” e “alle provocazioni rispondono”. Il governo richiama il prefetto Mori nella capitale in previsione del suo trasferimento. La sua determinazione nel tener testa agli squadristi sarà comunque apprezzata da Mussolini, che lo invierà nel 1924 in Sicilia a debellare la mafia: passerà alla storia come "il prefetto di ferro". Nel suo diario, Italo Balbo (1896-1940), colui che ha creato e promosso la diffusione dello squadrismo agrario, stimerà in circa 60 mila i fascisti impegnati a turno nell'occupazione di Bologna, definita "prova generale della rivoluzione", da ripetere con forze più vaste sul piano nazionale.dettagli
-
27 ottobre 1922Mentre è in corso la marcia su Roma la Decima Legio occupa la cittàAlla vigilia della marcia su Roma i fascisti, affiancati dagli Arditi, prendono possesso di Bologna manu militari. Le camicie nere bolognesi sono divise in tredici coorti, raggruppate in due legioni, una per la città e una per la provincia, al comando di Umberto Baccolini e Gino Baroncini. Nella serata del 27 ottobre convengono in città più di duemila uomini. Il Prefetto fa presidiare dalle forze dell'ordine Piazza Maggiore e i principali edifici pubblici. L'esercito è consegnato nelle caserme. Il mattino del 28 le squadre si concentrano nelle sedi centrali del partito, in via Marsala e in via Saffi. Viene occupata la ferrovia e circa trenta fascisti, arrestati nei giorni precedenti, sono liberati dal carcere con un colpo di mano architettato da Leandro Arpinati e Giancarlo Nannini. In via Zamboni alcuni fascisti armati fermano gli agenti Paolo Vitalone e Carmelo Pancaldi in servizio di ronda e intimano loro di consegnare le pistole. Si scatena una sparatoria nella quale le guardie e uno degli aggressori rimangono feriti. Vitalone morirà il giorno dopo all'ospedale, lo squadrista Mario Carlo Becocci il 4 novembre. Mentre nel pomeriggio si ha la cessione dei poteri all'autorità militare, i fascisti occupano i magazzini dell'Associazione tubercolotici di guerra di Borgo Panigale, disarmando i militari di guardia. Alla Direzione centrale automobilistica si impossessano di quattro mitragliatrici. La terza coorte, guidata da Arconovaldo Bonacorsi, attacca il campo d'aviazione dei Prati di Caprara. Gli assalitori sono respinti dai soldati di guardia e non riescono ad accedere ai depositi di artiglieria e munizioni. Lasciano sul campo due feriti. Lo sgombero totale dell'aeroporto viene ordinato entro l'alba del giorno seguente. Durante i disordini di queste convulse giornate trovano la morte gli squadristi Giovanni Bisetti e Athos Vezzali. Il 29 ottobre viene devastata la roccaforte socialista di Molinella, denunciata dal federale Baroncini come "punto di polarizzazione del sovversivismo bolognese" e considerata una spina nel fianco per il movimento sindacale fascista. Viene invasa e devastata la sede delle cooperative e altri uffici periferici con la dispersione e la confisca dei beni. A Bologna, dopo un incontro con il generale Sani, nuovo pleniopotenziario, i fascisti sfilano in perfetto ordine, inneggiando alle forze armate. Intanto in altre zone della città avvengono scontri sanguinosi con le forze dell'ordine. Durante l'assalto alla caserma dei carabinieri di San Ruffillo, rimangono uccisi l'ex legionario fiumano Oscar Paoletti e lo squadrista Giancarlo Nannini, comandante di una delle coorti di Bologna, che saranno accolti tra i martiri della rivoluzione fascista. Nella stessa occasione sono feriti Giuseppe "Peppino" Ambrosi, "meraviglioso squadrista di tutte le spedizioni più difficili" e l'ardito Giovanni Fantini. In zona sono devastate la biblioteca popolare, l'Azienda Macchine, la cooperativa Muratori. In provincia vengono assaltati e occupati gli uffici di collocamento di Marmorta, San Pietro Capofiume e San Martino in Argine. Diversi dirigenti socialisti sono espulsi dal paese. Il 30 ottobre Mussolini è incaricato di formare il nuovo governo. Il giorno successivo da Bologna i fascisti, che hanno ottenuto il permesso di occupare Palazzo d’Accursio, gli scrivono questo telegramma: “Legioni bolognesi esultanti vittoria presentano le armi al Capo”. Il 3 novembre Arconovaldo Bonacorsi assume il comando del migliaio di squadristi bolognesi presenti a Roma e sfila con loro a Villa Borghese. Tra il 4 e il 5 novembre a Bologna le camicie nere smobilitano e l’autorità militare cede il controllo della città al Prefetto.dettagli
-
7 marzo 1923Umberto Puppini sindacoAl termine del mandato prefettizio di Vittorio Ferrero, che ha gestito il passaggio del Comune all'amministrazione fascista, è eletto sindaco Umberto Puppini (1884-1946), ex combattente e professore di Idraulica alla Scuola d'Ingegneria di Bologna. "Il rispetto di Dio, la devozione alla Patria, l'ossequio all'autorità dello Stato" sono i postulati a cui si ispira l'opera del nuovo sindaco, che non manca, pochi giorni dopo l'insediamento, di criticare aspramente il suo predecessore, il socialista Francesco Zanardi, accusato di aver beneficiato soprattutto "quelli che di beneficenza non hanno bisogno", cioè i residenti delle aree signorili, le cooperative e i partiti "sovversivi". L'obiettivo principale di Puppini è il risanamento del bilancio, ma anche la messa a punto di un piano di interventi urgenti: la sistemazione delle fogne, delle strade, dei fabbricati scolastici. A suo dire Bologna deve essere trasformata da "villaggio agricolo" a moderno centro industriale, anche grazie a sovvenzioni statali. Alle realizzazioni del Comune si affiancheranno, nei mesi seguenti, quelle promosse dal segretario fascista Arpinati: la Casa del Fascio, i Gruppi rionali, i campi sportivi. Ben presto Bologna sarà considerata "esempio unico e inequivocabile" per il fascismo italiano. Puppini ricoprirà la carica sino al 1926, anno in cui i sindaci verranno sostituiti in tutta Italia con podestà di nomina governativa. Sarà in seguito direttore della Scuola d'Ingegneria (1927-32), Sottosegretario alle Finanze (1932-34) e Ministro delle Telecomunicazioni (1934-35). Abbandonerà il fascismo durante la guerra, per ritornare agli studi di idraulica e all'insegnamento. A lui si deve il notevole impulso dato in questi anni all'edilizia universitaria (da citare in particolare lo studio, assieme a Giuseppe Vaccaro, della nuova sede di Ingegneria) e l'interesse per problemi viari quali i collegamenti tra il centro e le nuove periferie. Per i suoi meriti scientifici, sarà insignito del premio dell'Accademia delle Scienze di Parigi.dettagli
-
27 marzo 1923Gino Baroncini a duello con Nello QuiliciLo squadrista Gino Baroncini (1893-1970), acerrimo avversario di Arpinati, inizia una dura contesa personale con Filippo Naldi (1886-1972), amministratore delegato del “Resto del Carlino”, e con il suo direttore, Nello Quilici (1890-1940). Il 27 marzo Baroncini e Quilici arrivano a battersi a duello. Il motivo della lite è spiegato dal primo sulle colonne de "L’Assalto": occorre un "supplemento di rivoluzione", anche con l'uso del manganello, per liberare il "Carlino" dalla cricca di affaristi che lo controllano e per farne l'organo portavoce del fascismo bolognese. Sullo sfondo c’è anche l’aggiudicazione, anelata da Naldi, dell'appalto milionario per la costruzione della ferrovia Direttissima. Pressati dalle intimidazioni fasciste, nel giro di alcuni mesi sia Quilici che Naldi lasceranno il giornale. Tuttavia Baroncini non godrà il frutto delle sue sopraffazioni. Entrato in rotta con Dino Grandi e con Italo Balbo, potenti ras emiliani in piena auge nell'élite del fascismo, sarà dimesso entro la fine del 1923 dalla carica di segretario della federazione bolognese - sostituiro temporaneamente da Edoardo Rotigliano (1880-1963) - e da quella di commissario politico per l'Emilia-Romagna. Dovrà lasciare inoltre la direzione dell’”Assalto” nelle mani di Giorgio Pini. In seguito si impiegherà nelle Assicurazioni Generali di Trieste e diventerà il braccio destro del presidente Edgardo Morpurgo. Nonostante il suo passato di implacabile squadrista, rimarrà alla guida delle Generali anche nel dopoguerra.dettagli
-
27 aprile 1923Con Arpinati l'Istituto Case Popolari costruisce case a riscattoLeandro Arpinati viene nominato dal Consiglio comunale Presidente dell'Istituto Case Popolari. L'attività costruttiva dell'istituto riprende a pieno ritmo dopo la stasi bellica, grazie anche al credito economico e politico di cui gode il ras bolognese. Arpinati rivendicherà di lì a poco, anche nei confronti del Comune, la massima autonomia decisionale nell'assegnazione degli alloggi, che andranno, "con assoluta priorità", agli ex combattenti e alle vedove di guerra. Dal marzo 1926 l'Istituto, presieduto dall'ing. Tabarroni, già vice di Arpinati, potrà usufruire di cospicui contributi governativi per la costruzione di case "con patto di futura vendita" (Legge 386/1926) e, fino al 1930, la casa in proprietà per i ceti medi diverrà l'unico suo obiettivo.dettagli
-
9 agosto 1923Uccisione di Pietro Marani a MarmortaNella zona di Molinella le leghe rivendicano l'applicazione del concordato Paglia-Calda e non vogliono firmare il patto colonico fascista. Per piegare i socialisti, il ras fascista Augusto Regazzi, fondatore del fascio locale e rappresentante dei possidenti terrieri, instaura un regime di terrore, con agguati, bastonature e violenze di ogni tipo. Viene presa di mira in particolare la famiglia Marani di Marmorta, i cui componenti sono socialisti e dirigenti della lega di miglioramento. Il 9 agosto una squadra di picchiatori guidata da Regazzi bastona un gruppo di antifascisti a Berrà e quindi prende d'assalto l'abitazione di Pietro Marani nella tenuta Bosco di Ornan Talon. Ai tentativi di intromissione dei fascisti si risponde dalla casa con spari e allora Regazzi sale sul tetto, pratica uno squarcio nel coperto e penetra all'interno, uccidendo il mezzadro ventiseienne a colpi di fucile. Il 12 agosto "ignoti malfattori" lanceranno due bombe: una contro la sede del Fascio di Molinella, l'altra contro la casa di un fascista. Seguiranno ancora scontri tra fascisti e socialisti con bastonature e colpi d'arma da fuoco. Recatosi a Molinella, il segretario della federazione provinciale fascista Baroncini farà pubblicare un ultimatum, proclamando un tregua di 48 ore per permettere "agli organizzati aderenti alle leghe socialiste" di fare atto di sottomissione e "desistere da ogni resistenza ingiustificata e criminosa". Inseguito da un mandato di cattura per l’assassinio di Marani, Augusto Regazzi sarà protetto dai ras del fascismo bolognese Grandi e Arpinati. Il suo arresto sarà a lungo sospeso per evitare “conseguenze vivissime, addirittura disastrose”, con il ritorno di Molinella “nel caos completo”. Al processo, che finalmente verrà celebrato nel 1925, sarà assolto con formula piena e potrà tornare trionfalmente a Molinella, mentre la famiglia Marani subirà lo sfratto dal suo podere. Regazzi continuerà a provocare incidenti a Molinella e dintorni con l’aiuto degli squadristi di Ferrara e Ravenna. I suoi metodi e il suo protagonismo andranno però a contrastare con la politica della Federazione Provinciale e nell’ottobre del 1928 Arpinati lo destituirà dalla carica di segretario politico del Fascio. Negli anni seguenti sarà più volte arrestato e nel 1932 internato per alcune settimane nel manicomio di Bologna, prima di essere inviato al confino alle isole Tremiti. Rientrerà nel PNF solo nel 1935, dopo la caduta del suo personale nemico.dettagli
-
28 ottobre 1923La Casa del Fascio e i Gruppi rionaliBologna è una delle prime città in Italia a dotarsi della Casa del Fascio, istituzione nata per consolidare e propagandare il movimento mussoliniano dopo la sua costituzione in partito politico. All'inizio del 1922 il segretario Arpinati sceglie un antico edificio del centro, palazzo Ghisilardi-Fava (o Palazzo Fava Ghisilardi), di proprietà del Comune e ne affida il restauro all'architetto Giulio Ulisse Arata (1881-1962). La ristrutturazione comporterà gravi manomissioni e alterazioni degli spazi interni e la rimozione e la perdita di numerosi resti archeologici (sul luogo si trovava anticamente un castello e poi il palazzo comitale). Lo storico dell'arte Francesco Malaguzzi Valeri loderà comunque - in un articolo apparso nel 1926 sul "Resto del Carlino" - il risultato ottenuto dal Podestà "nel ripristinare il bel palazzo quattrocentesco del Fascio di Bologna, nel ridarvi alla luce e all'arte saloni, soffitti originali, decorazioni". In breve tempo la Casa diventa la vera e propria centrale operativa del fascismo bolognese. Vi trovano sede, oltre al partito, l'Università Fascista, inaugurata il 29 ottobre 1924 (diventerà in seguito Istituto di cultura fascista), la cappella votiva dei Martiri fascisti (poi anche dei caduti in Africa e in Spagna), la biblioteca, inaugurata il 1° marzo 1925, la redazione del periodico "L'Assalto" e del mensile "Vita Nova". Sono ospitate inoltre importanti federazioni sportive, che fanno capo ad Arpinati, la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), e inoltre l’Ispettorato sportivo delle scuole medie, il GUF, la sede dell'Opera Nazionale Balilla (ONB). Vi saranno un ufficio postale e telegrafico, un ristorante e un albergo diurno, "il più grande, il più moderno e il più completo fra gli esistenti in Italia", con quaranta gabinetti, saloni da barbiere, parrucchiere per signora, depositi bagagli. A supportare l'attività del partito fascista vengono inoltre istituiti i Gruppi rionali (o Circoli rionali), intitolati ai martiri fascisti. Saranno quattordici nel 1938, ognuno guidato da un gerarca locale, il Fiduciario, e dotato di una propria sede nella periferia cittadina. Le sedi sono a volte ex case del popolo requisite alle organizzazioni di sinistra, altre volte sono costruzioni apposite, come quella in via Matteotti (poi Teatro Testoni), edificata grazie a una sottoscrizione obbligatoria tra gli abitanti della Bolognina. Tra le sedi più connotate è quella del nucleo Malcantone del Gruppo Meloncello, che ha il portone sormontato da due enormi fasci disegnati dall'ing. Gasparri, impegnato in zona Ghisello nella costruzione della Funivia. Il GR di via San Mamolo sarà in un primo tempo intitolato allo stesso Arpinati. Cambierà denominazione (GR "Mario Becocci") nel 1933, dopo la sua caduta in disgrazia. Secondo Torquato Nanni, amico e agiografo del segretario, i gruppi rionali sono "il segreto della coesione e della disciplina" del fascismo bolognese, attraverso i quali esso ha "un quotidiano e metodico contatto col popolo". All'interno della sede, vera e propria "casa dell'operaio", si possono trovare l'ambulatorio medico, una piccola biblioteca, la sala cinematografica, l'asilo e la cooperativa. Qui lo squadrista eleva il proprio spirito e "diventa un prezioso elemento di ordine sociale". In sostanza i GR sono una “continuazione della tradizione socialista delle strutture ricreative e mutualistiche, rinnovata sotto un diverso vessillo e subordinata in ogni necessità alla Casa del fascio” (Trocchi)dettagli
-
29 ottobre 1923Mussolini a BolognaBenito Mussolini è in città nella mattinata del 29 ottobre, nell'ambito delle celebrazioni del primo anniversario della Marcia su Roma. E' accolto alla stazione da numerose schiere di Fasci e Sindacati. Poi il corteo delle auto si avvia verso il centro, tra le squadre allineate in via Indipendenza, via Rizzoli e via Zamboni. Vestito in borghese, con la bombetta in testa e l'impermeabile sulla camicia nera, il duce si alza più volte per salutare la folla esultante, stando in piedi sull'auto decappottabile guidata personalmente da Leandro Arpinati, capo dei fascisti bolognesi. Prima di recarsi al Teatro Comunale, dove sarà accolto dalle autorità cittadine e ascolterà il discorso del sottosegretario Acerbo, Mussolini si reca a San Ruffillo per scoprire una lapide in onore Oscar Paoletti e Giancarlo Nannini, due giovani "martiri" fascisti, caduti nei giorni della Marcia su Roma. Nel pomeriggio il Duce visita l'Istituto Ortopedico Rizzoli, ricevuto dal Presidente prof. Giovanni Pini e dal prof. Vittorio Putti, responsabile medico. Qui si intrattiene soprattutto con i numerosi mutilati ricoverati. In occasione della visita, un muratore disoccupato, Marino Tiraboschi, gli dedica questa poesia: O gran Benito che la nostra bella Itagliahai salvato da un grande fallimentonessuno certamente al mondo si sbagliase al cuore ti innalza un monumento. Tu hai disperso tutta la canagliadei lennini che avevvano la bandiera rossa al vento:che hanno mangiato persino la fratagliadei bovi e delle vacche in un momento. Splende di nuovo d'Itaglia la stellaperché con coraggio e fede che mancavaha giuntato dell'oglio alla fiammellacosì la patria nostra si salvava. Sia gloria a te che hai fatto l'Itaglia belladandogli il posto che in Europa ci aspettava.dettagli
-
5 dicembre 1923Proteste contro la riforma GentileIl 5 dicembre gli studenti universitari dell’Alma Mater iniziano una protesta contro la riforma voluta dal ministro della pubblica istruzione Giovanni Gentile (1875-1944), che Mussolini ha definito “la più fascista delle riforme”. Sono preoccupati soprattutto per l’introduzione dell’esame di stato abilitante alle professioni, che ritarda l’ingresso al lavoro. La riforma aumenta inoltre le tasse universitarie, penalizzando le famiglie più povere, e riduce le sessioni di esame: si va dunque verso un modello di università ancora più elitario e antidemocratico di quello esistente. Il Fascio considera oppositori del governo tutti i critici della riforma e contrasta fin dall’inizio l’iniziativa studentesca, imponendo l’astensione degli iscritti al GUF e promettendo misure disciplinari. Anche agli studenti cattolici della FUCI viene data l’indicazione di non partecipare alle proteste. L’agitazione a Bologna rientra rapidamente e già l’11 dicembre il neo rettore Pasquale Sfameni può annunciare con soddisfazione al ministro che la situazione è tornata tranquilla. All’inizio del 1924 i vertici del GUF bolognese saranno modificati in base agli ordini della Segreteria generale della Federazione Nazionale Universitaria Fascista (F.N.U.F.). Leandro Arpinati sarà designato commissario straordinario.dettagli
-
1924La biblioteca della Casa del FascioCollocata in un prestigioso salone rinascimentale, è inaugurata la biblioteca della Casa del Fascio. E' aperta al pubblico per 12 ore al giorno, dalle 12 alle 24. E' accessibile a tutti e contiene un notevole patrimonio di periodici e opere generali. Secondo il promotore Arpinati, essa deve essere “ricca e varia, perchè il Fascismo crede profondamente nel sapere, che deve essere una ragione italica nelle civiltà”. Assieme all'Università fascista e alle conferenze di cultura politica, la biblioteca è il luogo deputato all'educazione dei giovani.dettagli
-
marzo 1924Arpinati reggente del Fascio cittadinoDopo le dimissioni di Gino Baroncini da segretario federale nel dicembre 1923 e la cooptazione di Dino Grandi nell'area governativa, Leandro Arpinati diventa il capo incontrastato del fascismo a Bologna. Nel marzo 1924, dopo alcuni mesi di commissariamento da parte di Edoardo Rotigliano, viene eletto reggente della Federazione provinciale e l'anno seguente ne diventa segretario. Nello stesso periodo assume anche cariche nazionali: è eletto deputato, membro del Gran Consiglio del fascismo e del Direttorio.dettagli
-
6 aprile 1924Elezioni politiche in un clima di violenzaIl 6 aprile si tengono in Italia le elezioni politiche. Il fascismo vuole legittimare appieno il suo potere e Mussolini sceglie di accogliere nella sua Lista Nazionale (chiamata anche "il listone") personalità di prestigio dello schieramento conservatore e liberale. In precedenza è stata approvata la cosiddetta legge Acerbo - definita da Filippo Turati “la legge di tutte le paure e di tutte le viltà” - che in nome della governabilità assegna i 2/3 dei seggi alla lista più votata sul piano nazionale. La campagna elettorale si è aperta in gennaio a Roma con la prima grande adunata fascista davanti a Palazzo Venezia. E' proseguita in tutto il paese in un clima di intimidazione e di violenza. Soprattutto nei piccoli centri, squadre di camicie nere hanno impedito i comizi e le affissioni dei partiti d'opposizione. Il giorno delle elezioni i seggi sono presieduti da picchetti di fascisti armati. In Emilia, come altrove, molti cittadini che si recano al voto vengono minacciati e aggrediti. A Imola è ucciso l'elettore comunista Luigi Cervellati. A Molinella il bracciante Angelo Gaiani, che ha dichiarato pubblicamente di aver votato socialista, è bastonato a morte all'uscita dal seggio. Nella provincia il PSI 11.993, i socialisti riformisti 7.943, il PPI 6.504. I comunisti contano poco più di 4.000 voti. Il PNF ottiene 111.112 voti e manda alla Camera Leandro Arpinati, Aldo Oviglio e Dino Grandi. I brogli e le intimidazioni delle camicie nere durante le elezioni saranno denunciati il 30 maggio in Parlamento dal deputato socialista Giacomo Matteotti (1885-1924), che pochi giorni dopo verrà rapito e assassinato.dettagli
-
10 agosto 1924Raid politico-sportivo da Bologna a RomaUna colonna di ventuno automobili, ognuna recante un cartello giallo con il nome di un “caduto per la rivoluzione” e una bandiera tricolore che spunta dal finestrino, parte da Bologna per Roma per portare sostegno a Mussolini, in difficoltà dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti. Il raid è organizzato dagli ex squadristi Bonaccorsi, Ambrosi, Marchesini e dal federale Leandro Arpinati (1892-1945), che coglie ogni occasione per mobilitare i fascisti in ambito sportivo e paramilitare.dettagli
-
1925Progetto Rizzoli per il quartiere universitarioL’ingegnere capo del Genio civile Gustavo Rizzoli presenta al rettore Sfameni un piano per l’assetto degli istituti universitari. Esso riprende il progetto della creazione di un quartiere universitario, già avviato con la Convenzione del 1910 e interrotto dalla guerra. Il piano Rizzoli diverrà operativo qualche anno più tardi, su impulso del podestà Arpinati, nominato nel 1929 sottosegretario agli Interni. L'ing. Rizzoli, direttore dell'ufficio tecnico del Consorzio per gli edifici universitari di Bologna (legge n. 488/1930) fino al 1948 e responsabile, dal 1945, della Sezione distaccata del Genio Civile presso l'amministrazione universitaria, coordinerà nel dopoguerra i lavori del piano di ricostruzione. Sarà infine riconosciuto collaboratore benemerito dell'Alma Mater.dettagli
-
3 gennaio 1925Devastati gli studi di noti avvocati e le sedi del Partito PopolareIl 3 gennaio, alla Camera dei Deputati, Mussolini si assume la piena responsabilità politica e morale del delitto Matteotti (10 giugno 1924) e dell'illegalismo fascista. Nella notte a Bologna squadre fasciste guidate da Arconovaldo Bonacorsi (o Bonaccorsi, 1898-1962) e Peppino Ambrosi devastano gli studi di alcuni noti avvocati vicini all'opposizione: Mario Bergamo, Dante Calabri, Eugenio e Mario Jacchia, Giulio Zanardi. Pluridecorato in guerra, Mario Jacchia (1896-1944) reagisce estraendo una pistola e cominciando a sparare contro i fascisti. Per l'uso dell'arma verrà arrestato e da quel giorno inizieranno le persecuzioni contro di lui. In città e provincia sono assaltate sedi sindacali e politiche e sequestrati con la forza i giornali antifascisti o quelli che, come il “Resto del Carlino”, hanno espresso indignazione per l'uccisione del deputato socialista. Gli squadristi penetrano nella sede del Partito Popolare e in quella dell'Unione del Lavoro in via Marsala e nella redazione del settimanale "Il Mulo" in via Oberdan. Vengono incendiati mobili e documenti. A seguito delle violenze i consiglieri comunali popolari si dimettono. Lo squadrista Bonacorsi propone di dare "solidarietà ai così detti Fascisti devastatori", approvando le dimissioni dei popolari, rei di essere "in losca combutta sul colle dell'Aventino" con le "vecchie baldracche social-comuniste", che tramano contro la Patria. Arpinati, sulle colonne dell’ “Assalto”, giustifica le aggressioni contro i professionisti, che nei loro studi fanno politica contro il governo. Di diversa opinione sono Dino Grandi, sottosegretario all’Interno, che scrive al Prefetto deplorando gli eventi, e soprattutto Aldo Oviglio, che dà finalmente seguito alle minacce di dimissioni espresse dopo il delitto Matteotti.dettagli
-
17 febbraio 1925Il “Resto del Carlino” passa sotto il controllo della federazione fascistTomaso Monicelli (1883-1946), uomo di fiducia degli industriali saccariferi genovesi proprietari del “Resto del Carlino”, riceve ripetute minacce da parte di Arpinati e Baroncini dalle colonne dell’ “Assalto”. I manganellatori radicali lo chiamano “Tomaso-Testa di Vipera”, “Giuda Monicelli”, “Pescecane del giornalismo senza fede” . Dopo che il 17 febbraio un’incursione nella sede di piazza Calderini da parte di una squadra di fascisti provoca una trentina di feriti, Monicelli è costretto a cedere il “glorioso” giornale nelle mani di uomini graditi a Mussolini. Leandro Arpinati (1892-1945) è in seguito eletto consigliere delegato dietro lauto compenso e il 4 marzo 1927 diventa proprietario del “Carlino” - secondo altri solo consegnatario pro tempore “per conto del Fascio di Bologna” - grazie a un contributo di due milioni in azioni da parte del senatore Edoardo Agnelli (1892-1935). Assieme ad Arnaldo Mussolini (1885-1931) cercherà di salvare il giornale dalle gravi difficoltà finanziarie che lo opprimono. Il fratello del Duce, e Presidente del Consiglio di Amministrazione, manovra da tempo per farne “il giornale del fascismo bolognese”.dettagli
-
6 marzo 1925Assoluzione del capo squadrista Augusto RegazziLa Corte d’Assise di Bologna assolve il capo squadrista Augusto Regazzi, direttore della repressione contro i socialisti nella Bassa bolognese e autore di numerosi delitti. Proveniente da una famiglia di agrari, si è distinto tra i più temibili e violenti squadristi emiliani. Prima di divenire Segretario del Fascio di Molinella è stato condannato per percosse e ferite e accusato di frode in rifornimenti militari (assolto per insufficienza di prove). Il 9 agosto 1923, durante una spedizione punitiva a Marmorta, ha ucciso a colpi di fucile il contadino Pietro Marani - uno degli agitatori dei coloni per l'applicazione del concordato Paglia-Calda - dopo che una squadra di quaranta fascisti è penetrata nel suo casolare, sfondando le porte e il tetto. In suo favore è intervenuto il sottosegretario all’Interno Finzi, invitando il gurdasigilli Oviglio a derubricare l’accusa di omicidio per evitare che "conseguenze vivissime, addirittura disastrose" annullassero "i meravigliosi risultati raggiunti a Molinella", dove al "caos completo" determinato dai socialisti era subentrato l’ordine imposto dai fascisti. La “scandalosa” assoluzione con formula ampia di Regazzi e dei suoi complici è festeggiata dai fascisti all’uscita dal tribunale. Regazzi rimarrà come ras di Molinella fino al 1928. In seguito la rivalità con Arpinati lo farà cadere in disgrazia e per qualche tempo sarà rinchiuso in carcere e in manicomio. Nel 1935 verrà reintegrato nel partito fascista e affiancherà Arconovaldo Bonaccorsi nella conquista delle isole Baleari per conto del caudillo Francisco Franco.dettagli
-
15 marzo 1925“Vita Nova”, mensile dell’Università fascistaEsce il periodico mensile “Vita Nova”, diretto da Giuseppe Saitta (1881-1965), filosofo idealista e allievo di Giuseppe Gentile. È espressione di un gruppo di intellettuali fascisti, soprattutto ex liberali, quali Giuseppe Albini, Giuseppe Lipparini, Dante Manetti, Frank De Morsier. Pubblica, inoltre, gli atti dell’Università fascista bolognese, fondata all’inizio dell’anno da Leandro Arpinati sul modello delle vecchie università popolari. La rivista e l’Università hanno sede presso la Casa del Fascio di Palazzo Fava. “Vita Nova” non avrà in sostanza un grande peso sulla vita culturale della città e crollerà assieme al suo promotore Arpinati.dettagli
-
31 marzo 1925La Scuola Superiore di Educazione FisicaCon la riforma scolastica di Giuseppe Gentile vengono soppressi gli Istituti di Magistero di Educazione Fisica di Roma, Torino e Napoli e l'educazione fisica è assegnata ad un ente autonomo, l'ENEF (Ente Nazionale per l'Educazione Fisica). Questo ente affida ad alcune Università l'incarico della preparazione del proprio personale insegnante. Il progetto per un nuovo Istituto Superiore Nazionale di Magistero per la Educazione Fisica - il primo e unico universitario in Italia - è presentato a Bologna da Giuseppe Monti (1861-1938). Ex allievo di Baumann alla Virtus, libero docente in educazione fisica della Facoltà di medicina, egli riversa qui l'esperienza dell'Istituto di Magistero di Torino e della Scuola superiore di educazione fisica aperta a Berlino nel 1920. Ottenuto un finanziamento governativo, la Scuola viene inaugurata il 31 marzo, alla presenza di Arpinati. E’ previsto (ma poi non realizzato) un apposito edificio, nell’area del nuovo impianto polisportivo del Littoriale. Diretto da Donato Ottolenghi (1874-1942), con Monti vice-direttore, l’istituto ha come obiettivo la formazione degli "educatori del fisico", soprattutto in ambito medico. Deve inoltre provvedere alla cultura fisica degli studenti universitari. Dal 1° febbraio 1926 sarà avviato un corso magistrale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'EF nelle scuole del Regno. Verranno in seguito proposti altri corsi complementari per maestri, istruttori di associazioni, docenti delle scuole medie. Il bilancio del primo anno sarà molto lusinghiero, con allievi provenienti da 47 province italiane, alcuni anche dalle isole. La Scuola bolognese avrà tuttavia vita breve. Con l'abolizione dell'ENEF e la creazione dell'Opera Nazionale Balilla (ONB), verrà sostituita dall'Accademia fascista di educazione fisica e giovanile, che aprirà nel 1928 a Roma presso il Foro Mussolini.dettagli
-
12 giugno 1925Il re inaugura il Lapidario dei caduti in guerra e pone la prima pietra del LittorialeRe Vittorio Emanuele III è in visita a Bologna nell’ambito delle celebrazioni per il venticinquesimo anno dalla sua ascesa al trono. Nel chiostro della basilica di Santo Stefano - dove ha sede l'Associazione fra le madri e vedove dei caduti - inaugura il Lapidario (o Lapidarium) dei bolognesi scomparsi in guerra, sistemato a cura dell'arch. Edoardo Collamarini. Nelle 64 lapidi in terracotta murate sotto l'ampio porticato sono incisi 2.536 nomi, quelli di tanti giovani morti senza conforto "nel duro letto di un ospedale o nel chiuso vallo della trincea" durante la Prima Guerra Mondiale (1915-1918). In seguito verranno aggiunti altri 2.059 caduti nella Seconda Guerra Mondiale (1940-1945). Nel 1932 sarà ricavato un nuovo accesso - Portale della Vittoria - che collegherà direttamente piazza Santo Stefano al chiostro del Lapidario. Nel realizzare il giardinetto di accesso, saranno abbattute le antiche case a ridosso della chiesa. Lo stesso giorno dell'inaugurazione del sacrario di Santo Stefano, Vittorio Emanuele III assiste, sul campo della Virtus al Ravone, a un saggio ginnastico offerto da oltre mille alunni delle scuole di Bologna. Il campo sportivo, ornato di festoni e bandiere, ha un aspetto imponente che il Re non manca di sottolineare, complimentandosi con il presidente virtussino Buriani. Infine nell’area - poco lontana - occupata un tempo dal tiro a segno il sovrano dà il via ai lavori del Littoriale. Accolto da “falangi di camicie nere inquadrate perfettamente” assiste al discorso di Arpinati e alla benedizione della prima pietra da parte dell’Arcivescovo, quindi firma la pergamena che verrà calata nelle fondamenta. Alle 17 circa il Re lascia Bologna, diretto a Casalecchio di Reno per l’inaugurazione del nuovo monumento ai caduti della prima guerra mondiale.dettagli
-
dicembre 1925La Federazione Italiana Sport Atletici si trasferisce a BolognaIl Congresso federale, che si tiene a Roma ai primi di dicembre, sceglie Bologna come sede della Federazione Italiana Sport Atletici (FISA). Alberto Buriani, nume tutelare della Virtus, è nominato presidente, mentre la carica di vice-presidente è assunta da Leandro Arpinati, membro del Consiglio Nazionale del Partito Fascista. La giunta esecutiva è interamente composta da soci virtussini. Nel febbraio 1927, dopo l'approvazione della Carta dello Sport (il nuovo statuto del CONI), che sancirà il controllo dello Stato su ogni istituzione sportiva, Arpinati sarà chiamato a dirigere la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), subentrando a Buriani. Il ras fascista bolognese sarà anche alla guida della Federazione Italiana del Giuoco del Calcio (FIGC) e avrà promosso la costruzione del nuovo grande stadio del Littoriale.dettagli
-
1926Le case per gli "umili"L'Amministrazione comunale cede all'Istituto Case Popolari un'area piuttosto disagiata fuori porta San Vitale, limitata dai binari ferroviari, per la costruzione di case per gli “umili”, cioè per quelle persone di bassa condizione, che abitando nei tuguri del centro cittadino “ne impediscono lo sviluppo”. Le case Icp di via Rimesse e di Corticella, consegnate nel 1926, non risolvono comunque il problema dei senza tetto, ospitati dopo la guerra in caserme periferiche o nell'ex ospedale del Baraccato, che viene potenziato con altre trenta baracche. La costruzione di nuove case per gli sfrattati è osteggiata in generale dalla politica ruralista del fascismo, ma anche dalla politica edilizia dell'Icp controllato dal podestà Arpinati, che privilegia, nel corso degli anni Venti, la costruzione di case a riscatto per famiglie piccolo-borghesi.dettagli
-
25 gennaio 1926Dissidenti contro ArpinatiAll’Assemblea del Fascio, che si tiene il 25 gennaio, Leandro Arpinati (1892-1945) è confermato come segretario federale. Alla sera si tiene alla Casa del Fascio una festa in suo onore. Intorno alla mezzanotte entrano con atteggiamento provocatorio alcuni fascisti dissidenti, che vengono subito invitati ad andarsene. Al loro rifiuto, ne nasce una rissa durante la quale vengono sparati anche colpi di pistola. I fascisti dissidenti Armando Zanetti e Renato Zaniboni rimangono feriti. La calma ritorna solo dopo l’intervento della forza pubblica. Il giorno successivo si tiene in città una manifestazione di solidarietà al federale. Circa trecento squadristi filoarpinatiani, provenienti da vari gruppi rionali, convergono verso le 21 alla Casa del Fascio e quindi sfilano per le vie del centro. In via Rizzoli, davanti al Modernissimo, sono affontati da una cinquantina di dissidenti, capitanati da Alberto Cuccoli, nazionalista ed ex segretario della Federazione provinciale dei Sindacati Nazionali. Lo scontro è evitato dall’accorrere della polizia e dello stesso federale Arpinati, in veste di paciere.dettagli
-
31 ottobre 1926Inaugurazione del LittorialeViene solennemente inaugurato l'impianto polisportivo del Littoriale, definito “primo anfiteatro della rivoluzione fascista” e “monumento della nuova epoca”. Il discorso di apertura è tenuto da Benito Mussolini, entrato nell’arena a cavallo, seguito da un corteo di gerarchi e vestito con l'alta uniforme di generale della Milizia. Il Duce rimane impressionato dalla cerimonia, dal grandioso omaggio del fascismo bolognese, che definisce “l’architrave del Fascismo italiano”: “Mai vi fu, io credo, nella storia d’Italia adesione più perfetta tra regime e popolo; mai si ebbe più formidabile rassegna di popolo in armi. Si può dire senza esagerare che la selva dei moschetti oscurava il sole, mentre io sentivo e raccoglievo il palpito della moltitudine sterminata”. Per la rivista “Il Comune di Bologna” il nuovo stadio - uno dei più grandi e moderni d'Europa, capace di 37.000 spettatori - è “veramente degno dell’Impero”. “In un giorno ormai non lontano la giovinezza d’Emilia e Romagna correrà a temprarsi le fisiche energie per meglio, poi, in possanza perfetta di corpo, in purità di spirito (mens sana in corpore sano) servire la Patria, come tutto il giovanile fiore d’Italia converrà, quivi, a disputare premi e orifiamme in gagliarde competizioni sportive d’ogni genere, che proprio completo è il Littoriale, immensa arena onnisportiva, da considerarsi tra le opere ciclopiche più eccelse dell’era fascista”. Il complesso è stato costruito a spese del fascismo felsineo. La Federazione di palazzo Fava, guidata da Leandro Arpinati (1892-1945), ha promosso una colletta tra le aziende cittadine, comprese le residue cooperative socialiste, chiamate a un obolo "spontaneo". Lo stile della struttura è stato ispirato al gerarca bolognese, presidente in carica della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), da una visita alle antiche Terme di Caracalla a Roma. Edificato dall'ingegnere Umberto Costanzini (1897-1968), capo ufficio tecnico della Casa del Fascio, e dall'architetto Giulio Ulisse Arata (1881-1962), con esteso utilizzo di calcestruzzo armato, il complesso costituisce il paradigma del nuovo rinascimento urbano voluto dal ras. Oltre allo stadio, dotato di pista per l'atletica, ospita campi di tennis e due piscine, di cui una - per la prima volta in Italia - al coperto, con posti per il pubblico e una lunghezza (33 metri) “sufficiente per l’omologazione di qualunque record nazionale ed internazionale”. Sotto le gradinate sono state ricavate varie palestre. Di fronte allo stadio si estende l’Antistadio, con un campo per il calcio, pedane e pista di atletica. Secondo Marcello Gallian il Littoriale vale il Colosseo ed è "il primo vero monumento della nuova epoca". In occasione della sua inaugurazione anche il poeta Giuseppe Ungaretti compone un'ode: Or dunque che è?Mutata tu sei civiltà?Questa palestra novellaè la sede più belladi te, Verità? La cerimonia di inaugurazione del Littoriale si tiene a lavori non ancora ultimati. Le foto ufficiali non mostrano le parti incomplete. Arpinati è particolarmente legato al nuovo stadio, che considera, più che un luogo per grandi spettacoli da giorni festivi, "un centro di vitalità, una scuola, una palestra", da cui dovrà scaturire una falange di atleti destinati ai trionfi olimpici, ma anche di "forti soldati temprati a tutte le battaglie della vita nazionale".dettagli
-
31 ottobre 1926Attentato a Mussolini. Linciaggio di Anteo ZamboniAl ritorno dall'inaugurazione del congresso scientifico, tenuta all'Archiginnasio, l'auto di Mussolini, un'Alfa Romeo rossa guidata da Leandro Arpinati, svoltando in via Indipendenza all'altezza del Canton dé Fiori, è fatta oggetto di alcuni colpi di pistola. Il Duce rimane illeso: un proiettile gli ha lacerato la fascia del Gran Cordone Mauriziano - che rimarrà esposta a lungo, come un cimelio, nel negozio Old England dello squadrista Giuseppe Ambrosi - e si è conficcato nell'imbottitura dell'auto. Un gruppo di fascisti si avventa immediatamente sul giovane Anteo Zamboni, studente bolognese di 16 anni, e lo massacra a colpi di pugnale. Tra essi Carlo Alberto Pasolini, padre del poeta Pier Paolo, Arconovaldo Bonacorsi (Bonaccorsi), futuro governatore delle Baleari, Albino Volpi, aministiato per il delitto Matteotti. Più tardi i quadrumviro ferrarese Italo Balbo correrà alla stazione per mostrare al Duce il pugnale insanguinato del linciaggio, proclamando: “Giustizia è fatta”. Nei giorni successivi le squadre fasciste, prendendo a pretesto quanto accaduto a Bologna, compiranno violenze in tutta Italia. A Genova sarà incendiata la sede del giornale socialista "Il Lavoro". A Napoli sarà assaltata la casa del filosofo Benedetto Croce e in Lunigiana quella dell'ex ministro liberale Carlo Sforza. In Veneto saranno devastate numerose sedi di organizzazioni cattoliche. Le indagini sull'attentato porteranno all'arresto e alla condanna del padre, della madre e dei fratelli di Anteo, tutti di fede anarchica. Nel 1932 l'avvocato antifascista Roberto Vighi invierà a Mussolini un lungo memoriale a difesa del padre di Anteo, condannato a trent'anni di carcere con accuse superficiali e incongruenti. Le circostanze dell'attentato rimarranno in gran parte oscure, per ammissione dello stesso Mussolini. Sarà messa in dubbio la paternità del gesto e si ipotizzerà una responsabilità dell'ala radicale del fascismo guidata da Farinacci e dello stesso accompagnatore del duce, Leandro Arpinati. Proprio a seguito dei fatti di Bologna, saranno approvate alcune leggi eccezionali, che sanciranno in Italia l'avvento di un regime dittatoriale. La legge 25 novembre 1926 n. 2008, Provvedimenti per la difesa dello Stato, stabilirà la fine della libertà di pensiero e di stampa, lo scioglimento dei partiti antifascisti, l'istituzione del tribunale speciale per gli oppositori del regime e la reintroduzione della pena di morte.dettagli
-
26 dicembre 1926Leandro Arpinati nominato PodestàLeandro Arpinati è il primo Podestà di Bologna. La carica, di nomina regia, sostituisce quella elettiva di sindaco, in base alla legge 4 febbraio 1926, che prevede il Podestà nei Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, poi estesa a tutti i comuni del Regno con il Decreto legge del 15 aprile 1926. Il 23 dicembre, "tra scroscianti applausi", il sindaco fascista Umberto Puppini ha concesso ad Arpinati la cittadinanza onoraria per la sua "azione pronta e sagace" e le "ardite, geniali iniziative da Lui concepite ed attuate ad affermazione delle idealità di forza e di grandezza della Patria". Il 26 dicembre avviene a Palazzo D'Accursio il passaggio di consegne al nuovo primo cittadino. Nel discorso inaugurale, Arpinati si propone di riportare Bologna tra le grandi città italiane.dettagli
-
1927"Bologna Sportiva" ingloba tutte le associazioni cittadineSu iniziativa di Leandro Arpinati, tutte le società sportive bolognesi vengono riunite in un unico ente, la Società Bologna Sportiva. Il fulcro del nuovo sodalizio è il Bologna Football Club, attorno al quale confluiscono le sezioni delle altre discipline: dall'atletica leggera al nuoto, dalla ginnastica al rugby, dalla scherma al pugilato. I primi anni della nuova società coincidono con l’apice della carriera politica di Arpinati, numero due del fascismo e presidente del Coni. Vi confluiscono, a volte dietro forti pressioni, società prestigiose come la Sempre Avanti!, che rimarrà autonoma fino al 1929. Dopo la caduta in disgrazia di Arpinati, anche Bologna Sportiva entrerà rapidamente in crisi: nell’aprile 1935 la società sarà fusa con la Virtus, mentre la sezione Calcio tornerà ad essere autonoma. La Virtus Bologna Sportiva aprirà le porte all'atletica femminile e avrà tra le sue file campionesse come le olimpioniche e campionesse mondiali Ondina Valla e Claudia Testoni.dettagli
-
6 maggio 1927VI Concorso Ginnastico Nazionale FemminileDal 6 all'8 maggio si tiene a Bologna il VI Concorso Ginnastico Nazionale Femminile, sotto l'alto patronato dei Reali d'Italia. Il Comitato esecutivo è presieduto da Leandro Arpinati, che dopo l'assunzione della carica di Podestà, lascia il compito ai vice Buriani e Ottolenghi, continuando comunque a intervenire presso vari ministeri per ottenere le necessarie concessioni. A Bologna giungono oltre cinquemila ginnaste, un numero mai raggiunto per simili manifestazioni. La sede delle gare avrebbe dovuto essere il Littoriale, da inaugurare per l'occasione all'attività sportiva, ma il terreno non è ancora pronto e occorre ripiegare sul campo della Virtus, mentre per il saggio finale è predisposto il Velodromo. Il 7 maggio alcune delle gare vengono disturbate dalla pioggia e devono essere effettuate nelle palestre cittadine. Alla sera si tiene, con “ottimo successo”, un'accademia al Teatro del Corso. Il pomeriggio dell'8 le squadre si radunano in Piazza VIII Agosto e si dirigono in corteo, “fra due ali di popolo plaudente”, verso il Velodromo. Il saggio finale, al cospetto del Principe di Piemonte, riesce “solenne, imponente, commovente”. Il merito maggiore del Concorso e della sua ottima riuscita va al prof. Giuseppe Monti, promotore della candidatura bolognese e ideatore degli esercizi ginnici. Con lui hanno collaborato i componenti della nuova Scuola Superiore di Educazione Fisica di Bologna e le società ginnastiche cittadine.dettagli
-
15 giugno 1927Variante al Piano Regolatore del 1889Il podestà Arpinati sovrintende a una corposa Variante del Piano Regolatore del 1889, in parte non compiuto. Il nuovo progetto prevede il riordino del quartiere universitario, l'allargamento di via Ugo Bassi, l'edificazione di una città giardino nei pressi del Littoriale e consistenti lavori sul canale di Reno. E' prevista inoltre l'apertura di una nuova grande arteria dalle due torri a palazzo Bentivoglio sul tracciato di via dell'Inferno (proposta Muggia-Evangelisti) e l'edificazione della nuova via Roma - poi via Marconi - sul tracciato dell'angusta via delle Casse, tra via San Felice e gli Orti Garagnani. La variante contempla altresì l'aggregazione di Borgo Panigale, di San Lazzaro di Savena e di Casalecchio di Reno alla città, per creare la "grande Bologna".dettagli
-
31 agosto 1927Campionati europei di nuoto al LittorialeDal 31 agosto al 4 settembre si tengono nella piscina del Littoriale i campionati europei di nuoto, water polo (pallanuoto) e tuffi. Protagonista assoluto in campo maschile lo svedese Arne Borg, vincitore dei 100, 400 e 1.500 stile libero, mentre tra le donne trionfano atlete olandesi. Il migliore risultato per gli azzurri è quello di Giuseppe Perentin, secondo nei 1500 s.l. con il nuovo record italiano. Notevole è lo sforzo organizzativo per promuovere la massima partecipazione del pubblico. In occasione dei campionati sono concessi sconti ferroviari, tram gratuito e l'accesso libero ai musei cittadini. Le nuove piscine del Littoriale appaiono tra le migliori d'Europa. Quella coperta sarà a lungo l'unica in Italia riscaldata nella stagione invernale. Vi si può accedere al prezzo di 2 lire e vi sono biglietti combinati per bagno e percorso tramviario andata e ritorno. Una cartolina pubblicitaria dichiara che la piscina del Littoriale "offre una palestra di nuoto impareggiabile" e che l'acqua, "disinfettata giornalmente", è "immune da qualsiasi bacillo". In questo impianto si terranno anche i Campionati italiani Assoluti, nel 1927 e dal 1930 al 1932, in occasione della presidenza FIN di Leandro Arpinati.dettagli
-
7 settembre 1927Il IX Congresso Eucaristico NazionaleDal 7 all'11 settembre si tiene a Bologna il IX Congresso Eucaristico Nazionale. L'evento è preparato nei minimi dettagli. Un comitato alloggi cura l'accoglienza nelle case private di migliaia di congressisti, che possono anche consumarvi i pasti pagando con appositi buoni. Il 6 settembre un imponente corteo segna l'ingresso in città delle autorità, tra cui il cardinale legato Tommaso Pio Boggiani, che siede, tra il cardinale arcivescovo Nasalli Rocca e il podestà Arpinati, sulla berlina di gala che aveva già ospitato Prospero Lambertini in procinto di divenire papa Benedetto XIV. In piazza XX Settembre, luogo dell'incontro con il cardinale legato, sull'asse dei viali è innalzato un gigantesco arco trionfale. La via Indipendenza, gremita di folla e pavesata a festa, "anche questa volta non vuole smentire la sua qualità di principale arteria cittadina". Il 10 settembre, durante il solenne Pontificale allo stadio Littoriale, 10.000 bambini delle scuole elementari cantano la Messa degli Angeli del maestro Baruzzi. In piazza VIII Agosto un palco per il cardinale copre “opportunamente” il monumento che ricorda la cacciata degli austriaci nel 1848. Di notte i principali monumenti cittadini sono coronati di luci. La torre Asinelli è sormontata da un grande fascio littorio illuminato. Le speranze per il nuovo corso del Bel Paese risuonano nelle parole dell’inno ufficiale: O Dio nascoso, innumereturbe al tuo piede oranti,per la ridesta Italialevan la speme e i canti:rifiorirà ne' secolibella di Fede e Amor Il congresso eucaristico ispirerà ad Alfredo Testoni una delle sue più fortunate commedie in vernacolo, El fnester davanti, che andrà in scena al Teatro del Corso il 2 dicembre. Il titolo richiama la frenesia dei bolognesi, che hanno voluto assistere agli eventi in prima fila: “Quando i percorsi dei cortei furono noti, iniziò una corsa pazza alle ‘finestre davanti’. Chi aveva la ventura di possedere finestre o balconi prospicienti sulle vie e sulle piazze predestinate, fu preso d’assedio: parenti, amici, lontani conoscenti, gente conosciuta di sfuggita, magari al mare, si buttarono all’arrembaggio, prenotandosi e combattendo per uno di quei posti privilegiati” (A. Lucchini).dettagli
-
novembre 1927Uno scudetto non assegnato al Bologna FCIl Torino vince il campionato di calcio 1926-1927 con 26 punti, davanti al Bologna con 24. L'ultima sfida tra le due squadre vede prevalere i rossoblu per 5 a 0, con due goal di Schiavio. A torneo concluso scoppia il caso Allemandi, legato a un derby truccato tra Juve e Torino. La squadra granata viene squalificata, ma il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, il bolognese Leandro Arpinati, non se la sente di assegnare lo scudetto ai rossoblu secondi in classifica, per non essere accusato di favoritismi. Il titolo di quest'anno non viene assegnato e rimane quindi vacante.dettagli
-
12 dicembre 1927Esce il quotidiano sportivo "Il Littoriale"Leandro Arpinati (1892-1945), presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio (FGCI) e commissario della Federazione di Atletica Leggera (FIDAL), fonda a Bologna un nuovo giornale sportivo, erede de “Il Corriere dello Sport”, in edicola dal 1924. Il titolo - “Il Littoriale” - è ispirato al nome del grande stadio moderno da lui inaugurato nel 1926. La linea editoriale riflette la politica e la visione dello sport del fascismo: non solo uno svago, “una pratica piacevole per occupare le ore d’ozio, ma un vero e proprio dovere civico”. “Lo sport come dovere di tutti i cittadini; la diffusione e il sostenimento dello sport, come funzione di Stato, nei confronti di tutti i cittadini indistintamente; il disinterresse e la moralità degli sportivi come fine della organizzazione e della propaganda” (Bacci) Presto “Il Littoriale”, espressione della Bologna di Arpinati, culla dello sport, "gloriosa città d'avanguardia, baluardo ferreo dell'Italia mussoliniana, fucina di attivismi eroici", diventerà il secondo quotidiano sportivo nazionale dopo la “Gazzetta dello Sport”, dedicando spazio - oltre al ciclismo e al calcio - anche a sport minori (ad esempio il pugilato). Come la “Gazzetta”, organizzerà eventi sportivi, quali la Gita turistica Bologna-Milano (1928) e la corsa ciclistica Predappio-Roma (1929). La proprietà passerà dalla Società Anonima Pubblicazioni Sportive Italiane alla Federazione Fasci di Combattimento di Bologna. Nel 1929 trasferirà la sua sede a Roma e sarà l'organo ufficiale del CONI. Dopo Arpinati, la direzione passerà all’on. Iti Bacci (1892-1954), vice-segretario del PNF. Nel 1932 sarà ceduto al conte Bonacossa e poi al PNF nazionale. Sotto la direzione di Renato Tassinari, vice-presidente della FIM, aumenteranno notevolmente le pagine dedicate ai motori. “Il Littoriale” verrà stampato fino al 1944.dettagli
-
26 maggio 1928Giorgio Pini direttore del "Resto del Carlino"A soli 29 anni Giorgio Pini (1899-1987), già direttore de “L'Assalto”, conosciuto per le sue doti di “fascista equilibrato”, è designato per ordine di Mussolini alla guida del “Resto del Carlino”. Il giornale naviga da tempo in cattive acque dal punto di vista finanziario, tanto che il Consiglio di Amministrazione è sul punto di cederlo. E’ gravato da diversi oneri, tra i quali il costo di stampa del quotidiano sportivo “Il Littoriale”, mentre le vendite sono in calo. Il Duce gli raccomanda di fare un giornale "che sia degno oggi e domani del quadrivio della rivoluzione delle camicie nere". Il podestà Arpinati (1892-1945), invece, lo considera solo una copertura di Mario Missiroli (1886-1974), al momento in disgrazia. Umiliato di sentirsi semplicemente un trait d'union, Pini non starà al gioco. Il 4 marzo 1930 sarà perciò dimissionato dal ras e rimpiazzato da Mario Ghinelli (1903-1946), suo fedelissimo. Sarà in seguito caporedattore al "Popolo d'Italia" e quindi nuovamente direttore del "Carlino" e anche - dal 20 ottobre 1944 - sottosegretario agli Interni della Repubblica Sociale, unico bolognese nel governo di Salò. Nel 1945 verrà arrestato a Brescia e nel 1946 processato per collaborazionismo. Le cariche ricoperte nella RSI saranno viste dall’accusa come una prova schiacciante di intesa con l’invasore tedesco. Sulla base di note biografiche da lui stesso redatte, i giudici lo descriveranno come protagonista di "nobili battaglie" contro gli esponenti del vecchio regime e fautore di riforme sociali e di pacificazione. Eviterà la pena capitale prevista per il reato di collaborazionismo e otterrà una pena di soli dieci anni, subito ridotta a sei per una decorazione ottenuta nella Grande Guerra. Verrà quindi amnistiato e potrà tornare libero già nell’agosto del 1946. Sarà tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano, assieme a Giorgio Almirante e Pino Romualdi. Nel 1947 sarà denunciato con Franco Maria Servello per apologia di fascismo e verrà condannato a un anno di confino.dettagli
-
12 giugno 1928Inaugurazione del monumento a CarducciAlla presenza di re Vittorio Emanuele III e della regina Elena, di Mussolini “duce del fascismo” e del Podestà Arpinati, viene inaugurato solennemente, a vent'anni dalla sua commissione, il grande monumento a Giosuè Carducci in marmo di Carrara. La “vasta scenografia marmorea” è l'opera più illustre e di maggiore impegno di Leonardo Bistolfi (1859-1933), artista del liberty amato da D'Annunzio e considerato lo “scultore ufficiale dell'Italia monarchica e liberale” (Buitoni). Nel suo stile “prevalgono le linee compositive languide e fluide, 'a schiocco di frusta', dell'Art Nouveau e una poetica vagamente visionaria, tipica del Simbolismo” (Collina). Il monumento occupa quasi per intero il giardino accanto all'ultima dimora del poeta in via del Piombo, addossato ad un tratto delle antiche mura del Trecento. Ai lati della scultura centrale, raffigurante Carducci seduto e pensieroso, ci sono i gruppi allegorici La Natura e il Poeta e La Libertà sul sauro destrier della Canzone, che intendono riassumere plasticamente la sua lirica. Durante la seconda guerra mondiale le solide fondamenta del monumento verranno adibite a rifugio antiaereo.dettagli
-
12 settembre 1929Arpinati sottosegretario agli Interni. Ghinelli federaleIl 12 settembre Dino Grandi (1895-1988) è nominato ministro degli Esteri. Nello stesso giorno Leandro Arpinati (1892-1945) diviene sottosegretario agli Interni. Si tratta, in pratica, della seconda carica del regime, detenuta dal 1926 dal Duce stesso dopo l'attentato di Anteo Zamboni e il successivo allontanamento del ministro Luigi Federzoni (1878-1967). Con la partenza del “ras dei ras” per la capitale, Mario Ghinelli (1903-1946), ispettore dei gruppi rionali e suo fedelissimo, gli subentrerà come segretario della Federazione bolognese del PNF. Erediterà inoltre le cariche di segretario del Fascio cittadino, presidente della Casa del Fascio, comandante dei fasci di combattimento, consigliere di amministrazione dell’Istituto Case Popolari, presidente della Poligrafici Riuniti, vice-presidente di “Bologna Sportiva”. Altri uomini vicini ad Arpinati, Antonio Carranti (1872-1930) e Giovan Battista Berardi (1895-1966), deterranno in successione la carica podestarile. Si realizzano, così, gli auspici espressi a Mussolini dal prefetto Guadagnini: "E' interesse del Partito che il blocco politico, dall'On. Arpinati formato, debba conservarsi anche senza di lui".dettagli
-
21 settembre 1929Antonio Carranti nominato PodestàCon la nomina di Leandro Arpinati (1892-1945) a sottosergetario agli Interni, diviene Podestà il suo “più vicino e più prezioso collaboratore”, l'avvocato Antonio Carranti (1871-1930), già esponente di spicco del partito monarchico costituzionale imolese e sindaco della cittadina dal 1898 al 1901. Delegato podestarile per le materie finanziarie, è presentato come un abile amministratore e un lavoratore instancabile. Il suo compito è essenzialmente quello di portare a termine le opere avviate dal suo predecessore. Morirà però molto presto, il 24 aprile 1930, dopo una breve malattia. Al suo posto subentrerà Giovan Battista Berardi (1895-1966), vice-podestà e membro del Direttorio del Fascio, anch'egli assiduo seguace di Arpinati.dettagli
-
ottobre 1929L'Istituto di Medicina Sportiva al LittorialeNell'autunno 1929, in occasione della convocazione del primo Congresso dei Medici sportivi, viene inaugurato l’Istituto di Medicina Sportiva al Littoriale. La sua creazione, su iniziativa di Leandro Arpinati, ha come fine il dare dignità scientifica allo sport, considerato non solo un'attività ludica, ma una pratica da studiare e controllare. Si vuole fugare i dubbi sulla pratica sportiva ricorrenti negli ambienti italiani dell'educazione fisica. Categorica, ad esempio, è l'opinione del Gruppo di Competenza per l’educazione fisica, emanazione del Fascio milanese: “Se la ginnastica deve essere educativa e deve essere impartita a fanciulli e adolescenti, dentro o fuori di scuola, di essa non possono far parte gli sports. Non esiste uno sport che da solo possa tendere allo sviluppo armonico dell’organismo”. L'ambizioso progetto di Arpinati è quello di affiancare, per la prima volta in Italia, a un centro polisportivo - il “suo” Littoriale - un'ambulatorio di medicina sportiva "non tanto inteso all'assistenza sanitaria degli infortuni, né ai consigli o alle provvidenze terapeutiche delle eventuali infermità o indisposizioni degli sportivi, quanto a titolo di controllo della efficienza atletica, o delle ricorrenti deflessioni di forma". Alla base sta l'idea che l’educazione fisica e lo sport debbano essere una scienza basata non solo sull'occhio dell'allenatore o dell'educatore, ma soprattutto su metodi precisi e sicuri. Proprio perchè la pratica sportiva tende a condurre l'atleta ai suoi limiti psico-fisici e nasconde a volte pericoli per la salute, occorre un istituto che sia “a tutela dei limiti di dispendio di energie consentite ad ogni sportivo dalle sue condizioni funzionali ed organiche”. Presso l'Istituto di Medicina Sportiva, diretto dal prof. Giovanni Pini, saranno da subito rese obbligatorie visite di accertamento per gli alunni delle scuole che utilizzano le strutture del Littoriale e per gli atleti delle società sportive bolognesi. Riguardo ai bambini l'obiettivo è anche quello di definire “il normotipo regionale maschile e femminile dagli 11 ai 18 anni”, in funzione della selezione dei soggetti adatti allo sport, “fino alla scelta dei campioni”. Sugli “sportivi maturi” vengono invece effettuati rilievi antropometrici e misure dell'energia dei diversi organi nell'esercizio sportivo. Diviso in cinque sale – per i rilievi antropometrici e biometrici, le analisi chimiche, la riproduzione di pratiche sportive – l'istituto è dotato di apparecchi moderni come il tapis roulant, la poltrona a sedile compressibile, le macchine Roentgen per radiografia e radioterapia. L'Istituto del Littoriale godrà di notevole considerazione e fama in parallelo alla fortuna politica del suo ideatore Arpinati. Con la sua caduta in disgrazia sarà ridimensionato, così come l’attività agonistica nell’intero impianto.dettagli
-
27 ottobre 1929La Torre di Maratona al LittorialeÈ inaugurata la Torre di Maratona al Littoriale. Edificata su disegno di Giulio Ulisse Arata (1881-1962), architetto piacentino molto attivo in questo periodo in città, grazie all’amicizia con Leandro Arpinati. L’opera è alta 42 metri. In prossimità della base vi è il luogo in cui venne fucilato il martire risorgimentale Ugo Bassi. La torre rappresenta lo spirito di competizione e resistenza dell’atleta, ma ha anche altri incarichi funzionali: ospita una gigantesca antenna per le trasmissioni radiofoniche, che serve anche per l’alza bandiera dei giorni di festa. Vi sventola un vessillo di 100 mq, regalato dalla Regia Marina ad Arpinati. Nell’incavo ad arco della Torre di Maratona, proprio di fronte alla tribuna reale, è scoperta solennemente la statua equestre di Mussolini, mentre sul pennone è issata una Vittoria alata. Entrambe sono opera di Giuseppe Graziosi (1879-1942), scultore modenese e professore all’Accademia di Firenze. “Artista verista, aggiornato al divisionismo”, è stato allievo di Giovanni Fattori Dopo la guerra il monumento del Duce a cavallo sarà in parte disperso e in parte fuso da Luciano Minguzzi per le statue dei partigiani di Porta Lame. La Vittoria, in origine rivolta alle tribune e da tempo girata e danneggiata dalle intemperie, sarà rimossa in occasione della ristrutturazione dello stadio negli anni Novanta. Durante la seconda guerra mondiale verrà usata come bersaglio dai soldati Alleati accampati nello stadio.dettagli
-
1930Progetto per la Scuola di Arti e MestieriAll'interno della zona dei Prati di Caprara, nei pressi della via Emilia, è prevista l'edificazione di un nuovo grande istituto tecnico: la Scuola di Arti e Mestieri.Il progetto è sostenuto da Leandro Arpinati e ne segue la fortuna politica. Sarà abbandonato dall'amministrazione comunale dopo la sua destituzione, nel 1933.Tra il 1930 e il 1932 l'architetto incaricato, Giulio Ulisse Arata (1881-1962), formula diverse ipotesi. Tutte presentano un grande impianto caratterizzato da una piazza con portici. Gli ambienti prospicienti alla piazza sono di grandi dimensioni, destinati a laboratori e aula magna.Sono previsti spogliatoi, una mensa, aule didattiche, uffici per i docenti. Il linguaggio architettonico è fortemente semplificato: la struttura di base in cemento armato è rivestita da un paramento murario con mattoni a vista e con ampie aperture.dettagli
-
10 luglio 1930Giovanni Battista Berardi nominato PodestàDopo la precoce morte di Antonio Carranti (1871-1930), subentra alla carica di Podestà di Bologna il romagnolo Giovanni Battista Berardi (1895-1966), già facente funzione di vice podestà. Fascista della prima ora, Berardi ha partecipato alla Marcia su Roma alla testa di un gruppo di Camicie Nere. Il giorno della strage di Palazzo d‘Accursio salì sulla torre Asinelli per togliere la bandiera rossa issata dai socialisti. Si è distinto in numerose azioni squadristiche, conquistando la fiducia del ras bolognese Arpinati, di cui seguirà la sorte politica dopo la sua caduta in disgrazia nel 1933. Si dovrà alla sua “fervida iniziativa” la riapertura del Teatro Comunale dopo l’incendio del novembre 1931. Provvederà infatti sollecitamente “alle opere di restauro e di ripristino” (Giacomelli). A coadiuvare Carranti è nominato vice-podestà Giuseppe Lipparini (1877-1951). Insegnante di Storia dell'arte all‘Accademia, oltre che scrittore e poeta, è noto per essere stato, nel 1914, l'oratore di uno dei primi comizi interventisti. Tesserato al PNF, fonde “in felice armonia la fede politica e le nobili facoltà di artista”.dettagli
-
28 ottobre 1930Ricostruzione del forno del pane. L'EAC in difficoltàPer iniziativa del Podestà Leandro Arpinati (1892-1945) viene ristrutturato l'immobile del forno comunale, voluto nel 1917 dal sindaco socialista Francesco Zanardi (1873-1954). Il nuovo edificio, progettato dall'ing. Carlo Tornelli, è molto più grande del precedente e, oltre che per il pane, è predisposto alla produzione di vino, ghiaccio e salumi. Intanto l'Ente Autonomo dei Consumi (EAC), di cui il panificio comunale fa parte, è controllato dal Fascio fin dal 1923 e diretto in un primo tempo dall’on. Bruno Biagi (1889-1947) e dallo stesso Arpinati. Negli anni si è enormemente ingrandito: ora gestisce 35 spacci di generi alimentari, macellerie, calzolerie, magazzini. Ha anche alcuni negozi in provincia. Il bilancio è però in grave perdita e solo la possibilità del Podestà di accedere a prestiti bancari, sfruttando la sua carica, eviterà il fallimento, almeno fino alla sua caduta in disgrazia nel 1933.dettagli
-
14 maggio 1931Lo “schiaffo” a ToscaniniLa sera del 14 maggio è in programma al Teatro Comunale un concerto, diretto da Arturo Toscanini (1867-1957), in memoria di Giuseppe Martucci (1856-1909), direttore emerito dell’orchestra bolognese alla fine dell’800. Il maestro si rifiuta di dirigere l’inno fascista Giovinezza e l’Inno reale al cospetto del ministro Costanzo Ciano (1876-1939), venuto a Bologna per inaugurare la Fiera del Littoriale, e del sottosegretario Arpinati. E’ aggredito e schiaffeggiato da alcune camicie nere presso un ingresso laterale del teatro. Tra gli squadristi c’è forse il giovane Leo Longanesi (1905-1957). La sua presenza è riferita da Indro Montanelli (1909-2001), ma per altri questa è “una leggenda senza conferma”. Rinunciando al concerto, Toscanini si rifugia all’hotel Brun. Il Federale Mario Ghinelli (1903-1946), con un seguito di facinorosi, lo raggiunge all’albergo e gli intima di lasciare subito la città, se vuole garantita l’incolumità. Il compositore Ottorino Respighi (1879-1936), media con i gerarchi e ottiene di accompagnare il direttore al treno la sera stessa. Il 19 maggio l’assemblea regionale dei professionisti e artisti deplorerà “il contegno assurdo e antipatriottico” del maestro parmigiano. Sull’ “Assalto” Longanesi scriverà: “Ogni protesta, da quella del primo violino a quella del suonatore di piatti, ci lascia indifferenti”. Toscanini dal canto suo scriverà una feroce lettera a Mussolini, già suo compagno di lista a Milano nelle elezioni politiche del 1919. Dal “fattaccio” di Bologna maturerà la sua decisione di lasciare l’Italia, dove tornerà a dirigere solo nel dopoguerra. Il concerto in onore di Martucci sarà rifatto al Comunale sessanta anni dopo, il 14 maggio 1991, sotto la direzione di Riccardo Chailly.dettagli
-
14 maggio 1931La funivia di San LucaIn occasione dell'apertura della Fiera del Littorale, alla presenza del ministro delle Comunicazioni Costanzo Ciano e del sottosegretario Leandro Arpinati, è inaugurata la funivia per il colle di San Luca. Allo studio fin dall'Ottocento, è realizzata con tecniche innovative dall'ingegner Ferruccio Gasparri. La funivia per il santuario di S. Lucatutta di ferro e crudaoscilla al limite dei campi;insieme a voi, amici,m'affido al miracolo volgaredi un gruppo di gente che vola ...(P. Volponi) Per superare un dislivello di circa 220 metri la cabina compie un tratto di 1.372 metri, interrotto da un unico pilone. La partenza è in località Ghisello, l'arrivo sulla cime del colle della Guardia, all'ex forte Mandorli. Per raggiungere più agevolmente la stazione a valle viene prolungata di 600 metri la linea Littoriale dei tram. Gestita dalla società SACEF fino alla guerra, la funicolare Bologna - San Luca sarà tra le linee italiane con bilancio attivo. Nel primo anno di attività conterà oltre 200.000 passeggeri. L'ing. Gasparri potrà affermare che Bologna ha conquistato, "inaspettatamente e di slancio", il primato nel campo dei trasporti funicolari.dettagli
-
ottobre 1931Leo Longanesi allontanato dalla direzione de "L'Assalto"Dopo la stroncatura di un articolo del senatore Giuseppe Tanari (1852-1933), esponente-simbolo della borghesia conservatrice bolognese, espresso in una nota dal titolo Vecchiaia delle parole, il direttore de “L'Assalto” Leo Longanesi (1905-1957) è costretto alle dimissioni. Risulterà vano il suo tentativo di farsi ricevere a Roma dal sottosegretario Arpinati: il suo ex ammiratore ed ex protettore politico avrà l'occasione di liberarsi di un personaggio divenuto scomodo, anche per l'episodio della clamorosa aggressione a Toscanini al Teatro comunale. E' infatti di Longanesi - oltre che del Federale Ghinelli - che si vocifera da tempo negli ambienti della stampa romana e estera come autore dell'"imboscata" al grande maestro.dettagli
-
1932Le "Aldini Valeriani" diventano Istituto Tecnico IndustrialeL'Istituto per le Arti e i Mestieri “Aldini Valeriani” diventa Istituto Tecnico Industriale. Nel curriculum del nuovo perito industriale, ispirato dal podestà Arpinati, è ridotto il tempo per il lavoro manuale, mentre sono aumentate le esercitazioni tecnologiche. La figura del perito tende a differenziarsi da quella dell'operaio generico e specializzato, dedito a compiti prevalentemente esecutivi, formato nella Scuola di Avviamento e nella Scuola Tecnica Industriale. Oltre che conoscere molto bene le macchine, il perito deve “saper gestire le esigenze organizzative dell’officina, svolgendo compiti di programmazione del ciclo produttivo”. Nel 1936 sarà creato alle “Aldini” un laboratorio tecnologico di alto livello, in grado di soddisfare anche esigenze esterne alla scuola.dettagli
-
5 maggio 1932Gian Carlo Nannini celebrato all'UniversitàIl segretario del PNF Achille Starace (1889-1945) celebra, assieme al rettore Ghigi, la memoria di Giancarlo Nannini (1899-1922), scoprendo una lapide a lui dedicata nell'atrio di palazzo Poggi. Nannini, al quale è intitolato un gruppo rionale nella zona di Corticella, era uno studente di Finale Emilia, distintosi sui campi di battaglia della grande guerra. "Intrepido come un eroe antico, sensibile come un poeta, coraggioso senza ostentazioni", al ritorno dal fronte si iscrisse al Fascio di combattimento, divenendo uno dei capi delle squadre d'azione cittadine. Nei giorni della Marcia su Roma partecipò a numerose azioni squadriste, tra cui la liberazione di alcuni fascisti dal carcere di San Giovanni in Monte. “Non era tempo quello di quiete e di studi (...) ma tempo di azione e di azione violenta contro la vecchia Italia materialistica e agnostica” (Saitta). Morì il 29 ottobre 1922, in uno scontro a fuoco con i carabinieri, durante un assalto alla caserma di San Ruffillo. Considerato uno dei martiri della Rivoluzione fascista, nel 1925 gli fu reso solenne omaggio con un pellegrinaggio delle autorità a San Ruffillo. Nel 1926 gli furono dedicati premi studenteschi e ricevette la laurea honoris causa in Giurisprudenza e nel 1931 gli fu intitolata una scuola, con una epigrafe di Mussolini. Nel 1934 la commemorazione del martire sarà particolarmente sentita: gli sarà dedicata una campana votiva e un corteo partirà dalla sede del gruppo rionale al luogo del sacrificio, dove saranno ricordati i nomi dei caduti per la rivoluzione fascista. In onore di Nannini, anche il gerarca Leandro Arpinati chiamerà la figlia Giancarla.dettagli
-
5 giugno 1932L'ippodromo dell'ArcoveggioIn via Corticella all'Arcoveggio è inaugurato il nuovo ippodromo progettato da Umberto Costanzini (1897-1968) con Ulisse Bandiera. L'impianto, per i tempi innovativo, è stato voluto fortemente dall'ex podestà Arpinati. Primo Castelvetro, esperto di trotto, lo definisce “splendido, elegante, completo”. La tribuna “super sottile” è una delle prime in Italia e la più ampia tra quelle completamente a sbalzo, senza pilastri di sostegno. I calcoli della struttura sono opera dell'ing. Armando Villa (1897-1958). Nell'ampio parcheggio, circondato da alberi di alto fusto, possono essere accolte le vetture di tutti gli spettatori. Le scuderie hanno box completamente in muratura. Specializzato per il trotto, l'ippodromo dell'Arcoveggio conoscerà ogni anno due periodi di riunioni equestri, con una sospensione estiva, durante la quale le corse si sposteranno sulla riviera adriatica, utilizzando l'ippodromo Savio di Cesena. Nel dopoguerra alcuni cavalli, come Tornese e Crevalcore, sapranno dividere i gusti del pubblico e il tifo, come i campioni del ciclismo o della boxe. Nel 1932 è allestito a Bologna anche un campo ostacoli, che nel 1948 diverrà ippodromo militare. Si trova ai Giardini Margherita ed è gestito dalla Società del Cavallo da Sella.dettagli
-
1 agosto 1932La Colonia Marina del Fascio bologneseCon “un sistema sbrigativo e nuovo”, cioè con l'ingresso di tanti bambini che ne prendono possesso, è inaugurata il 1° agosto, a Miramare di Rimini, l'imponente Colonia Marina del Fascio bolognese, progettata dall'ing. Ildebrando Tabarroni, che ha diretto personalmente i lavori. La struttura, a padiglioni separati, per l'epoca ormai antiquata, si ispira a quella dell'Ospizio Marino Provinciale Bolognese di Rimini, o colonia Murri, opera di Giulio Marcovigi. Quattro grandi edifici in laterizio, in stile eclettico, costruiti perpendicolarmente al mare e collegati da un lungo corridoio, ospitano i dormitori e i refettori, mentre corpi di fabbrica più piccoli sono adibiti a uffici e camere per il personale. La struttura è situata in un'area di 20.000 mq lungo la litoranea Rimini-Riccione e può ospitare fino a 1.200 bambini, provenienti dai 61 comuni della provincia di Bologna. La vita della colonia, intitolata alla Decima Legio, è regolata da una "materna disciplina". Essa deve contribuire alla "bonifica umana" a cui si è dedicato fin dall'inizio il fascismo bolognese. E' una sorta di vita militare con orari rigidi e attività ben scandite. Le addette all'assistenza sono ragazze diplomate e tesserate al partito fascista, che hanno seguito un corso per “vigilatrici di colonia”. La grande struttura è stata promossa dal Segretario federale Mario Ghinelli, “interprede fedele, intelligente, dinamico, volitivo delle direttive del Duce”, che cammina "nel solco tracciato da Leandro Arpinati". Le domande per le colonie estive saranno filtrate negli anni seguenti dall'Opera Nazionale Dopolavoro: nel 1935 l'ente invierà 100 bambini, regalando la retta ai più bisognosi. Nel 1939-40 la colonia ospiterà bambini provenienti dall'Albania e dalla Libia, richiamati in patria per essere messi al sicuro dagli eventi bellici. Durante la seconda guerra mondiale la colonia bolognese servirà dapprima da ricovero per i reduci della spedizione in Russia e dopo il 25 luglio 1943 sarà trasformata in campo di internamento femminile per i corpi di sabotaggio e spionaggio della RSI. Nel dopoguerra il complesso sarà restaurato con ingente sforzo economico dal Comando Alleato, dopo aver servito da campo di prigionia per militari tedeschi. Nel 1947 riprenderà a funzionare come Colonia estiva del Comune di Bologna, accogliendo circa 1.200 bembini, divisi in tre turni. Il 18 gennaio 1958 il dott. Valente, amministratore dei beni dell'ex GIL, cederà la colonia al card. Lercaro. Da allora, fino al 1977, sarà gestita dall'Opera Diocesana di Assistenza.dettagli
-
28 ottobre 1932I martiri fascisti nel sacrario della CertosaIl fascismo bolognese celebra il Decennale della marcia su Roma. Al teatro del Corso, pieno all'inverosimile di camicie nere, si tiene la cerimonia d'apertura. Contro lo sfondo del palcoscenico una grande immagine del Duce campeggia tra bandiere, trofei di alloro e una “fittissima selva” di vessilli fascisti, sindacali e patriottici, provenienti da Bologna e provincia. Si svolge quindi la solenne cerimonia di traslazione delle salme dei 53 caduti per la causa della Rivoluzione fascista nel nuovo sacrario della Certosa. Il rito funebre è celebrato in San Petronio dall'arcivescovo Nasalli Rocca, alla presenza delle massime autorità locali. Leandro Arpinati tiene un discorso commemorativo. La città è percorsa da un grande corteo di camicie nere, mentre i bar e i locali di intrattenimento abbassano le saracinesche, per rispetto della “famiglia eroica dei Morti”. Il fascismo della X Legio bolognese - legione già prediletta da Giulio Cesare - è quella che "ha dato il più grande sacrificio per la causa della Rivoluzione" (Mussolini). Il nuovo “Sepolcreto dei prodi fascisti” in granito di Siena, edificato nel VI chiostro della Certosa, accanto a quello della Grande Guerra, è opera dell'architetto Giulio Ulisse Arata (1881-1962), con la collaborazione dello scultore Ercole Drei (1886-1973), autore dei rilievi. Si presenta come un vasto ipogeo sovrastato dall'Ara dei Caduti. All'ingresso è murata la scritta "Caduti per il fascismo Bologna memore qui li raccoglie e li onora in eterno". E' stato costruito con una sottoscrizione pubblica, alla quale hanno partecipato le personalità più in vista del fascismo bolognese, da Grandi a Federzoni. Lo stesso Mussolini ha inviato 5.000 lire. Il valore simbolico del sacrario sarà bene espresso nelle pagine della rivista del Comune di Bologna: “Non è privo di significato che questi nostri Fratelli siano stati raccolti qui, accanto ai Caduti della grande guerra, ai piedi di quel colle sacro ai bolognesi, di fronte al Littorale, palestra delle nuove generazioni: tutti si votarono alla medesima Causa, tutti caddero per lo stesso ideale, per l'Italia più grande, più libera, più potente. Essi continueranno, così riuniti, a vegliare sui confini della Patria, sui diritti della Vittoria, sulla quotidiana fatica del Duce”.dettagli
-
28 febbraio 1933Concorso per la facciata di San PetronioViene bandito un concorso nazionale per il disegno della facciata di San Petronio. Nel 1928 un proposito di Leandro Arpinati, appoggiato da Guido Zucchini - autorevole erede di Rubbiani nei restauri bolognesi - aveva ricevuto un netto rifiuto da parte del ministro della Pubblica Istruzione Piero Fedele. Questi aveva ammonito il Podestà a non recare offesa “alla meravigliosa bellezza di una delle più stupende piazze d’Italia”, eliminando “uno degli elementi principali di questa bellezza”. Le ipotesi di sovrapposizione di soluzioni moderne sul corpo antico della basilica vengono pesantemente stigmatizzate sul “Resto del Carlino” da Marcello Piacentini, il più autorevole architetto italiano del periodo: “Lasciamo San Petronio com’è: sta benissimo”. Contrario è anche Igino Benvenuto Supino, titolare della cattedra di Storia dell’Arte all’Università, mentre in un articolo non pubblicato l’architetto modernista Enrico De Angelis irride al desiderio “di impiastricciare il profilo alpino del S. Petronio con un merletto di guglie trite”. Il 24 gennaio 1935 il podestà Angelo Manaresi inaugurerà comunque una esposizione dei progetti e tre di essi saranno giudicati eseguibili: quelli di Guido Cirilli, di Domenico Sandri e di Duilio Torres, tutti quanti in blando stile neo-gotico. Non si passerà, tuttavia, ad alcun concreto intervento.dettagli
-
9 aprile 1933Viaggio a Roma dei goliardi bolognesi450 goliardi, appartenenti a 26 nazioni e tutti iscritti all'Università di Bologna, compiono dal 9 al 12 aprile un viaggio a Roma accompagnati dal rettore Ghigi, dal segretario federale Ghinelli e dal presidente del GUF Ballarini. Nella capitale visitano la Mostra della Rivoluzione fascista e sono ricevuti da Starace, da Arpinati e dal Governatore di Roma. Fanno inoltre omaggio all'altare del Milite Ignoto. Al cospetto di Mussolini, gli studenti esprimono “i sentimenti di ammirazione della gioventù di tutto il mondo” al Duce del Fascismo.dettagli
-
30 aprile 1933La Società degli uomini eminentiUn’informativa della polizia diretta al ministero dell’Interno rivela che Bologna è da molti anni dominata da una “potentissima organizzazione massonica”, una rete segreta politicamente trasversale, di cui fanno parte gli uomini “più in vista” e influenti della città, appartenenti a vari partiti politici. All’interno della massoneria bolognese esiste una “crema”, una società ancora più nascosta, chiamata la Società degli uomini eminenti. Ne fanno parte professori, funzionari, liberi professionisti, uniti dall’interesse a mantenere posizioni di potere. Tra loro è in vigore un patto segreto: quando un partito è al potere, gli Eminenti di quel partito sono tenuti a proteggere gli Eminenti degli altri partiti, anche se si tratta di oppositori. Fanno parte della “crema”, tra gli altri, i socialisti Bentini e Zanardi, i fascisti Oviglio, Arpinati, Serpieri, Biagi, Puppini, Muzzioli, il liberale Germano Mastellari, difensore della famiglia Zamboni dopo l’attentato al Duce. L’anima spirituale del gruppo sarebbe il giornalista Mario Missiroli (1886-1974), ex direttore del “Resto del Carlino” e del “Secolo”, antico avversario di Mussolini, che con lui si è addirittura battuto a duello nel 1922, dopo averlo chiamato “perfido gesuita e solennissimo vigliacco”. Da tempo Missiroli è considerato l’ispiratore politico di Leandro Arpinati (1892-1945), che gli ha affidato la direzione occulta del “Carlino” e tenta di riconciliarlo con il PNF, superando la proscrizione del Duce. La vicinanza con il giornalista disprezzato dalle alte sfere del partito - direttore nel dopoguerra del “Messaggero” e del “Corriere” e legato ad ambienti segreti inglesi - sarà uno dei motivi della caduta in disgrazia del ras bolognese.dettagli
-
3 maggio 1933La caduta in disgrazia di Leandro ArpinatiLeandro Arpinati (1892-1945), indiscusso leader del fascismo bolognese, conosciuto come “Il Pontefice Nero”, cade in disgrazia presso Mussolini a seguito di una lite, arrivata fino alla sfida a duello, con il segretario del PNF Achille Starace (1889-1945). Viene dimesso da Sottosegretario agli Interni e mandato al confino a Lipari. Il suo posto è occupato da Guido Buffarini Guidi (1895-1945). Pur rimanendo fedele al Duce, Arpinati ha manifestato più volte segnali di autonomia ed è accusato di trafficare con avversari del regime, come l'ex direttore del "Resto del Carlino" Missiroli o la famiglia di Anteo Zamboni, il giovane attentatore di Mussolini nel '26. Oltre alle cariche politiche, Arpinati perde anche il lavoro nelle Ferrovie, per il quale era in aspettativa. Inoltre non gli viene rinnovata la tessera del PNF. Il confino di cinque anni gli sarà ridotto per la malattia della moglie. Non potrà, però, allontanarsi dalla sua tenuta di Malacappa, presso Argelato.dettagli
-
24 giugno 1933Commissariamento della Federazione fascista bologneseDopo la caduta in disgrazia di Leandro Arpinati (1892-1945) il fascismo bolognese viene epurato dall'ispettore del fascio Zelindo Ciro Martignoni (1897-1973), segretario federale dal 1° luglio 1933 al 24 dicembre 1934. Nato in provincia di Mantova, combattente nella grande guerra, tra il 1921 e il ‘22 ha partecipato alle azioni squadristiche e ha poi ricoperto varie cariche nel Fascio del capoluogo. Dal dicembre del 1932 fa parte del Direttorio nazionale del PNF. Gli “arpinatiani”, in primis il federale Mario Ghinelli (1903-1946), vengono privati della tessera e sottoposti a provvedimenti disciplinari. E’ nominata una commissione federale di disciplina, presieduta da Piero Monzoni (1896-?), futuro segretario (dal 21 agosto 1940). Anche il “Resto del Carlino” passa sotto il controllo di Dino Grandi (1895-1988), tramite il nuovo direttore Giorgio Maria Sangiorgi. Nel gennaio 1934, con un atto di imperio, Mussolini obbligherà il Comune a cedere gratuitamente la Casa del Fascio al PNF di Bologna. Insieme verranno liquidate le società per la Casa del Fascio e per il Littoriale, prima controllate da Arpinati. Il 2 agosto 1934 il segretario del PNF Starace espellerà una ventina di tesserati bolognesi dal partito - tra essi Giuseppe Ambrosi, Arconovaldo Bonaccorsi, Walter Boninsegni - con questa motivazione: “dava la propria solidarietà, ostentando atteggiamenti in netto contrasto con lo spirito tradizionalemente fascista, ad un tesserato eliminato dai ranghi perché postosi notoriamente contro le direttive del P.N.F.”. Ghinelli si trasferirà a Napoli e nell’agosto 1934 sarà espulso dal PNF. Andrà quindi in Spagna a combattere con il caudillo Francisco Franco, partecipando alla presa di Malaga. Nel ‘39 verrà riammesso nel partito, ma dopo l’armistizio non aderirà alla RSI. Dopo l’incarico a Bologna Martignoni verrà eletto deputato nella XXIX legislatura del Regno. Negli anni Trenta sarà dirigente AGIP a Mantova e membro della deputazione zootecnica. In seguito si ritirerà dalla vita politica.dettagli
-
gennaio 1934La rivista "Credere"Il mensile “Vita Nova”, la cui fondazione era stata deliberata da Arpinati, viene sostituito dopo la caduta dell'ex podestà dalla rivista “Credere”, una smaccata apologetica di regime “del tutto priva di storia autonoma” (Paci). E' diretta dall'ispettore del Fascio Ciro Martignoni (1897-1973), che lascerà non appena terminata l'epurazione dell'ambiente arpinatiano. Vi collaborano, tra gli altri, gli storici Giovanni Maioli e Giovanni Natali (1884-1959), il giornalista e scrittore Gianni Granzotto (1914-1985), il letterato e critico letterario Dante Manetti. L'Università Fascista di Bologna è intanto soppiantata dal novello Istituto di Cultura Fascista.dettagli
-
24 gennaio 1934Il Comune regala al PNF la Casa del Fascio“In ossequio al pensiero e alle direttive del Duce” il Comune approva, con delibera del Podestà Angelo Manaresi, la cessione gratuita della Casa del Fascio di via Manzoni al Partito Nazionale Fascista. Il diritto di proprietà era stato avanzato a seguito dell'insolvenza della Società “Pro casa del Fascio”, emanazione del gerarca Arpinati, ormai caduto in disgrazia e inviato al confino. Mussolini era intervenuto personalmente per scongiurare l'alienazione dell'immobile, storica centrale operativa della Decima Legio bolognese.dettagli
-
27 maggio 1934I mondiali di calcio al LittorialeIl 27 maggio allo stadio Littoriale è prevista la partita Svezia-Argentina per gli ottavi di finale dei campionati mondiali di calcio. La squadra sudamericana è composta da semi-dilettanti e cede agli scandinavi per 3 a 2 davanti a circa 15mila spettatori. L’argentino Belis realizza al terzo minuto il primo goal in assoluto dei Mondiali. In preparazione della partita con la Svezia, il 22 maggio gli argentini hanno giocato un’amichevole con l’SS Casalecchio, squadra di Prima divisione, vincendo per 7 a 1. Il 31 maggio si giocherà il derby danubiano tra Austria-Ungheria, con i primi vincenti per 2 a 1 dopo una gara durissima, definita “non una partita, ma una baruffa” dall’allenatore austriaco Meisl. Accorreranno 25mila tifosi, attratti anche dal maggior blasone delle due squadre, che in questo periodo dominano il calcio europeo. Per questi mondiali non solo previste al Littoriale partite dell'Italia, benché il nuovo impianto polisportivo sia concerdemente riconosciuto come uno dei più funzionali e moderni. La scelta è dovuta probabilmente ai contrasti politici, che hanno portato alla caduta in disgrazia di Leandro Arpinati (1892-1945), committente dello stadio e massimo dirigente dello sport italiano.dettagli
-
14 ottobre 1935La Cooperativa bolognese di consumoSulle ceneri dell'Ente autonomo dei consumi, fondato durante la prima guerra mondiale dal “sindaco del pane” Francesco Zanardi (1873-1954), nasce la Cooperativa bolognese di consumo. Eredita i 18 negozi salvati dal fallimento dell'Ente. Nel 1929 l'EAC, simbolo dell'amministrazione socialista, era sopravvissuto all'avvento del nuovo regime fascista grazie all'intervento di Leandro Arpinati (1892-1945), ma dopo la sua caduta in disgrazia, nel 1933, era stato abbandonato a se stesso. Nel 1945 la Cooperativa bolognese sarà di nuovo guidata da Zanardi, tornato a Bologna dopo un lungo esilio e nominato commissario dal CLN.dettagli
-
19 giugno 1936Alfredo Leati a capo della Federazione bolognese del P.N.F.Alfredo Leati (1899-1953) assume la carica di segretario della Federazione bolognese dei Fasci di combattimento. Avrà come vice segretari il dott. Giovanni Marchesini e il prof. Alfredo Coppola. Laureato in medicina, fascista iscritto al P.N.F. dal 1° febbraio 1921, Leati sarà anche Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dall’11 marzo 1939 e Ispettore del Partito Nazionale Fascista fino al 22 novembre 1939. Il 4 gennaio 1937 sarà nominato cavaliere dell’ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. La sua gestione sarà messa sotto accusa “per una amministrazione ‘allegra’ e non sufficientemente oculata”. Dal 4 gennaio 1940 cesserà dalla carica di Federale e da quella di consigliere nella Corporazione della chimica. Al suo posto verrà nominato Vittorio Caliceti ( -1940), squadrista, ardito di guerra ed ex legionario fiumano, tornato alla ribalta nel Pnf bolognese dopo la destituzione di Arpinati.dettagli
-
26 agosto 1936Arconovaldo Bonaccorsi “governatore” delle BaleariSotto il nome di “generale conte Rossi” (Conde Rossi) sbarca nell’isola di Maiorca lo squadrista Arconovaldo Bonaccorsi (o Bonacorsi, 1898-1962), già Segretario del Fascio di Bologna tra il 1921 e il 1922, fedele di Arpinati, ben noto in tutta l’Emilia-Romagna per la sua spregiudicatezza e i modi violenti. È uno dei presunti assassini del giovane Anteo Zamboni, linciato a Bologna come attentatore del Duce nel 1926. Con il grado di console della Milizia volontaria fascista (MVSN) è inviato da Mussolini a conquistare le isole Baleari, considerate basi aeree ideali per una ipotetica guerra contro la Francia. È accompagnato, tra gli altri, da Augusto Regazzi, già fondatore e ras del Fascio di Molinella, protagonista di tutte le spedizioni punitive contro i dirigenti delle leghe socialiste, poi caduto in disgrazia presso Arpinati, che mal digeriva la sua “dittatura personale” su Molinella. Per qualche tempo è stato addirittura rinchiuso in manicomio. In poche settimane Bonaccorsi arruolerà 2.500 volontari e inquadrerà i più coraggiosi e violenti come Dragones de la Muerte. La conquista di Maiorca e di Ibiza - e la loro rapida “italianizzazione” - saranno accompagnate da una feroce repressione degli oppositori, con arresti e fucilazioni sommarie. Secondo Georges Bernanos (1888-1948) saranno oltre tremila le persone assassinate dai falangisti comandati da Bonaccorsi. Ma il suo atteggiarsi a Governatore delle Baleari e la sua fama di macellaio lo renderanno inviso sia al generale Franco che a Mussolini. Nel 1937 il bolognese sarà richiamato dalla Spagna e inviato a combattere in Etiopia.dettagli
-
18 aprile 1940Dino Grandi proprietario del "Resto del Carlino"Dino Grandi (1895-1988), divenuto dopo la caduta di Arpinati la personalità più influente del fascismo bolognese, entra il possesso del “Resto del Carlino”. Giovanni Telesio, suo addetto stampa all'ambasciata di Londra è il nuovo direttore. Assieme al cognato Aurelio Manaresi, agente dell'INA, Grandi lavorava da tempo per accrescere il suo potere sul quotidiano bolognese, in cronica difficoltà finanziaria e conteso tra vari potentati. Il gerarca di Mordano è un fedele seguace di Mussolini, anche se in passato ha contestato linea espressa dal Duce. E' emerso come uno degli uomini più potenti del regime: ministro degli esteri e quindi ambasciatore a Londra. Si è laureato subito dopo la prima guerra mondiale, ancora "in divisa di capitano degli alpini e con le medaglie bene in vista sulla giubba". Sono bastate poi poche settimane "a trasformare l'avvocatino in mazziere" (Invernizzi). Al "Carlino" ha collaborato già nel 1914, appena diplomato al liceo. Fu scoperto tra i giovani ferventi interventisti dal direttore Nello Quilici, grande amico di Italo Balbo e fautore di una linea decisamente fascista per il quotidiano bolognese. Il 25 luglio 1943 Grandi sarà artefice, assieme a Federzoni e Bottai, della caduta di Mussolini ed eviterà la condanna a morte nella RSI riparando all'estero per alcuni anni.dettagli
-
febbraio 1941Una "lezione manuale"Il segretario federale del PNF invita a costituire presso i gruppi rionali delle squadre speciali di fascisti di provata fede con il compito di infliggere una “lezione manuale”, cioè una sberla, a chi esprime critiche o manifesta “malumori, tentennamenti, mormorii” nei confronti del regime. La “salutare lezione” viene impartita a chi nei locali pubblici (ma anche per strada) non ottempera all'obbligo, introdotto dal dicembre 1940, di ascoltare in piedi il Bollettino di guerra. In novembre, in occasione della posa di una lapide nella sede del primo fascio bolognese, il “rituale degli schiaffi” coinvolgerà diversi cittadini per non aver scoperto il capo al passaggio del gagliardetto. Davanti al caffè San Pietro saranno malmenati alcuni fascisti della prima ora trovati senza divisa, come l'ex segretario di Arpinati Mario Lolli e il mutilato di guerra Renato Zamboni.dettagli
-
10 settembre 1943La "trafila romagnola" dei generali inglesiIl 10 settembre giunge al convento di Camaldoli un gruppo di circa trenta soldati inglesi provenienti dai campi di prigionia di Arezzo e Firenze. Una decina sono generali, tra i quali l’ex governatore della Cirenaica Philip Neame e l’ex comandante della Western Desert Force Richard O’Connor. Sapendo che i tedeschi sono stati informati da un colonnello italiano della loro fuga, il priore li convince a trovare rifugio nel villaggio di Seghettina, in comune di Bagno di Romagna nei pressi dell’impervia Foresta della Lama. La notizia della presenza di alti ufficiali alleati sull'Appennino romagnolo giunge negli ambienti dell'antifascismo forlivese. Tra coloro che vanno ad incontrare gli ex prigionieri vi sono Torquato Nanni di Santa Sofia, Tonino Spazzoli, l'istruttore militare Bruno Vailati e l'ex gerarca fascista Leandro Arpinati, originario di Civitella di Romagna. Secondo lo storico don Bedeschi, quest’ultimo informa i generali sui piani tedeschi di allagamento della pianura padana e sulle “armi segrete” in mano a Hitler, confidenze ricevute da Mussolini alla Rocca delle Caminate. Per gli ufficiali più alti in grado è organizzata una fuga rocambolesca, che prevede il loro prelevamento sulla costa adriatica e l'attraversamento del fronte via mare. Il cammino è tortuoso e pieno di pericoli: inizia una vera e propria "trafila romagnola", analoga a quella che portò alla salvezza Garibaldi nel 1849. Il 19 dicembre, dopo faticosi trasferimenti tra Cesena, Forlì, Cervia, Riccione e vari tentativi di imbarco andati a vuoto, da Cattolica partirà il peschereccio della salvezza. Il giorno successivo i generali saranno salutati a Bari dai comandanti alleati Eisenhower e Alexander. Nel marzo 1944 Giorgio Bazzocchi e Arturo Spazzoli provvederanno a trasferire al sud, attraverso impervi sentieri in Toscana e nelle Marche, gli altri ex prigionieri rimasti in Appennino. Ventotto uomini su due barche giungeranno il 20 maggio sani e salvi ad Ortona, già occupata dagli inglesi. La vicenda dei generali è solo un capitolo dell’opera di solidarietà dei contadini dell’alto Appennino romagnolo - gli abitanti di Ridracoli, Strabattenza, Pietrapazza e quelli dei non lontani comuni di Santa Sofia e San Piero in Bagno - che aiuteranno tanti militari stranieri a salvarsi, mettendo a rischio la loro vita.dettagli
-
7 ottobre 1943Tentativo di coinvolgere Arpinati nella Repubblica SocialeIn un incontro alla Rocca delle Caminate, promosso dal commissario federale del partito fascista repubblicano Aristide Sarti, dal direttore del “Carlino” Giorgio Pini e dal prorettore Goffredo Coppola, Benito Mussolini offre a Leandro Arpinati, vecchio ras di Bologna da tempo emarginato, l'incarico di ministro degli Interni nella neonata Repubblica Sociale Italiana, con la promessa di eleggerlo Presidente del Consiglio al termine della guerra. Arpinati, ormai lontano dal fascismo e in contatto con ambienti politici liberali moderati, declina l'invito, dichiarando il suo interesse esclusivo per l'agricoltura. Durante il colloquio il Duce gli confessa di voler strappare a Hitler il consenso per l'armistizio con gli anglo-americani, ma egli si mantiene freddo e distante, accusandolo di essere ormai prigioniero dei Tedeschi. L'esito negativo del colloquio sconvolge i piani “dell'ala più autorevole del fascismo bolognese” (Bergonzini) e porterà al repentino declino della carriera politica del giovane Sarti.dettagli
-
27 gennaio 1944Nove condanne a morte per vendicare l'uccisione di FacchiniA seguito dell’uccisione del Segretario del Fascio di Bologna Eugenio Facchini, il Tribunale provinciale straordinario condanna a morte nove antifascisti. Presidente dell'assise è il gen. Ivan Doro, comandante della 4a Zona della GNR, ex ardito e squadrista implacabile, soprannominato “Ivan il Terribile”, amico di Arpinati “sul nascere del fascismo” e già comandante della Legione di Bologna della MVSN. Il processo, celebrato in assenza degli imputati e dei loro avvocati, è sommario e senza prove. La corte applica le disposizioni dettate il 3 novembre dal segretario del PFR Alessandro Pavolini, che ordinano di colpire, oltre agli esecutori, anche i supposti "mandanti morali" degli attentati, considerati "responsabili dell’avvelenamento delle anime e delle connivenze con l’invasore". Alcuni dei condannati sono antifascisti imolesi prelevati dal carcere della Rocca: i fratelli Bartolini, Sante Contoli, il giovanissimo Antonio Ronchi, il professore di violoncello Alessandro Bianconcini e il primario dell’Ospedale civile, già medico personale di D’Annunzio, prof. Francesco D’Agostino. Altri sono bolognesi: il Console della Milizia Silvio Bonfigli, Cesare Budini, Zosimo Marinelli, il giornalista del "Resto del Carlino" Ezio Cesarini, il grande invalido di guerra e Medaglia d’Oro al V.M. Luigi Missoni. La posizione del minorenne Ronchi viene stralciata, mentre la pena di morte inflitta a Missoni e Contoli è commutata in trent’anni di reclusione. I restanti otto condannati sono trascinati la sera stessa al Poligono di Tiro e fucilati, dopo esser stati seviziati e percossi fino all’ultimo. Il plotone d'esecuzione è comandato dal tenente della G.N.R. Guerrino Bettini di Imola, che ha richiesto questo "onore" al nuovo federale Torri. Prima di morire Marinelli ha scritto alla moglie: “Cara moglie, il Tribunale ha pronunciato la mia sentenza di morte, ma sono tranquillo. Ho con me compagni forti e sereni al pari di me, sicuri e fiduciosi che il nostro sacrificio non sarà vano”. Vano invece è risultato il tentativo, fatto dall'Arcivescovo Nasalli Rocca, affinché la sentenza di morte fosse almeno sospesa. Oltre all'esecuzione delle fucilazioni, è annunciata una taglia di un milione di lire sugli esecutori dell'attentato. Uno dei militi partecipanti alla fucilazione sarà giustiziato dai gappisti davanti al Bar Sport fuori Porta Sant'Isaia. Un altro membro del plotone d'esecuzione subirà la stessa sorte qualche giorno dopo.dettagli
-
3 agosto 1944La cattura e la scomparsa di Mario JacchiaI fascisti irrompono a Parma nella sede del comando militare partigiano dell'Emilia Nord-Ovest e catturano Mario Jacchia (Rossini, 1896-1944), che cerca fino all'ultimo di guadagnare tempo per favorire la fuga dei compagni. Trasferito al comando della polizia di sicurezza tedesca, viene barbaramente torturato. Jacchia appartiene a una nota famiglia di professionisti ebrei bolognesi. E' stato fervente nazionalista, ufficiale nella prima guerra mondiale, più volte ferito e decorato. Dopo la guerra ha aderito prima a un gruppo paramilitare nazionalista, poi al fascio di Leandro Arpinati. Si è allontanato dalla destra dopo l'aggressione al padre e l'incendio del suo studio. Con l'approvazione delle leggi razziali del 1938 è passato con decisione all'antifascismo, divenendo uno dei fondatori del Partito d'Azione a Bologna. Dopo interminabili sevizie Jacchia viene soppresso e il suo corpo non sarà mai più ritrovato. Il comando della GNR sosterrà di aver rinvenuto nelle sue tasche un elenco di un centinaio di antifascisti, per la maggior parte liberi professionisti. Nella cosiddetta "lista Jacchia", quasi certamente fabbricata ad arte dall'Ufficio Politico della GNR e dalla Questura, figurano anche i nomi di persone, come Francesco Pecori, Giorgio Maccaferri, Pietro Busacchi, Cesare Zuccardi Merli, Pasquale Vetuschi, che saranno di lì a poco eliminati da sicari fascisti.dettagli
-
22 aprile 1945Uccisione di Leandro ArpinatiLeandro Arpinati (1892-1945), ex capo del fascismo bolognese, viene ucciso nella sua tenuta di Malacappa, vicino ad Argelato, da un gruppo di giovani uomini e donne, che portano il bracciale dei partigiani della 7a Gap. L'amico Torquato Nanni (1888-1945), già sindaco socialista di Santa Sofia (FC), tenta Invano di difenderlo frapponendosi al mitra puntato contro di lui, ma anch'egli viene freddato sul posto. Come molti punti della vita di Arpinati, anche le circorstanze della sua morte non saranno mai del tutto chiarite. La figlia Giancarla sosterrà il coinvolgimento della banda comunista di Ultimo Borghi (Ciro), che in quei giorni, nella zona di Argelato, compie altre rappresaglie contro ex fascisti. Secondo altri, la morte cruenta di Arpinati è da collegare alla sua conoscenza di segreti scottanti su uomini del passato regime.dettagli
-
23 maggio 1988Muore Dino GrandiMuore a 93 anni l'ex gerarca fascista Dino Grandi (1895-1988). Fu con Mussolini dalla prima ora, ma fu anche, con Balbo a Arpinati, uno dei pochi ad esprimere pareri contrari al Duce. Il 25 luglio 1943, al Gran Consiglio, presentò il famoso ordine del giorno, che portò alla sua caduta. Nei suoi ricordi autobiografici traspare un grande amore per l'Italia, alla quale avrebbe evitato una guerra a cui era impreparata, per la stessa ammissione del Capo. Dopo la destituzione e l'arresto del Duce si oppose alla scelta di Badoglio: avrebbe preferito una personalità più giovane e non compromessa con il regime. Con la nascita della Repubblica di Salò, si rifugiò in Spagna e in Portogallo. Churchill in persona volle testimoniare del suo sentimento antitedesco e della sua vicinanza all'Inghilterra, dove fu a lungo ambasciatore. Negli dopoguerra riuscì a sfuggire il giudizio come criminale di guerra. Nel 1946 si trasferì in Brasile, dove divenne rappresentante della Fiat, possidente terriero, consulente legale della famiglia Kennedy. Rientrò in Italia nel 1959 e acquistò una grande e florida azienda ad Albareto, in provincia di Modena, “nel cuore dell'Emilia ormai rossa” (Gotor).dettagli