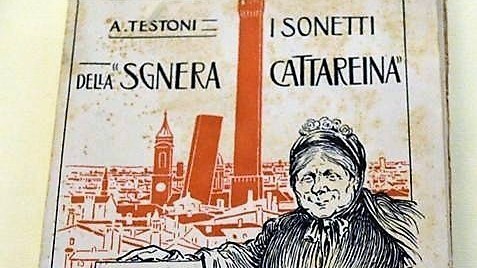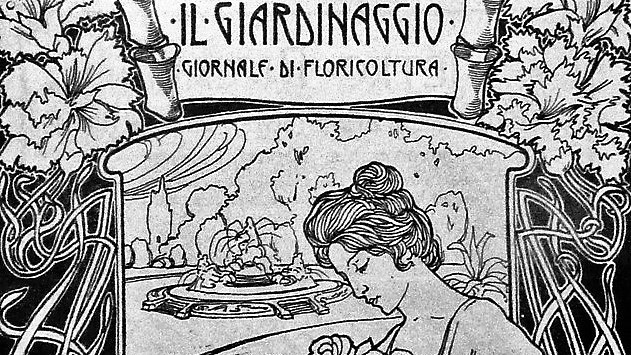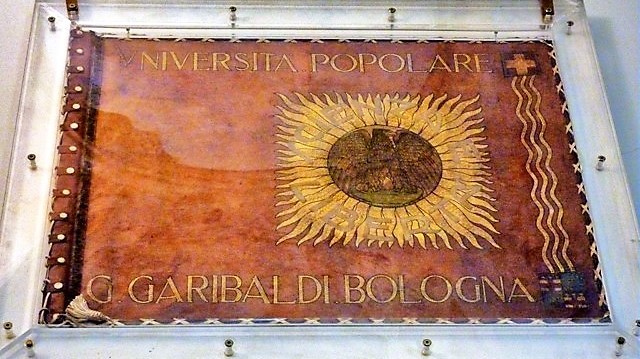Cronologia di Bologna dal 1796 a oggi
Archivio di notizie sulla storia della città e del suo territorio dal 1796 ad oggi. Con riferimenti bibliografici, link, immagini.
-
1899Primo apparecchio radiologicoAll'Istituto Ortopedico Rizzoli, per volere del direttore prof. Alessandro Codivilla, è realizzata una camera per le radiografie e vengono prodotte con successo lastre ai raggi X. L’impianto radiografico, realizzato dalla ditta Erneke di Berlino, è il primo installato in Italia. La scoperta dei raggi Roentgen risale a soli quattro anni prima (1895).dettagli
-
1899I nuovi palazzi Giordani e MaccaferriAlla conclusione di via Indipendenza, presso Porta Galliera, sono edificati i palazzi Giordani e Maccaferri. Il primo è opera dell'ing. Giuseppe Ceri (1839-1925) e ospiterà il caffè teatro Verdi; il secondo, progettato da Attilio Muggia (1861-1936) lungo il portico della Montagnola, conterrà al suo interno l'Eden Kursaal, primo café-chantant a Bologna. Entrambi gli edifici mostrano uno stile costruttivo neorinascimentale, di genere aulico e borghese. Nel 1896, durante lo scavo delle fondamenta di Palazzo Giordani, sono stati rinvenuti resti della Rocca di porta Galliera, che anticamente occupava una vasta area a ridosso delle mura cittadine e che fu per cinque volte atterrata dai bolognesi tra il XIV e il XVI secolo.dettagli
-
1899Lo zuccherificio di BolognaSi svolge la prima campagna produttiva dello zuccherificio di Bologna, controllato dall'Eridania, società fondata a Genova il 27 febbraio 1899 e sostenuta dal Credito Italiano. L'azienda ha da poco inaugurato la sua attività nel latifondo di Codigoro (FE). Nel 1900 aprirà un nuovo impianto a Forlì. Consoliderà poi la sua leadership nel campo della produzione saccarifera, in grande espansione nel corso del Novecento: negli anni Cinquanta saranno suoi 31 degli 82 zuccherifici attivi sul territorio nazionale. L'impianto bolognese, che sorge fuori porta Lame, nell'area della villa del famoso cantante Farinelli (sec. XVIII), risulterà uno dei maggiori. Distrutto durante la seconda guerra mondiale, sarà poi ricostruito e funzionerà fino al 1971. La coltivazione della barbabietola da zucchero avrà per tutto il secolo grande sviluppo nel territorio bolognese, come in Romagna e nel Ferrarese. I terreni fertili della pianura padana saranno in grado di assicurare grande produttività. Nel 1927 si costituirà nel capoluogo la Federazione Nazionale Bieticoltori (FNB), trasformata nel 1932 in Associazione Nazionale Bieticoltori (ANB). In tutta la Bassa bolognese sorgeranno stabilimenti per la produzione e il confezionamento dello zucchero: i principali a San Pietro in Casale, San Giovanni in Persiceto, Minerbio, Crevalcore, Molinella.dettagli
-
1899Ugo Valeri a BolognaUgo Valeri (1873-1911), giovane artista padovano, frequenta a Bologna l'Accademia di Belle Arti e entra a far parte della locale scapigliatura. Si accompagna ad altri “irregolari” come lui, quali Athos Casarini (1883-1917) e Alfredo Protti (1882-1949). Presto si dimostra "pittore di straordinario estro, disegnatore della più capricciosa e squisita originalità". Ha grandi doti di caricaturista: ritrae i suoi professori con una schiettezza che desta meraviglia. Umberto Notari (1878-1950) gli fa subito illustrare i suoi romanzi, Quelle signore, Fufù, Maiale nero, I tre ladri e lo invita a ritrarre attori e attrici sulle sue riviste, "La Lettura" e "L'Illustrazione italiana". Dopo aver vissuto randagio fra Padova, Bologna, Milano, Venezia, Napoli, Valeri morirà tragicamente nel 1911, cadendo dal balcone di Cà Pesaro a Venezia. Il necrologio pubblicato dalla rivista "Il Veneto" parla di uno "strano spirito pensoso fatto di contraddizioni, incalzato dal desiderio di risolvere un enigma che era in lui stesso, che avvertiva dovunque intorno a sé, di trovare un’espressione d’arte a questo tormento". Il suo disegno, affine a quello di Toulouse-Lautrec, mostra una grande vitalità, un "instancabile dinamismo del tratto" (C. Mezzalira), l'urgenza di ritrarre la vita moderna, le strade animate dalla folla e dalle luci.dettagli
-
1899"Rime e ritmi" ultima raccolta poetica di CarducciLa casa editrice Zanichelli pubblica Rime e ritmi, ultima raccolta poetica di Giosue Carducci (1835-1907). Contiene 29 liriche composte nei dieci anni precedenti. La maggior parte di esse sono già state pubblicate, anche se in seguito riviste e accuratamente "levigate". Solo cinque sono inedite. Ci mostrano un Carducci crepuscolare, combattivo, fedele a se stesso e alle utopie della sua giovinezza. Si susseguono vari temi e toni: si tratta di una sintesi completa della sua attività lirica più tarda. Egli è consapevole di essere al termine della sua parabola creativa e con l'ultima lirica prende congedo dalla poesia: Fior tricolore, Tramontano le stelle in mezzo al mareE si spengono i canti entro il mio core.dettagli
-
1899Giuseppe Bellei e le ricerche sul "lavoro cerebrale" nelle scuoleNel 1898 i medici Alfredo Boselli e Giuseppe Bellei, responsabili della Sezione scolastica dell'Ufficio municipale d'igiene, visitano oltre 8.000 bambini delle scuole elementari di Bologna. Intendono misurare l'accrescimento corporeo infantile. Dalla ricerca emerge che oltre il 40 per cento degli scolari mostrano un netto dimagrimento nel corso dell'anno scolastico. Il calo di peso è messo in relazione con lo stato sociale delle famiglie di provenienza: il fenomeno è infatti prevalente nelle classi più disagiate. Presentando nel 1899 i risultati dell'indagine, i due medici dichiarano di voler sviluppare il lavoro in direzione psicologica. Secondo loro la medicina scolastica non deve limitarsi all'osservazione delle malattie, ma "esplicarsi nello studio delle qualità psichiche e morali, dello sviluppo dell'intelligenza, delle condizioni che ostacolano o difficultano il lavoro cerebrale, delle cause che diminuiscono o favoriscono l'attenzione". I dati raccolti serviranno a regolare i metodi di insegnamento "col maggiore vantaggio intellettuale e col minore danno". Ad occuparsi dell'approccio psicologico sarà soprattutto il dott. Giuseppe Bellei (1866-1938), allievo di Cantalamessa e Ruggi, dotato "di uno spirito versatile e poliedrico di ricerca" e "aperto a una pluralità di metodi differenti di studio". Nel 1901 pubblicherà una relazione su La stanchezza mentale nei fanciulli delle pubbliche scuole, prima inchiesta in Italia sul lavoro mentale scolastico. Dal 1907 guiderà il laboratorio batteriologico e cinque anni più tardi assumerà la direzione dell'Ufficio municipale d'Igiene, al posto di Fausto Monetti. Le sue capacità saranno dimostrate dai buoni provvedimenti presi in occassione dell’epidemia di colera dell'estate 1911 e di quella di vaiolo dell’inverno 1917. Durante la grande guerra, con l'Ufficio d'Igiene requisito dall'autorità militare, Bellei dirigerà i Servizi di profilassi dell’Ospedale Militare di Bologna.dettagli
-
1899Giacomo Puccini aggregato all'Accademia FilarmonicaGiacomo Puccini (1858-1924) viene aggregato all'Accademia Filarmonica di Bologna. Il grande compositore prosegue una tradizione familiare. Risultano infatti tra gli accademici alcuni suoi avi, maestri di cappella a Lucca: Giacomo senior, Antonio e Domenico Puccini. Nella primavera del 1945 l'Accademia riceverà in custodia un fascicolo di appunti autografi, di eccezionale valore, della Madama Butterfly, che da allora conserverà gelosamente nel suo archivio.dettagli
-
1899Debutto del baritono Riccardo StracciariSostituendo il famoso baritono Giuseppe Kaschmann, debutta al Teatro comunale il giovane Riccardo Stracciari (1875-1955), originario di Casalecchio di Reno ed ex allievo del Liceo musicale di Bologna. Canta nella Risurrezione di Lazzaro, oratorio in due parti per canto ed orchestra di don Lorenzo Perosi (1872-1956). La sua carriera decollerà subito dopo. Nel 1904 sarà alla Scala e nel 1906 al Metropolitan di New York. Verrà apprezzata la sua voce morbida, “dagli acuti sonori”, così come “la correttezza della linea del canto” e la presenza scenica. Sarà grande esecutore delle opere di Verdi e Donizetti, ma il suo cavallo di battaglia sarà il ruolo di Figaro nel Barbiere di Siviglia, che interpreterà per oltre 1.400 volte. Nel 1909 sarà iniziato a Carrara alla massoneria. Si ritirerà dalle scene nel 1937 e dal 1940 insegnerà canto in forma stabile a Roma. Lo si ascolterà per l’ultima volta nel 1944 al Teatro Sociale di Como, dove interpreterà Germont nella Traviata.dettagli
-
gennaio 1899Il trasformista Fregoli al Teatro del CorsoIn gennaio il trasformista Leopoldo Fregoli (1867-1936) si esibisce con successo al Teatro del Corso. In estate il trionfo si ripete al Politeama D'Azeglio per molte serate, agevolato anche dall'annuncio dell'illuminazione del teatro con la luce elettrica. Fregoli ha cominciato la sua carriera teatrale durante il servizio militare, iniziato a Bologna nel 1889 e proseguito a Massaua in Africa. Qui, per lo scarso numero di attori disponibili, fu costretto a recitare più ruoli, inventando così il nuovo genere del trasformista. Dal 1893, con la Compagnia di Varietà Internazionale da lui fondata, ha effettuato spettacoli in tutta Italia e all'estero: in Spagna, in America Latina e negli Stati Uniti. Nel 1897, durante uno spettacolo a Lione, ha conosciuto i fratelli Lumière e da allora ha introdotto brani di cinema nel suo show, ribattezzato Fregoligraph.dettagli
-
16 gennaio 1899Impianto idroelettrico per l'Istituto Rizzoli alla GradaL'Istituto Ortopedico Rizzoli affitta alcuni locali dell'opificio della Grada e vi impianta due turbine idrauliche a reazione tipo americano della ditta Alessandro Calzoni per la produzione di energia elettrica. Essa è condotta poi sulla collina di San Michele in Bosco tramite una linea dedicata su pali posata lungo i viali di circonvallazione o addossata alle mura. Una ulteriore turbina sarà alloggiata nel tornacanale, ricavato nel 1845. L'impianto idroelettrico del Rizzoli rimarrà in funzione fino al 1926. Nel 1930 le turbine saranno smantellate, dopo la scadenza del contratto di affitto dell'opificio tra il Rizzoli e il Consorzio del Canale di Reno.dettagli
-
16 gennaio 1899Emma Consolini dirige un concerto per 24 arpeIn occasione di una Accademia vocale e strumentale a favore della Cassa Soccorso Studenti poveri e Colonie estive che si tiene al Teatro comunale il 16 gennaio, Emma De Stefani Consolini (1864-1936) dirige la Marcia Solenne di Gounot-Thomas eseguita da 24 “signorine arpiste“. Originaria di Parma, allieva di Giorgio Lorenzi al conservatorio di Firenze - dove si è diplomata col massimo dei voti - ha vinto nel 1887 il concorso per la Scuola d'Arpa nel Liceo musicale di Bologna. Oltre che essere un‘ottima strumentista, si cimenta nella composizione e nella direzione. In un concerto del 1906 farà suonare assieme 32 arpe e 30 violini. Nel 1904 Ugo Pesci scriverà che Emma "raccogliendo le sue allieve passate e presenti può mettere insieme un mezzo battaglione d’arpiste", pur essendo ancora giovane. Insegnerà nel liceo bolognese fino al 1928. Dalla sua scuola usciranno “le più acclamate arpiste d‘Italia“. Lascerà diversi pezzi e il manuale Scale in tutti i toni per arpa.dettagli
-
18 gennaio 1899La commedia "Acqua e ciacher" di TestoniAl Teatro Contavalli la Compagnia Bolognese di Goffredo Galliani mette in scena Acqua e ciacher (Acqua e chiacchere), ultima fatica di Alfredo Testoni (1856-1931). Il commediografo è lodato sul numero di gennaio di “Bologna che dorme” per la sua genialità, le “ottime qualità sceniche” e la sua determinazione a rinnovare i fasti del teatro dialettale che “amò tanto e tanto rinsanguò, e che ancora tanto aspetta da lui”.dettagli
-
marzo 1899Il Ricreatorio della Società OperaiaIl Comitato d'Istruzione della Società Operaia mette a punto un programma di istruzione popolare, che coinvolge i suoi soci adulti, ma anche i loro figlioli e familiari. Entro due anni sono avviate tre istituzioni complementari: la Università Popolare, la Sezione di Ginnastica e il Ricreatorio. Quest'ultimo è definito dalla “Squilla” socialista il “Ricreatorio laico”, per distinguerlo dai ricreatori cattolici, che in questo periodo sorgono in vari punti della città. E' riservato a bambini e ragazzi tra i sei e i sedici anni. Inizialmente funziona solo d'estate: offre una refezione gratuita e propone corsi di ripetizione, distribuzione di testi scolastici e opuscoli educativi, organizza gite e passeggiate campestri. Nel 1904 diventerà stabile tutto l'anno e troverà una sede adeguata in via Schiavonia. La sua attività comprenderà, oltre allo studio e ai lavori manuali, passeggiate istruttive, canto e fanfara. Il prof. Remigio Legat sarà incaricato della educazione fisica dei ragazzi iscritti. Al Ricreatorio diurno sarà presto aggiunto un Ricreatorio serale e domenicale per giovani operai fino ai diciotto anni.dettagli
-
3 marzo 1899Illuminazione elettrica dal Mulino del PalloneIn attesa di una moderna centrale al Battiferro, l'energia elettrica è generata in un'officina provvisoria installata al Mulino del Pallone, che comprende un alternatore trifase da 300 HP. La piccola rete di distribuzione tocca Palazzo Maccaferri, dove ha sede l'Eden Kursaal, e si spinge fino all'hotel Brun in piazza Malpighi. Un primo esperimento di illuminazione elettrica pubblica è stata fatta, con scarso successo, durante l'Esposizione del 1888.dettagli
-
20 marzo 1899Carducci denuncia in Senato le carenze dell'Università di BolognaIl un discorso tenuto al Senato il 20 marzo Giosuè Carducci denuncia le carenze delle strutture dell'Università di Bologna. Esse risalgono agli anni Sessanta, quando gli studenti erano 400, contro gli oltre 1.800 attuali. Mancano gli spazi per le scuole di chimica, fisica e “farmaceutica”. Gli studenti di filologia (i suoi studenti!) sono costretti a far lezione nelle aule dell’Istituto di mineralogia. “E contro i sassi hanno un cattivo contrastare le idee”. Il poeta non è nuovo a mettere in evidenza il problema. Nel 1888 in consiglio comunale la sua analisi sulla scarsa iniziativa a Bologna a favore degli studi superiori era stata impietosa: “Nel primo decennio della costituzione del Regno di Italia fu languore e indifferenza per tutto, massime in Bologna, per l’insegnamento”. E le cose non migliorarono nel secondo decennio: mentre altre città favorirono l’incremento dei propri istituti, a Bologna non si fece praticamente nulla. In quella occasione aveva avvertito del pericolo di una "fuga di cervelli": i professori, aveva detto, “possono dileguarsi quando i mezzi, gli strumenti, il luogo mancano a insegnare la scienza come i tempi richiedono; quando mancano gli insegnanti complementari, quando ... manca l'aria, l'ambiente, il mezzo; mancano laboratori, macchine, libri, biblioteche speciali”.dettagli
-
27 marzo 1899Il telegrafo di Marconi attraversa la ManicaSu richiesta del governo francese Guglielmo Marconi realizza le prime trasmissioni telegrafiche senza fili attraverso il canale della Manica, tra le stazioni di Wimereux, vicino a Boulogne sur Mer, e South Foreland. Il 27 marzo ha luogo il primo collegamento radio. In luglio due navi della Marina britannica si scambiano messaggi fino a 140 chilometri. Il 3 marzo precedente alcuni marinai di un piroscafo, che per la nebbia ha urtato un battello-faro nella Manica, sono stati i primi naufraghi salvati grazie alla radio. Marconi si sposta negli Stati Uniti al seguito delle regate di Coppa America: ogni tre minuti i giornali di New York ricevono suoi messaggi via radio sull'andamento delle gare da una cabina del piroscafo Ponce.dettagli
-
14 aprile 1899Bagno pubblico in via D'AzeglioIl barbiere Alberto Fabrizi chiede il permesso di aprire un bagno pubblico annesso al suo negozio in via D'Azeglio n. 3. Esso comprende una sala d'aspetto e due locali per la doccia, mentre nel cortile del fabbricato si trova "un cesso regolare".dettagli
-
17 aprile 1899Il pranzo degli accattoniIn occasione delle nozze d'argento sacerdotali del cardinale Svampa, 450 poveri sono invitati ad un pranzo nella chiesa del Sacro Cuore. La piaga dell'accattonaggio è a Bologna particolarmente vistosa: 284 persone chiedono l'elemosina in pubblico e sono più di 800 gli anziani indigenti che attendono di entrare nel ricovero di mendicità. Ha grande eco sulla stampa una iniziativa dell'amministrazione comunale, che si propone di internare gli accattoni. Per Federico Marzocchi, che scrive con lo pseudonimo di Chiappini su “Bologna che dorme”, "la vista della miseria offende i borghesi gaudenti e ne turba la digestione” e propone ironicamente di “militarizzare la classe dei questuanti".dettagli
-
29 aprile 1899Festa di beneficenza pro operaie anemicheDal 29 aprile al 1° maggio si tiene ai giardini R. Margherita una festa di beneficenza pro operaie anemiche. Per promuoverla è stampata una cartolina illustrata da Alfredo Baruffi (1873- 1948), artista rappresentativo del Liberty bolognese.dettagli
-
5 maggio 1899Il Comitato per Bologna Storica e ArtisticaSi costituisce il 5 maggio il Comitato per Bologna Storica e Artistica (BSA), un ente privato sussidiato dal Comune, che ha come scopo “di vigilare, favorire e promuovere quanto giovi alla tutela e all'intelligente restauro degli edifizi pubblici e privati, onde conservare alla città il suo carattere storico ed artistico”. Tra i soci fondatori vi sono il conte Francesco Cavazza (1860-1942), l'ing. Tito Azzolini (1837-1907) e altri notabili e professionisti bolognesi. Alfonso Rubbiani (1848-1913) funge consulente artistico. Primo presidente è l'ex sindaco Gaetano Tacconi (1829-1916). Cavazza gli succederà dal 1907 al 1942. In occasione dei tradizionali Addobbi delle Parrocchie - festa decennale che comporta la ripulitura dei palazzi e delle strade dei quartieri cittadini - il Comitato studia preventivamente quali edifici sono bisognosi di restauro artistico e offre gratuitamente ai proprietari l'opera dei propri artefici, concorrendo spesso anche alle spese. Compie, inoltre, attività di propaganda presso i proprietari e le ditte incaricate dei restauri, perché questi siano effettuati con criteri di buon gusto e secondo la tradizione. Oltre che il restauro di una cinquantina di edifici storici, tra i più importanti della città, il Comitato curerà - a partire dal 1928 - la "Strenna Storica Bolognese", preziosa raccolta di studi storici sulla città. Farà collocare numerose lapidi in città a ricordo di uomini illustri e di fatti notevoli della storia cittadina. Il primo socio onorario del benemerito sodalizio sarà, nel 1901, il poeta Giosue Carducci.dettagli
-
14 maggio 1899Corteo ciclistico del Touring ClubIl Touring Club Ciclistico Italiano (fondato a Milano l'8 novembre 1894) organizza in piazza Maggiore un grande raduno corteo di velocipedisti, nel 50. anniversario dell’assedio di Bologna da parte degli Austriaci. Il comitato dei festeggiamenti estende l'invito a prendere parte alla manifestazione ai sindaci della provincia, ai quali si chiede di farsi accompagnare dalle rispettive bande municipali. In piazza Maggiore il sindaco Dallolio tiene per tutti un discorso commemorativo. In occasione del congresso si svolge anche una gara motociclistica, vinta da Attilio Caffarati su una moto Carcano. Il Touring è definito dai bolognesi, per via della sigla TCCI, il "Club dello starnuto". Le prime biciclette sono molto costose (fino a 900 lire) e quindi privilegio dei più ricchi. Per imparare occorre un apprendistato, che gli appassionati bolognesi fanno alla Montagnola, affittando i velocipedi al noleggio Pelloni. Tra i primi ciclisti escursionisti, vi sono il dilettante fotografo Giuseppe Michelini e i letterati Alfredo Oriani (1852-1909) e Olindo Guerrini (1845-1916), autore dell'inno del Touring e di odi alle due ruote: “sovra il ferreo corsier passo contentocome a novella gioventù rinato,e sano e buono e libero mi sento”dettagli
-
18 maggio 1899La "Gioconda" di D'Annunzio al Teatro DuseIl 18 maggio Eleonora Duse e Ermete Zacconi tengono, nel teatro dedicato all'attrice, una recita straordinaria della Gioconda. I due interpreti sono giudicati sublimi e l'allestimento ottimo. Il pubblico ritiene semmai discutibile il testo di Gabriele D'Annunzio. La tragedia in quattro atti, scritta nel 1898, mette in scena il conflitto tra le esigenze morali, il piacere e l'estetica. Tra Silvia, angelo del focolare, e la seducente modella Gioconda Dianti, lo scultore Settala sceglie la seconda, portando la prima al sacrificio. Dopo questo spettacolo il teatro chiude per un pò di tempo, per riaprire con "un brevissimo corso di rappresentazioni col Cinematografo Lumière".dettagli
-
20 maggio 1899La Commissione provinciale per la pellagraIl Consiglio provinciale nomina una Commissione permanente per lo studio e la cura della pellagra, grave piaga sociale comparsa alla fine del Settecento nella pianura Padana e nei paesi dell’Appennino. Intorno al 1880 in Emilia-Romagna oltre 18.000 persone, quasi un quarto dei lavoratori agricoli della regione, risultavano pellagrosi. Nel 1878 quasi la metà dei pazienti entrati nel manicomio di Ferrara erano “poveri contadini pellagrosi”. Nel 1898, anno di fame, sono stati censiti 755 pellagrosi, per la maggioranza braccianti. Dal 1887 al 1902 vi sono 1.284 morti per pellagra e 531 persone sono ricoverate in manicomio. La malattia dipende dalle precarie condizioni economiche della popolazione delle campagne ed è causata soprattutto da una dieta poco equilibrata, basata sul consumo quasi esclusivo di polenta di mais. E’ conosciuta anche come “la malattia delle tre D”, per i sintomi che la caratterizzano nelle varie fasi di avanzamento: dermatite, diarrea, demenza. Nell’ultimo stadio, detto frenosi pellagrosa, il paziente presenta segni di squilibrio nervoso e di pazzia e necessita del ricovero nell’Ospedale psichiatrico. La Commissione si attiverà per l’apertura, in vari comuni della provincia, di locande sanitarie, in cui agli ammalati saranno offerti assistenza medica e cibo più variato. Nel 1902 organizzerà a Bologna il II Congresso pellagrologico italiano.dettagli
-
22 maggio 1899Prima gara automobilisticaNell‘ambito del Convegno Turistico organizzato dal Touring Club il 22 maggio si corre la prima gara automobilistica intorno a Bologna. Il percorso di circa 80 chilometri tocca San Pietro in Casale, Poggio Renatico e Malalbergo con ritorno in città e arrivo davanti alla fabbrica della ditta Casaralta. Il circuito deve essere completato entro le tre ore e mezzo. Sono ammesse vetture vetturette e tricicli. E' iscritto anche il noto costruttore Ettore Bugatti. Dei dodici partenti solo sette giungono al traguardo e vengono classificati. Tra le vetturette vince Emile Laporte su Orio-Marchand in 2 ore e 23 minuti. Tra i tricicli primeggia Attilio Caffaratti di Pinerolo su Perfecta in 2 ore e 5 minuti, alla “folle” media di 38 km orari. Visto il grande successo dell‘iniziativa, l'anno successivo la corsa sarà replicata.dettagli
-
18 giugno 1899Bagno pubblico in Piazza XX SettembreIn Piazza XX Settembre l'ing. Filippo Buriani costruisce un grande bagno pubblico, secondo il progetto approvato dalla Giunta comunale nel 1894. Si tratta di un bagno ad aspersione, dotato di cabine doccia, brevettato nel 1883 dal dermatologo tedesco Oscar Lassar e pienamente "rispondente all'esigenze e dell'igiene e dell'economia". Per il sindaco Alberto Dallolio si tratta di un vero e proprio "istituto educativo", che deve ispirare al popolo "il sentimento della dignità personale, il rispetto del proprio corpo". L'inaugurazione avviene il 18 giugno 1899. Il costo del servizio è fissato in 25 centesimi e comprende anche l'uso di biancheria e sapone. E' aperto dalle 8 alle 18 nei giorni feriali e dalle 7 alle 17 nei festivi. Il suo utilizzo durerà fino al 1940, quando il Comune, per motivi speculativi, venderà l'area all'Istituto Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (poi INAIL), intenzionato a costruirvi la sua sede. Anche dopo la demolizione dei bagni pubblici, però, e nonostante la redazione di un accurato progetto di recupero a cura dell’arch. Alberto Legnani, lo spazio rimarrà a lungo libero e allestito a giardino. L'albergo in seguito costruito su quest'area sarà definito "uno dei più evidenti scempi della speculazione edilizia del dopoguerra a Bologna".dettagli
-
25 giugno 1899Alle amministrative vincono i liberali conservatoriAlle elezioni amministrative parziali che si tengono domenica 25 giugno i socialisti e i radicali trionfano ad Alessandria, Pavia, Ferrara e Piacenza. A Roma le votazioni sono favorevoli ai clericali. A Bologna, come a Biella e a Foligno, prevalgono i liberali conservatori. Il 12 luglio viene rieletto sindaco il liberale Alberto Dallolio (Dall'Olio, 1852-1935)dettagli
-
1 luglio 1899L'on. Andrea Costa arrestato a BolognaIl deputato socialista Andrea Costa (1851-1910), che ha perduto l'immunità parlamentare (art. 45 dello Statuto), viene arrestato e incarcerato a Bologna. Deve scontare alcuni mesi di prigione per reati di stampa risalenti al 1895.dettagli
-
27 agosto 1899La Pro Montibus et Sylvis e la Festa degli AlberiIl conte Cesare Ranuzzi Segni (1856-1947) fonda la Società Emiliana Pro Montibus et Sylvis, parte dell'associazione naturalistica sorta a Torino nel 1898 per iniziativa del Club Alpino Italiano (CAI). In questo modo alcuni notabili di Castiglione dei Pepoli, Porretta Terme e Bologna intendono affrontare il problema del depauperamento delle risorse produttive della montagna, in particolare di quelle forestali. Il 27 agosto la Pro Montibus organizza, a Castiglione dei Pepoli, la prima Festa degli Alberi mai celebrata in Italia, su modello di quella nata negli Stati Uniti nel 1872. Un grande pino bianco del Canada viene piantato in un'aiuola circolare vicino alla chiesa e al fabbricato delle Colonie scolastiche. La stessa festa si tiene a Bologna il successivo 26 ottobre. A Villa Aldini gli alunni delle scuole piantano alberi per rendere i colli più verdeggianti. Nel 1903 sarà fondata la rivista quindicinale "L'Alpe", primo periodico italiano dedicato ai problemi forestali. Nel 1904 sarà istituita a Vergato la prima cattedra di alpicoltura.dettagli
-
9 settembre 1899Gli atleti della Virtus al Concorso Nazionale di ComoGli atleti della Virtus Società Ginnastica Educativa partecipano con successo al concorso ginnico internazionale, che si svolge a Como in occasione dell’Esposizione per i cento anni della pila di Volta. Nella gara B di squadra la Virtus vince la Corona d’Alloro e Giuseppe Medici primeggia nel sollevamento pesi. Nel concorso atletico si pone in evidenza uno dei primi campioni polivalenti della società bolognese, Romeo Monari, vincitore nel salto in alto, nel salto con l’asta e nel getto del sasso. Alessandro Pederzoli, altro atleta Virtus, vince il Campionato e la Categoria Plinio nelle gare di Tiro a Segno, che si svolgono il 16-17 settembre. L’8 luglio, a causa di un corto circuito elettrico, un incendio ha distrutto completamente i padiglioni dell'Esposizione, compresa la rimessa con i nuovi tram destinati al servizio cittadino. Le strutture sono state ricostruite a tempo di record grazie a una pubblica sottoscrizione.dettagli
-
1 ottobre 1899IX Congresso degli ingegneri e architetti italianiDal 1° all'8 ottobre si tiene a Bologna, presso la Sala dei Notai e la Scuola di Applicazione degli Ingegneri, il IX Congresso degli ingegneri e architetti italiani. Tra i 450 iscritti vi sono i maggiori esponenti emiliani, quali Alfonso Rubbiani, Edoardo Collamarini, Attilio Muggia, Leonida Bertolazzi, Gaetano Rubbi. Ma vi sono anche assenze significative, come quella dell’ing. Paolo Sironi, autore del quartiere di villette in stile liberty fuori porta Sant’Isaia. A nome del Collegio degli Ingegneri ed Architetti Bolognesi, Rubbiani dedica al congresso il suo saggio su La chiesa di S. Francesco e le tombe dei glossatori in Bologna (Zamorani e Albertazzi, 1999). Tra le deliberazioni conclusive vi è la promozione dell'insegnamento artistico nelle scuole d'applicazione d'ingegneria. Il diploma di Accademia non ha, infatti, valore legale per l'esercizio della professione. La Scuola Superiore d'Architettura, che diverrà in seguito Facoltà di Architettura, sarà aperta solo nel 1919. Durante il congresso vengono effettuate escursioni a Bologna, presso la Scuola Comunale di Porta Galliera, il Mercato bestiame, l'Istituto Ortopedico Rizzoli; ai “superbi monumenti antichi di Ravenna” e nella provincia ferrarese, con visite a Pomposa, alle bonifiche e agli stabilimenti di Codigoro e Marozzo, alla Botte sul Panaro di Bondeno. Degna di nota è anche l'Esposizione di Architettura e d'Arte Applicata aperta per l'occasione, notevole “in riguardo specialmente ai lavori architettonici esposti da valenti giovani architetti”.dettagli
-
4 novembre 1899La chiesa di San Paolo di RavoneFuori porta Sant’Isaia inizia, su progetto dell’ing. Giuseppe Ceri (1839-1925), la ricostruzione della chiesa di San Paolo di Ravone, di origini antichissime. Il 4 novembre, alla presenza del cardinale arcivescovo Domenico Svampa, è posata la prima pietra. Occorreranno però cinque anni per l’inaugurazione (4 ottobre 1904), dopo non poche polemiche tra l’impresa e i parrocchiani. Il lavoro sarà per il vulcanico Ceri fonte di delusione e di gravi dispiaceri “per gli stravolgimenti apportati al progetto dalle autorità” (Buitoni). Sarà comunque avviata la bonifica definitiva dell’alveo del torrente Ravone, che scorre poco distante dalla chiesa. La canonica della parrocchia sarà edificata nel 1923-24 da Guglielmo Grimaldi.dettagli
-
26 novembre 1899Festa delle MatricoleIl 26 novembre si svolge la Festa delle Matricole. Celebra la sempre più numerosa presenza di studenti iscritti all'Alma Mater. Al mattino i goliardi si recano alla stazione per ricevere i rappresentanti degli altri atenei, provenienti soprattutto dall'Emilia e dal Veneto. Nell'aula magna dell'Università il Rettore tiene un discorso alle matricole, sottolineando il significato della consegna dei berretti - rito di lontane origini tedesche - come momento di liberazione dal giogo dell'autorità e come augurio per la libertà di pensiero. Concluso l'intervento di Puntoni, gli universitari si avviano in corteo, accompagnati dalla banda, verso la chiesa di Santa Lucia, sede della Società sportiva Virtus, addobbata per l'occasione di bandiere e festoni d'edera. Qui, tra canti, balli e brindisi, si svolge la vera e propria cerimonia di "imberettamento". La festa si conclude a notte fonda con una fiaccolata per le vie del centro. A ricordo della Festa viene stampata una cartolina, illustrata da Augusto Majani (Nasica). Del corteo degli studenti rimane una foto, ripresa davanti a San Petronio, del dilettante Francesco Cecchi.dettagli
-
1 dicembre 1899Testoni recita la "Sgnera Cattareina"La sera del 1° dicembre 1899, nell'atrio del Teatro Comunale, Alfredo Testoni recita per la prima volta in pubblico I sonetti della Sgnera Cattareina, personaggio nato quasi per caso sulle pagine della rivista "Bologna che dorme", che accompagnerà il drammaturgo per tutta la sua carriera, assieme a quello del cardinale Lambertini. La vecchietta chiaccherona, incarnazione della saggezza popolare, è incaricata daTestoni di svelare bonariamente vizi e virtù del popolo bolognese. Nel 1904 l'editore Nicola Zanichelli darà alle stampe la prima edizione "compita" dei sonetti, con le illustrazioni di Nasica. Altre edizioni compariranno nel 1908 e nel 1910, fino all'ultima del 1945. Testoni effettuerà molte dizioni pubbliche nei teatri italiani, alternando i suoi sonetti alle liriche del poeta crepuscolare veronese Berto Barbarani e del romano Trilussa. Nel 1929 La sgnera Cattareina diventerà una commedia, ideata per Maria Melato e rappresentata nel 1930 dalla bolognese Guglielmina Dondi. Un'altra grande interprete sarà Argia Magazzari.dettagli
-
10 dicembre 1899Volo in pallone del comandante MerighiDomenica 10 dicembre il comandante Giacomo Merighi, un ex artista ambulante, divenuto “ginnastico” e areonauta, si alza in volo dall'Arena del Pallone, diretto in Toscana. La “spettacolare esibizione” è finanziata dalla Società Maestrani, ditta di cioccolato, e serve a finanziare gli asili infantili. Con Merighi ci sono il dott. Massimo Bartoletti e il dott. Vincenzo Lodi, economo del Comune. Assistono numerose personalità, quali il conte Cavazza e il commendator Sanguinetti. La ditta Maestrani distribuisce alle signore intervenute e ai bambini i suoi rinomati cioccolatini. L'aerostato si stacca da terra alle 14 circa, raggiunge rapidamente i 900 metri di quota e atterra presso la villa Gotti a S. Ruffillo. Il volo risulta notevolmente ridotto rispetto al previsto, forse per la paura di uno dei passeggeri. All'arrivo il comandante Merighi viene congratulato da alcuni spettatori, che hanno seguito il pallone in carrozza.dettagli
-
20 dicembre 1899Proiezioni e fonografo all'Arena del SoleDal 20 dicembre Salvatore Cucumazzi Spina espone un fonografo nell'atrio dell'Arena del Sole. Il permesso è stato rilasciato dalla Questura a condizione che non siano riprodotti discorsi politici. Fino al 1908, nei mesi invernali, l'atrio dell'Arena ospiterà spettacoli cinematografici: il Reale cinematografo Gigante (1902-1903) e il Cinematografo Edison (1903-1908) della famiglia Bocher, presente con un baraccone anche nella vicina piazza VIII Agosto. Nel 1915 le proiezioni, gestite da Felice Galli e Alberto Grazia, si sposteranno all'interno del teatro, trasformato in Politeama Garibaldi, grazie a una tettoia che lo rende agibile anche nella cattiva stagione.dettagli