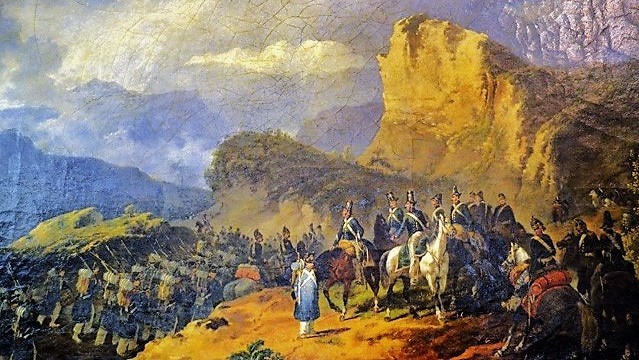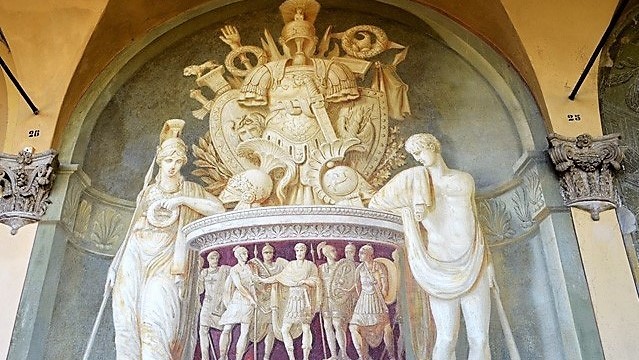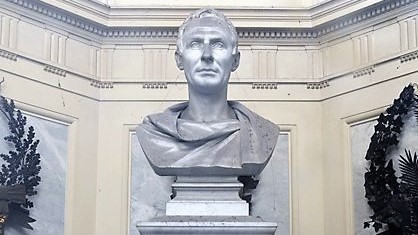Cronologia di Bologna dal 1796 a oggi
Archivio di notizie sulla storia della città e del suo territorio dal 1796 ad oggi. Con riferimenti bibliografici, link, immagini.
-
1844La popolazione di BolognaIl “Diario ecclesiastico bolognese” documenta il persistere di una condizione di precarietà e indigenza per gran parte della popolazione bolognese. Su 71.547 abitanti (33.782 maschi e 37.765 femmine), il 29,9% sono operai e artigiani, il 15,7% inservienti e il 18,7%, cioè 12.983 persone, risultano sussidiati e mendicanti. Oltre 6.500 persone, invece, vivono di rendita e circa 3.500 appartengono a categorie privilegiate, come i nobili, gli ecclesiastici e i magistrati.dettagli
-
1844Una Società per la strada ferrataUn gruppo di privati cittadini promuove una Società avente come scopo la realizzazione di una strada ferrata che da Padova scenda verso sud lungo la sponda sinistra del Po e, attraverso Bologna, metta in comunicazione il mare Adriatico con il Mediterraneo. La questione ferroviaria è ormai aperta da alcuni anni in Italia: la creazione di una estesa rete è vista come una necessità per lo sviluppo economico della penisola. Per molti, come Minghetti e Cavour, è anche la via privilegiata per la sua unificazione politica.dettagli
-
1844Coperto il canale in via AvesellaTra il 1844 e il 1845 è coperto il canale che scorre all'aperto in via Avesella, nei pressi del Santuario della Pioggia. Lo stesso intervento fu fatto alla fine del XVII secolo per il canale di Savena, che scorreva "scoperto e lurido" lungo via Castiglione, coprendolo "con opportune volte, allargando la strada, facendola sicura e salubre".dettagli
-
1844Un viale esterno alle muraTra il 1844 e il 1851 l'ingegnere comunale Giuseppe Baretti realizza un nuovo viale esterno alle mura, accogliendo le proposte di Filippo Antolini per Porta Santo Stefano.dettagli
-
1844Il romanzo "Clelia, ossia Bologna nel 1833"E' pubblicato a Malta il romanzo Clelia, ossia Bologna nel 1833. Contiene una precisa disamina della situazione politica cittadina durante e dopo la rivoluzione del 1831, descritta come un mutamento “rapido, sicuro, non brutto di civil sangue”. Sul frontespizio del libro è raffigurata una loggia della Certosa, teatro dell'amore impossibile di una giovane nobildonna decaduta con un ufficiale austriaco. L'autrice del romanzo, Ifigenia Zauli Sajani, è moglie di un mazziniano forlivese affiliato alla Giovine Italia, costretto a fuggire dal suo paese dopo i moti del 1831-32. Collaboratrice del marito per le riviste "Il Mediterraneo" (1838-1845) e "La Speranza" (1846-1847), durante il soggiorno sull'isola pubblica vari libri, tra i quali II ritorno dell'emigrato (1842), Beatrice Alighieri (1842) e Gli ultimi giorni dei cavalieri di Malta (1840). La pubblicazione di Clelia verrà proibita nel Granducato di Toscana, assieme agli scritti di Foscolo e alle poesie di Giusti.dettagli
-
1844Un parafulmine per San LucaGrazie ad un lascito di Giovanni Aldini (1762-1834), nipote di Luigi Galvani, la cupola del santuario di San Luca è dotata di un parafulmine.dettagli
-
1844Nuova facciata per la chiesa della Madonna dei PoveriGaetano Cesari disegna la nuova facciata della chiesa di S. Maria Regina dei Cieli in via Nosadella. Essa ha origine da un antico ospedale per pellegrini dedicato a S. Maria delle Laudi. L'oratorio, da tempo abbandonato, fu riaperto da alcuni operai e nel 1577 vi fu fondata la Confraternita della Regina dei Cieli, detta anche dei Poveri, alla quale papa Clemente VIII concesse la facoltà di liberare un condannato a morte. La Madonna dei Poveri era molto venerata dai bolognesi. Ad essi si affidavano in occasione delle frequenti epidemie e pestilenze che affliggevano la città. La sacra immagine era portata in processione il 24 giugno, festa di S. Giovanni Battista, fino alla Basilica di S. Petronio. La Compagnia dei Poveri fu soppressa nel 1798, ma ripristinata nel 1822. Il santuario fu ricostruito e ampliato nel 1603, grazie alle donazioni dei fedeli. Affidato ai Domenichini, verrà restaurato nel 1870, ma subirà poi un lento declino. Dal 1912 sarà assegnato ai Sacerdoti del Sacro Cuore (padri dehoniani), che fino al 1926 avranno qui lo Studentato. All'interno della chiesa si conservano dipinti di Lionello Spada e Lucio Massari, mentre gli affreschi della cupola sono attribuiti a Gian Gioseffo Dal Sole.dettagli
-
1844Adeodato Malatesta: un nuovo corso per l'arte sacraSu commissione dei Padri Cappuccini, il pittore Adeodato Malatesta (1806-1891), direttore dell'Accademia di Modena, esegue il dipinto che raffigura Il matrimonio di Maria e Giuseppe per l'altare maggiore della chiesa di San Giuseppe, in costruzione fuori Porta Saragozza. La capacità di Malatesta di sintetizzare la tradizione pittorica italiana e di introdurre senza timore anche le istanze puriste è un segnale di rinnovamento che sarà raccolto dai migliori giovani artisti bolognesi, quali Alessandro Guardassoni (1819-1888), Pietro Montebugnoli (1820-1876) e Giulio Cesare Ferrari (1818-1899), che lo raggiungeranno a Modena. La partenza dei tre giovani avverrà non senza polemiche e dispetto all'interno dell'Accademia di Bologna.dettagli
-
1844Il manicomio di ImolaSu impulso del medico Cassiano Tozzoli (1785-1863) e con l'appoggio del vescovo Mastai Ferretti, futuro papa Pio IX, è aperto a Imola un nuovo manicomio, il primo in Romagna. Il luogo è chiamato "Asilo" ed è dotato di 80 posti letto. Accoglie malati dall'ospedale di S. Maria della Scaletta di Imola, ma presto anche dalle province di Forlì, Ravenna e Ferrara. Nel 1860 gli ospiti saranno 103. Nel 1869 l'istituto verrà ampliato a cura del prof. Luigi Lolli (1819-1896), direttore dell'ospedale civile, su progetto dell'arch. Carlo Cipolla di Napoli. Sarà formato da una serie di padiglioni indipendenti capaci di 800 posti letto. Nel 1890, in una vasta area agricola ai margini della città, verrà creato l'ospedale psichiatrico "Osservanza", struttura moderna destinata ai pazienti cronici, "incorreggibili". Nel 1897 la sede adiacente a Santa Maria della Scaletta, chiamata anche Villa dei Fiori, sarà acquisita dalla Provincia di Bologna e diventerà Ospedale psichiatrico provinciale "Luigi Lolli", con ammalati provenienti dall'area bolognese.dettagli
-
1844La Società dei Barbieri e ParrucchieriNel 1844 si costituisce la Società dei Barbieri e Parrucchieri, classe sociale importante a Bologna e formata per la maggior parte di persone colte. A dirigere il sodalizio è chiamato il marchese Luigi Pizzardi (1815-1871) "patrizio dei più amati e stimati in Bologna", che resterà in carica per 27 anni, fino alla sua morte. I barbieri non pagano una quota di ammissione, ma un contributo mensile di 50 centesimi. I "fattoretti" pagano invece 25 centesimi. Dopo un anno di ammissione i soci hanno diritto, in caso di malattia, a un sussidio di 50 centesimi al giorno, fino alla ripresa del lavoro. Essi possono chiedere un aiuto anche per la malattia di loro familiari. Viceversa questi ultimi possono ottenere soccorso in caso di morte del capo-famiglia aggregato. Gli affetti da malattia cronica hanno diritto al sussidio se hanno fatto parte della Società per almeno dieci anni consecutivi e hanno "esattamente compiuti i doveri di socio". Dopo l'Unità nel mese di maggio verrà dato doppio sussidio ai soci infermi per commemorare il primo solenne ingresso di re Vittorio Emanuele II a Bologna.dettagli
-
1844Ampliata la Quadreria dell'AccademiaLa Quadreria dell'Accademia di Belle Arti, collocata dal 1802 nell'ex collegio dei Gesuiti in Borgo Paglia, viene ampliata incorporando la cappella del convento, affrescata con l'Apoteosi di Sant'Ignazio, opera di un allievo di Andrea Pozzo. La sala, un tempo utilizzata per l'iniziazione dei novizi al sacerdozio, ospitò in seguito la scuola di pittura dell'Accademia. Da ora servirà come sala da esposizione, più avanti ospiterà lo scalone di accesso della Pinacoteca Nazionale. Il patrimonio della Quadreria, formatosi soprattutto con la chiusura di chiese e conventi nel periodo napoleonico, sarà aumentato ulteriormente dopo le soppressioni del 1867-68. Dal 1882 essa sarà resa autonoma dall'Accademia.dettagli
-
1844Il macello di MedicinaA Medicina (BO) viene costruito, su progetto dell’ing. Angelo Emiliani, un nuovo macello pubblico. La sua facciata imponente, in stile rinascimentale neo-palladiano, spicca sulle altre costruzioni del borgo. Nel Novecento molti lo chiameranno il Norge, forse in omaggio al dirigibile dell’esploratore polare Umberto Nobile (1885-1978), altri semplicemente “al mazel vec” (il macello vecchio). Con la costruzione, tra il 1910 e il 1911, del caseggiato delle “casenuove” (Al Ché Novi) - che il comune di Medicina utilizzerà per ospitare diverse famiglie povere di Portonovo - e lo spostamento del macello in una zona più periferica, anche il Norge sarà trasformato in un condominio popolare, suddiviso in vari appartamenti. Accanto ad esso saranno costruiti i bagni pubblici, importanti per una comunità ancora priva di servizi igienici nelle case. Davanti al palazzo un vasto prato esteso fino alla Strada San Vitale ospiterà di tanto in tanto le attrazioni di un piccolo luna park o il tendone del circo Orfei.dettagli
-
1844Cessa la pubblicazione delle "Effemeridi bolognesi"Cessa la pubblicazione delle Ephemerides motuum coelestium calcolate dall'Osservatorio di Bologna, a lungo il più completo almanacco astronomico disponibile in Europa. Si tratta di tabelle che contengono le coordinate dei corpi celesti calcolate in determinati intervalli di tempo e sono uno strumento fondamentale per le osservazioni astronomiche. La serie moderna delle Effemeridi Bolognesi fu iniziata dall'astronomo Eustachio Manfredi (1674-1739), primo direttore della Specola, e continuata dai suoi successori. Le tavole compilate dalle sue sorelle furono "fra le più estese e complete fra le molte che furono prodotte". Le più antiche, invece, risalgono al 1554 per mano di Nicolò Simi (1530-1564), professore di matematica e astronomia all'Alma Mater, e sono considerate il primo almanacco italiano. Famose sono anche le Effemeridi bolognesi degli astri medicei, con osservazioni sui moti dei satelliti di Giove, pubblicate nel 1668 da Giovanni Domenico Cassini (1625-1712), l'autore della meridiana di San Petronio. Il declino dell'Osservatorio è iniziato dopo la morte di Pietro Caturegli (1786-1833), direttore dal 1815. Il calcolo delle effemeridi - affidata ad astronomi assistenti - è stata l'ultima attività di rilievo fino al 1844. Nel frattempo il prestigio delle Ephemerides Bononienses, che avevano portato la Specola "al più intenso splendore" nel corso del Settecento, è diminuito in seguito allo sviluppo di analoghe pubblicazioni nelle maggiori città europee.dettagli
-
19 gennaio 1844Muore il latinista Filippo SchiassiIl 19 gennaio muore Filippo Schiassi (1764-1844), sacerdote ed ex frate benedettino, grecista, latinista e epigrafista. Assieme a Girolamo Bianconi e Filippo Rocchi sviluppò a Bologna gli studi archeologici. Fu professore di lingua greca, di filosofia e di archeologia all'Alma Mater, di cui fu anche Rettore nel 1813-1814 e dal 1817 al 1824. Nel 1810 aprì il Museo Antiquario dell'Università, erede della Stanza delle Antichità dell'Istituto delle Scienze, e ne curò la guida, pubblicata nel 1814. Dove Schiassi "si mostrò veramente celebre e sovrano" fu nella trattazione delle iscrizioni latine. Le sue epigrafi sulle tombe della Certosa sono raccolte in due volumi con il titolo Specimen Inscriptionvm Coemeterii Bononiensis (1809-1815). Il Lexicon epigraphicum Morcellianum, da lui pubblicato tra il 1835 e il 1838 in tre volumi, è invece una vasta collezione di epigrafi antiche.dettagli
-
22 gennaio 1844Prima sentenza per il moto di SavignoIl tribunale pontificio emette la prima sentenza contro quaranta imputati del moto di Savigno. In marzo vi saranno altri processi e venti persone saranno condannate a morte. Solo sei popolani, però - Giuseppe Govoni, Raffaele Landi, Giuseppe Minghetti, Lodovico Monari, Giuseppe Rabbi e Giuseppe Veronesi - saranno effettivamente giustiziati il 7 maggio a Bologna nel prato di S. Antonio. Gli altri condannati, tra i quali i nobili e i possidenti a capo della rivolta, avranno la pena commutata nel carcere a vita.dettagli
-
6 febbraio 1844Terremoto a Bologna e ModenaAlle 19 e 40 del 6 febbraio un terremoto ondulatorio, con direzione da sud-est a nord-ovest, fa tremare Bologna. La scossa è registrata anche a Modena.dettagli
-
21 febbraio 1844La Società delle miniere solfureeIl 21 febbraio si costituisce la Società delle miniere solfuree di Romagna, con sede a Bologna. La produzione dello zolfo, estratto dai giacimenti presenti nelle valli dei fiumi Savio, Marecchia e Rabbi, passerà da due milioni e mezzo di libbre nel 1854 a quindici milioni e mezzo nel 1855.Lo zolfo di Romagna è migliore di quello siciliano. E' un prodotto importante per l'agricoltura, essendosi estesa la pratica della solforazione delle viti e degli ulivi.Gli imprenditori di questa società, tra essi Gaetano e Camillo Pizzardi, Cristoforo Insom, Gaetano Rasori e Luigi Pizzardi in qualità di gerente, hanno tra i loro obiettivi anche quello di “dirozzare” e indirizzare al bene i figli degli operai, assumendosi l'onere della loro istruzione.E' istituita inoltre una cassa di mutuo soccorso per l'assistenza agli operai infortunati.dettagli
-
17 marzo 1844Le Deputazioni sezionali agrarieIl marchese Luigi Davia propone l'istituzione delle Deputazioni sezionali agrarie sull'esempio della Conferenza Agraria accolta nella sua abitazione dall'agronomo Carlo Berti Pichat. Il loro scopo è "di conoscere e di migliorare la pratica agraria di ciascuna parte della bolognese provincia e di diffondervi le notizie e la istruzione". Il territorio provinciale è suddiviso in 13 sezioni (che in seguito aumenteranno fino a 23). Nel capoluogo di riferimento risiede una deputazione, che si occupa esclusivamente "dello stato della pratica agricoltura nella rispettiva sezione". Le Deputazioni tengono un'adunanza mensile alla quale partecipa una Commissione di sei soci della Società Agraria bolognese. Ogni anno esse inviano alla Società Agraria una sintesi dei propri atti e le memorie e i rapporti letti nelle adunanze mensili. Il progetto delle Deputazioni sezionali sarà approvato pochi mesi dopo dalla Sacra Congregazione degli studi e il 19 giugno 1849 dalla Legazione. Le attività si avvieranno in alcuni casi non senza difficoltà. Già nel 1851 la Commissione incaricata della corrispondenza con le Deputazioni lamenterà che "mentre non poche di quelle corrispondono con esattezza degna di lode al desiderio di questa benemerita Società Agraria, altre rimangono costantemente sorde ad ogni invito, ed ai replicati eccitamenti sin qui avuti".dettagli
-
1 maggio 1844Giuseppe Galletti coinvolto nella "cospirazione romana"Dopo l'intercettazione, da parte della polizia, di alcune lettere e di una cambiale di 700 scudi, raccolti dal Comitato bolognese per finanziare una insurrezione nella capitale, l'avvocato Giuseppe Galletti (1798-1873), uno dei capi del movimento di opposizione liberale, viene arrestato e tradotto dopo pochi giorni a Roma. Contro di lui, contro suo cugino Angelo Rizzoli (1809-1873) e i loro complici romani è celebrato un processo per cospirazione, che li vede sostenere una difesa debole e che si conclude il 21 agosto 1845 con una sentenza severa. Galletti e gli altri capi della rete insurrezionale sono condannati al carcere a vita, pena che l'avvocato bolognese sconterà fino all'amnistia del 1846, concessa da Pio IX ai condannati politici. Dopo la sua liberazione, ricoprirà importanti incarichi governativi e militari sia nei governi laici di Pio IX, che durante la Repubblica Romana.dettagli
-
7 maggio 1844Fucilati a Bologna alcuni condannati per il moto di SavignoNel prato di Sant'Antonio (poi via Castelfidardo) vengono giustiziati sei uomini “compromessi” nei moti mazziniani culminati nello scontro di Savigno del 15 agosto 1843. E' stata decisa la fucilazione alla schiena, considerata “morte esemplare”. Per gli altri condannati a morte l'11 marzo, con sentenza della Commissione straordinaria militare, la pena capitale è commutata nella galera a vita “sotto stretta custodia“, mentre trenta cospiratori di secondo piano devono scontare pene minori. Tutti perdono i beni posseduti fino al momento del reato. Il 26 e 28 giugno saranno emesse altre condanne. Il 16 luglio sarà fucilato Giuseppe Gardenghi, facchino di 24 anni, ritenuto uno dei protagonisti del moto, estradato poco prima dal Ducato di Modena. Le ultime sentenze si avranno il 4 e 5 novembre. In pratica vengono giustiziati solo “poveri diavoli” (Rambaldi), mentre gli ideologi della rivolta, tutti possidenti e benestanti, riescono, grazie alle conoscenze e alle disponibilità economiche, a salvarsi riparando all'estero. Tra i congiurati “di rango” vi sono il marchese Livio Zambeccari, il conte Oreste Biancoli, i marchesi Tanari e Pietramellara, il dott. Gaetano Bottrigari, i fratelli Muratori, tutti emigrati in Francia. Sul muro del convento del Corpus Domini in via Castelfidardo, luogo del martirio dei cospiratori di Savigno, sarà murata una lapide dettata da Enrico Panzacchi.dettagli
-
giugno 1844Felice Orsini rinchiuso a San LeoFelice Orsini (1819-1858), carbonaro e patriota mazziniano, arrestato poco tempo prima a Pesaro, è tradotto in giugno nella fortezza di San Leo, assieme al padre e ai riminesi Andrea Borzatti e Enrico Serpieri. "Posti a cavallo e bene incatenati", i ribelli vengono scortati alla prigione da ventiquattro soldati. L'episodio è ricordato da un dipinto dell'artista riminese Guglielmo Bilancioni (1903). Il comandante fa rinchiudere i prigionieri in una segreta detta Spicco, un ambiente migliore di altri, per aver ospitato un tempo una caserma. Nel suo diario Orsini descrive le celle come "orribili, anguste, con mura spesse più di un metro, e con finestre su tre decimetri di lato". Il patriota romagnolo diventerà universalmente noto per l'attentato all'imperatore Napoleone III, il 14 gennaio 1858, per il quale sarà condannato a morte. Il forte conserva la memoria della prigionia del conte di Cagliostro (1743-1795), famoso avventuriero, massone e cultore di scienze occulte, condannato nel 1791 per eresia e qui rinchiuso fino alla morte, in una cella a pozzetto, senza finestre.dettagli
-
16 giugno 1844La spedizione dei fratelli Bandiera e lo scultore PacchioniCon la meraviglia dell’impresa / con la serena costanza del supplizio / affermarono / di tutte le genti italiche - uno - il pensiero la fede il destino / Giuseppe Pacchioni di Bologna - della spedizione dei Bandiera superstite / fece (Iscrizione sul Monumento ai fratelli Bandiera a Cosenza) I fratelli Attilio ed Emilio Bandiera, ufficiali della marina austriaca conquistati alle idee mazziniane, alla notizia di una sollevazione popolare in Calabria, partono dalla loro base a Corfù. Il 16 giugno sbarcano assieme a diciassette compagni alla foce del fiume Neto, quando oramai la rivolta è conclusa. Decidono di continuare comunque l'impresa, ma vengono traditi dal brigante Pietro Boccheciampe (1814-1887), loro compagno d'avventura. Inseguiti dalle guardie civiche borboniche, sono catturati dopo un conflitto a fuoco alle porte di San Giovanni in Fiore. Assieme ad altri sette compagni sono fucilati nel Vallone di Rovito il 25 luglio. Informato delle esecuzioni mentre è a teatro, il principe Massimo, cardinale delegato di Ravenna, commenta così: "Questa sera si piglia con maggior piacere il gelato!". Davanti alla corte marziale di Cosenza compaiono anche due bolognesi, l'artigiano Tommaso Mazzoli (1823-1852), di venti anni, e lo scultore Giuseppe Pacchioni (1819-1887), di ventisei. Catturato il 23 giugno dalle guardie di San Giovanni in Fiore, Pacchioni viene condannato a prigionia perpetua, assieme a Giovanni Manessi e a Carlo Osmani. Rimarrà in prigione fino al 1848, quando sarà graziato dai Borbone. Sarà di nuovo arrestato a Bologna dopo il tentativo mazziniano del 1853, e rinchiuso nelle carceri dell'Abbadia. Dopo aver rifiutato una proposta di grazia nel 1857, in occasione della visita a Bologna di Pio IX, sarà liberato il 12 giugno 1859 e portato in trionfo dai suoi concittadini. Nel 1878 scolpirà una statua di marmo, denominata Monumento dei Martiri e dedicata ai Fratelli Bandiera, ai loro compagni e ai patrioti cosentini del 14 marzo 1844, che sarà collocata davanti alla Villa Comunale di Cosenza (vedi iscrizione sopra). Sulla sua tomba alla Certosa si leggerà questa epigrafe: “Il Papato il Borbone l'Austria nemici della Patria lo ebbero nemico implacabile. Legò il nome alla spedizione Bandiera. Repubblicano e libero muratore confermò coi fatti i suoi ideali”.dettagli
-
agosto 1844Ritratti in dagherrotipoAnche se solo in forma saltuaria è avviata a Bologna la produzione di ritratti in dagherrotipo, cioè secondo il procedimento fotografico messo a punto nel 1839 dal chimico e fisico francese Louis Daguerre (1787-1851). In agosto opera in città Josephine Dubray, una signorina esperta delle invenzioni più recenti, che si dichiara disposta a dare lezioni ai dilettanti e a vendere una macchina completa per "Daguerotipi". Nel mese di ottobre giunge da Parigi Claude Porraz, che esegue ritratti della famiglia senatoria degli Albergati e viene ospitato nel palazzo di via Saragozza. Anch'egli è disponibile a insegnare "i processi pratici e teorici dell'Arte". Ha una esperienza di tre anni e ha frequentato Daguerre, i famosi ottici Chevalier e Marc Antoine Gaudin, inventore di un nuovo processo di sviluppo. E' in grado, tra l'altro, di applicare il colore ai suoi ritratti, cosa che, però, alcuni giudicano un cedimento a gusti volgari. Le immagini fotografiche ottenute con le tecniche di Daguerre e Niepce non sono riproducibili. Per impedire l'annerimento, le preziose lastre di rame sono di solito conservate sotto vetro, in cofanetti intarsiati.dettagli
-
15 agosto 1844Uragano nel Bolognese e in RomagnaIl pomeriggio del 15 agosto sulle campagne del Bolognese si scatena un “impetuoso uragano” da nord-ovest con grandine, che provoca gravi danni “in molti punti“. La forza del vento è tale che nella fascia di territorio interessata, “di non lieve estensione”, vengono abbattuti alberi “di qualche grossezza”, danneggiati filari di vite e risaie. Lo stesso “flagello” colpisce numerosi paesi della Romagna.dettagli
-
11 settembre 1844Luigi Calori professore di anatomiaLuigi Calori (1807-1896) ottiene la cattedra di Anatomia umana all'Università di Bologna. Nato a San Pietro in Casale, ha conseguito la laurea all'Alma Mater nel 1829, rimanendo poi come assistente e dissettore presso il suo maestro, Francesco Mondini. Nel 1835 ha iniziato a insegnare anatomia pittorica all'Accademia di Belle Arti e da allora si è dedicato all'ampliamento del Museo anatomico, di cui sarà direttore dal 1850. Oltre che insegnante di anatomia per cinquant'anni, sarà preside della facoltà di medicina, rettore dell'Università (1876-77), presidente più volte dell'Accademia delle Scienze e della Società Medico-Chirurgica. Alla morte lascerà un centinaio di pubblicazioni su argomenti di anatomia normale e comparata, teratologia, antropologia e una importante raccolta di oltre duemila crani umani, oggi conservati presso il Museo delle Cere Anatomiche "Luigi Cattaneo". Il comune di San Pietro in Casale gli dedicherà, ancora in vita, una piazza del paese (1875) e metterà una lapide sulla sua casa natale.dettagli
-
19 ottobre 1844L' "Ernani" di Verdi con Nicola IvanoffIl 19 ottobre al Teatro Comunale va in scena la prima bolognese dell'Ernani di Giuseppe Verdi. L'opera segna il ritorno, a grande richiesta, del tenore russo Nicola Ivanoff (1810-1880), protagonista assieme al soprano tedesco Sofia Loewe e al baritono italo-francese Felice Varesi. Cantante protetto da Gioachino Rossini, destinato a divenire bolognese d'adozione, Ivanoff ha fatto furore, nella stagione autunnale 1839 del Comunale, nella Lucia di Lammermoor e nell'Anna Bolena di Donizetti. E' stato, inoltre, grande interprete nello Stabat Mater di Rossini, rappresentato all'Archiginnasio nel 1842. Su richiesta del maestro pesarese, Verdi ha scritto appositamente per lui alcune romanze dell'Ernani e dell'Attila, sostituendo pezzi di minore effetto.dettagli
-
novembre 1844Fanny Cerrito al Teatro ComunaleIn novembre al Teatro Comunale si esibisce la danzatrice Fanny Cerrito (1817-1909). Ha debuttato a Napoli nel 1832 e in seguito ha conquistato i teatri europei. E' prima ballerina all'Her Majesty's Theatre a Londra, favorita del pubblico inglese. E' una ragazza “vezzosa e incantevole, col sorriso d'Amore” e anche a Bologna suscita entusiasmi, che non saranno toccati da altre osannate primedonne della danza, come Fanny Elssler o Maria Taglioni, la sua grande rivale. La sua esibizione produce “un diluvio di poesie encomiastiche e recensioni osannanti su tutta la stampa locale” (Calore). Gaetano Fiori, direttore di “Teatri, Arti e Letteratura”, la presenta come “grazia del Ballo”, “diletta dell'arte”, ora lontana e spirituale, ora “carezzevole amante”. Altri la descrivono come la personificazione "di quel bello, che quando si ammira nelle famose opere dei greci artisti, viene detto ideale". Hans Christian Andersen, nella sua autobiografia, ne parla come di una incarnazione della gioventù, come "il tuffo di una rondine nella danza". Un pasticcere bolognese le dedicherà un dolce speciale: delle meringhe al lattemiele ispirate al suo seno procace, chiamate volgarmente “poppe alla Cerrito”.dettagli
-
3 novembre 1844Le Scuole Tecniche BolognesiIl 3 novembre cominciano i primi corsi delle Scuole Tecniche Bolognesi, fondate grazie ai lasciti di Giovanni Aldini (1762-1834) e Luigi Valeriani (1757-1828). Loro intenzione era istituire "una Scuola di disegno dedicato alle arti e mestieri meccanici, con premio di più medaglie di argento e d'oro ogni anno ai più meritevoli allievi, e non nel solo mero disegno, ma eziandio nella pratica presso i più reputati maestri meccanici, sotto l'ispezione di più Deputati autorevolissimi dello stesso Consiglio Municipale". Aldini ha lasciato al Comune, oltre a parte delle sue proprietà nel Milanese, una ricca collezione di macchine "all'oggetto di formare e porre in attività un Gabinetto destinato a procurare, specialmente agli artisti, i mezzi di conoscere le principali macchine riguardanti le arti e mestieri". Le Scuole Tecniche impartiscono agli artigiani locali insegnamenti di disegno, fisica, meccanica e chimica. Si tenta di formare costruttori di utensili e macchine dotati, almeno a livello elementare, di un sapere tecnico-scientifico. La carenza di competenze tecniche negli operai e negli imprenditori, la loro incapacità di costruire nuove macchine, ma anche di montare e riparare quelle acquistate all'estero, è vista, assieme alla difficoltà di reperimento di capitali, come uno dei limiti principali alla diffusione delle attività manifatturiere nel territorio bolognese. Le scuole si ispirano all'esperienza francese del Conservatoire des Arts et des Métiers, assunto a modello di istruzione tecnica per gli artigiani. Sono organizzate lezioni con dimostrazioni compiute su modelli. Nel nuovo gabinetto di disegni e oggetti dimostrativi, realizzato per lo svolgimento dei programmi, confluisce anche la collezione Aldini, che però rimarrà praticamente inutilizzata. Le difficoltà di affermazione delle Scuole Tecniche negli anni preunitari saranno dovute soprattutto alla situazione di persistente arretratezza della realtà economico-sociale bolognese. Le scuole saranno chiuse nel 1860. Rimarrà solo il corso di disegno, considerato "fattore fondamentale di comprensione, ideazione e progettazione" dei manufatti. Funzionerà come scuola annessa a quella elementare della città. La loro esperienza riprenderà nel 1878 con la nascita dell'Istituto Aldini Valeriani per le Arti e i Mestieri, comprendente una scuola-officina per le attività pratiche.dettagli
-
4 novembre 1844Ultime sentenze per il moto di SavignoLa Commissione militare, creata a seguito delle cospirazioni e delle azioni di bande armate sugli Appennini nel 1843-44, pronuncia il 4 e 5 novembre le ultime sentenze contro alcuni arrestati, comminando pene tra i 5 e i 15 anni di carcere. Molti dei protagonisti dei moti, come Gaetano Bottrigari (1807-1889), Giovanni Righi de' Lambertini (1800-1870), Livio Zambeccari (1802-1862), Oreste Biancoli (1806-1886), Sebastiano Tanari (1814-1881), Pietro Vassé Pietramellara (1804-1849), hanno da tempo riparato in Francia.dettagli
-
10 novembre 1844Charles Dickens a BolognaNel corso del viaggio che compie in Italia tra il 1844 e il 1845, lo scrittore inglese Charles Dickens (1812-1870) arriva a Bologna, proveniente da Modena, la sera del 10 novembre. Rimane solo una mezza giornata, quanto basta per alcune brevi e incisive impressioni, che lascerà nel libro Pictures from Italy (1846). La città gli appare pervasa da "un non so che di grave e di dotto" e immersa in una piacevole penombra. Tra i numerosi e ricchi edifici rimane particolarmente colpito dalla Certosa, in cui si trova a passeggiare, "tra colonnati e tombe imponenti", assieme a una folla di contadini e con alle costole "un piccolo Cicerone locale", che ha molto a cuore la reputazione del posto e cerca di mostrargli solo i monumenti belli. In questo periodo nel cimitero - divenuto un vero e proprio museo a cielo aperto - opera un custode-dimostratore in uniforme da ufficiale comunale, che ha il compito di accogliere e accompagnare i visitatori. Il lavoro sarà a lungo appannaggio della famiglia Sibaud, di origine francese.dettagli
-
11 dicembre 1844Una copiosa nevicataSu Bologna nevica ininterrottamente dall‘8 all‘11 dicembre. Si provvede a scaricare i tetti delle case, minacciati di crollo. L‘inverno 1844-1845 risulterà tra i più freddi e nevosi della storia. Nel dicembre 1844 nella vicina Modena cadranno oltre due metri di neve, 89 centimetri nella sola nevicata del 14, la più copiosa di sempre.dettagli